Infame è il marchio
Donald J. Trump sa che cosa vuole e chi non vuole sulla sua strada. Vuole un mondo che nessuno si azzardi a pensare come «casa comune» da difendere, da usare e da continuare a costruire
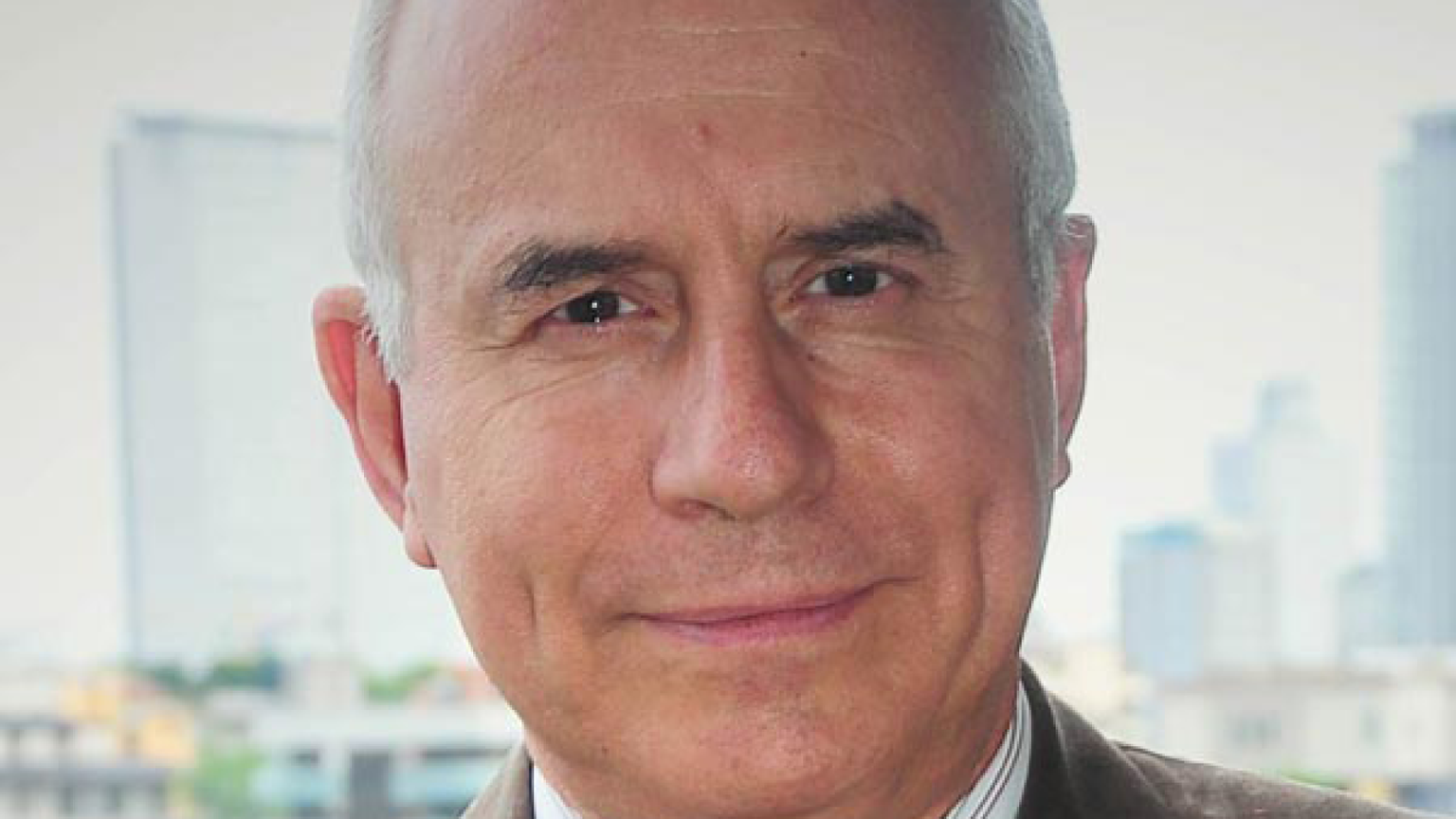
Donald J. Trump sa che cosa vuole e chi non vuole sulla sua strada. Vuole un mondo che nessuno si azzardi a pensare come «casa comune» da difendere, da usare e da continuare a costruire insieme: il grido di battaglia è «ognun per sé», Stati e persone. Non vuole nel suo Paese, costruito dai migranti di tutto il mondo, tutta una serie di persone che considera indesiderabili o, come ha proclamato ieri, «pericolose»: dai rifugiati, lavoratori e persino turisti di religione islamica sunnita e sciita ai migranti latino americani prevalentemente di religione cristiano cattolica (nel primo caso la discriminazione religiosa è esplicita, nel secondo è implicita e si mescola ad altri elementi ugualmente preoccupanti).
Sta decidendo di conseguenza, il nuovo capo della Casa Bianca. Costruisce ogni giorno nuovi "muri", materiali e ideali, commerciali e politici, culturali e religiosi. E si è persuaso che il «prezzo» di tutte queste barriere debba ricadere su quelli dell’«altra parte»: abitanti, emigranti, mercanti, governanti, credenti... Si sbaglia. Non sarà così, e non solo perché nessuno può e deve mettere arrogantemente le mani nelle tasche degli altri, ma perché il prezzo delle ingiustizie, prima o poi, lo pagano tutti non solo i più deboli. Per intanto, però, il presidente Usa tira diritto. Confeziona persino «marchi» d’infamia verso popoli, comunità, etnie e organizzazioni sovrannazionali e li mette in circolazione con la potenza mediatica della parola dell’«uomo più potente del mondo». La questione è gravissima, e costa persino evocarla per gli echi terribili che scatena. Ma è inevitabile.
Certo, potrebbe essere consolante pensare che si tratti solo di un pirotecnico spettacolo d’inizio mandato, ma non lasciano spazio a molte illusioni le aspre "parole di disordine" – protezioniste, anti-umanitarie e contrarie a ogni «concerto delle nazioni» – che Trump continua a lanciare e che si vanno accumulando e insediando nei dibattiti politici non solo d’oltre Atlantico e alimentano i nuovi rivoli d’antagonismo e d’odio che hanno preso a scorrere in ogni dove. Come se non bastassero quelli ingrossati dalla propaganda dei fondamentalisti jihadisti...
È infatti convinto, Trump, di sapere perfettamente l’effetto che tutto questo farà: la "sua" America (che non è tutta l’America, ma nel Nuovo Mondo è dominante da circa due secoli) sarà più che mai "prima" a livello globale: più ricca, più forte, più sicura. Fiat "great America" et pereat mundus. Si sbaglia ancora una volta. E ce ne accorgeremo tutti, sperabilmente presto. Nessuno si salva da solo, neanche la superpotenza Usa. E non si rimedia ai guasti del lato oscuro della globalizzazione chiudendosi in recinti per (presunti) ricchi e recintando i poveri nelle loro sventure di miseria e di guerra.
Anche nello sviluppato Nord del mondo – negli States come in Italia – i ricchi sono sempre più ricchi e sempre meno numerosi. Mentre nei troppi e derelitti Sud del mondo la caparbia e repulsiva «avarizia» dei pre-potenti di questo passo finirà davvero per suscitare – secondo la profetica constatazione di Paolo VI, scandita mezzo secolo fa nell’enciclica Popolurom Progressio – «il giudizio di Dio e la collera dei poveri».
Non bisogna nominare il nome di Dio invano. E allora è bene tornare su un punto già toccato e che le argomentazioni usate ieri dal presidente Trump per decretare la porta chiusa in faccia per alcuni mesi ai richiedenti asilo, ma anche a lavoratori (addirittura con il permesso permanente, la famosa green card), di fede islamica provenienti da sette Stati, tutti Paesi d’Africa e Asia piagati dalla guerra tranne uno, l’Iran. La cosa che colpisce di più è che colui che è stato eletto a capo della prima e più grande democrazia d’Occidente si sta così mettendo, oggi, su un piano sinora proprio del califfo nero di Raqqa.
Il marchio di identificazione e di rifiuto degli «islamici» idealmente impresso per ordine di Trump sul passaporto di una persona in fuga dalla Siria e dall’Iraq o dallo Yemen o dalla Somalia somiglia maledettamente alla «n» araba di nasara, nazzareno, imposta per ordine di al-Baghdadi sulle case dei cristiani di Mosul. Somiglia non è uguale. Perché gli Usa, così, rifiutano accoglienza, aiuto, la possibilità di una nuova vita a coloro che sono costretti a lasciare la propria terra e lo fanno in base a un’appartenenza religiosa di gruppo non a una qualche colpa personale. E perché, invece, nel Siraq sotto il califfato islamico per i cristiani «marchiati» non è più consentita la vecchia vita, e le alternative all’esilio sono la conversione, la sottomissione pagante o la morte. Il significato delle due scelte (quella di Trump provvisoria, quella dei jihadisti strutturale) è però ugualmente devastante.
Se la fede e la cultura di una persona o di un gruppo di persone diventano il motivo di una discriminazione aspra e ingiusta, questo riguarda tutti non solo i direttamente interessati. Se essere musulmano diventa un «marchio» di pericolosità e un peccato civile, se per questo la condizione di persecuzione e di miseria di un essere umano diventano irrilevanti, nessuno è salvo e nessuno è civilmente al sicuro, ma tutti – cristiani, ebrei, buddisti o di ogni altra tradizione e convinzione religiosa e filosofica – siamo in pericolo. Perché se non solo il mondo dei tagliagole, ma anche il mondo che si è costruito sulla cultura dei diritti fondamentali della persona umana diventasse davvero un mondo di esseri «marchiati», che in base a questo possono essere accettati e rifiutati, saremmo a un passo dall’incubo. Un incubo che abbiamo già affrontato e sconfitto. E che è assurdo possa crescere di nuovo a partire dalla «terra della libertà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA







