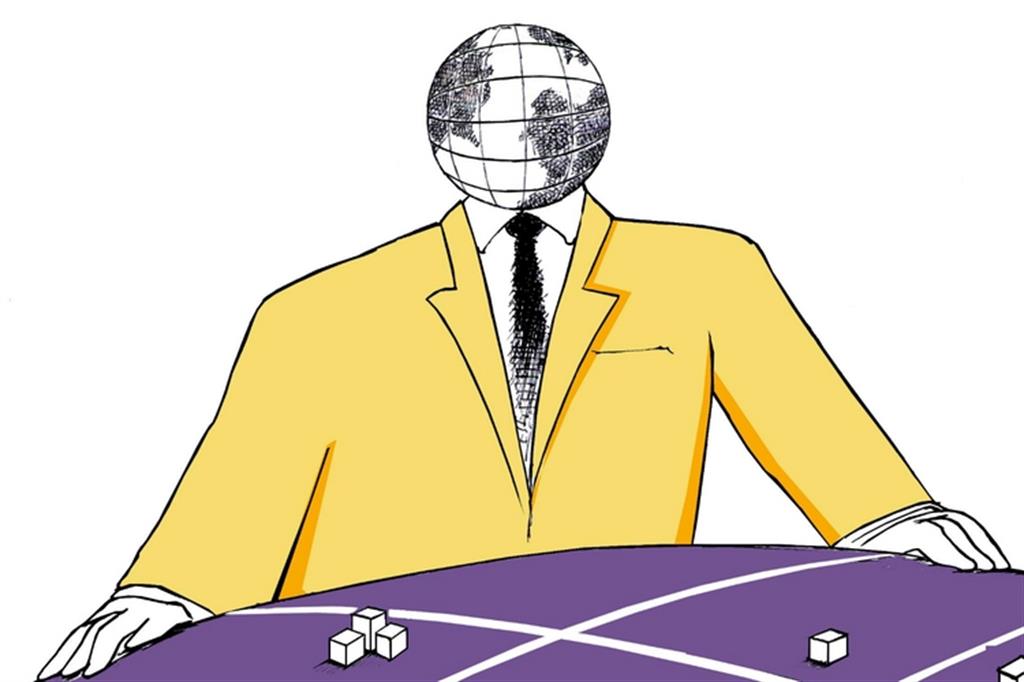
Con i recenti risultati delle elezioni in Italia e in Europa si è tornato a parlare di un fenomeno conosciuto in sociologia con il termine “gentrificazione”, traduzione letterale di gentrification, parola coniata dalla sociologa inglese Ruth Grass nel 1964 per descrivere i mutamenti urbanistici, architettonici e sociali di un’area urbana popolata dalle fasce più fragili della popolazione, sia in termini economici che culturali. L’etimologia del termine deriva dalla parola inglese gentry, ovvero piccola nobiltà, che attraverso l’acquisto di immobili a bassi prezzi in quartieri urbani e meno abbienti, attiva un ricambio urbanistico e culturale dell’area, riqualificandola economicamente e culturalmente, producendo un conseguente lievitare dei prezzi e un graduale ricambio abitativo.
Negli ultimi mesi, il tema della riqualificazione delle periferie è stato al centro del dibattito pubblico, ma quali sono le priorità e come si può investire in maniera sostenibile evitando l’omologazione e una progressiva perdita di identità territoriale? Luca Molinari, docente di Storia dell’Architettura presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, oltre che autore del recente Le case che siamo (Nottetempo, pagine 94, euro 10,00), prova a rispondere: «È evidente che nelle periferie si concentri il malessere di quella parte della società esclusa e meno attiva nella vita sociale, ma bisogna fare attenzione perché il tema delle periferie è un tema su cui si fa sempre molta demagogia. Per prima cosa è necessaria una rottura del sistema tradizionale centro-periferia in una modalità sempre più policentrica e non unidirezionale, nella quale si crei una forma di ascolto e trasfor-mazione che permettano il coinvolgimento.
È necessario lavorare sugli strumenti partecipativi, ma anche su forme di presidio civile per favorire l’accoglienza e rendere le periferie non più come dormitori alienanti, ma come luoghi in cui possa avvenire uno scambio». La riqualificazione urbana, ovviamente, va considerata da diversi punti d’osservazione: come fenomeno sociologico, architettonico, economico e psicologico, perché a mutare non è solo la città, ma chi la abita, soprattutto considerato che l’argomento va ad inserirsi in una più ampia discussione sull’emergenza abitativa. L’impressione generale è che la direzione sia sempre con maggior vigore quella dello sharing economy, di luoghi di lavoro condivisi e partecipazione dei cittadini nel processo di progettazione e costruzione delle esigenze della città: «Le persone – prosegue Molinari – sono sempre meno legate all’idea di possedere, soprattutto i giovani. Tutto ciò cambia inevitabilmente l’idea di pricacy, quindi condivido con la mia comunità temporanea non solo gli spazi, ma anche le esperienze. Un tempo si stabiliva un confine informale più netto, adesso è più facile entrare nelle vite d’altri.
La rivoluzione digitale, inoltre, ha favorito la delocalizzazione, ma è anche un’esigenza antropologica di stare insieme e creare una comunità flessibile basata sul principio di dare e avere, con uno scambio di tempo e servizi. Così muta la scenografia anche per gli uffici, luoghi informali colonizzati di volta in volta, che addomestichiamo e nei quali condividiamo cose che prima erano individuali. La partecipazione, quindi, è un bene nella misura in cui il senso di partecipazione comporta un senso di adesione. Se la comunità si attiva e dà senso a un luogo abbandonato, genera un sentimento di appartenenza che porterà inevitabilmente alla cura; è questa la ridefinizione, ovvero prenderci cura di un luogo che ci radicherà a sua volta».
È evidente, quindi, che l’Italia stia cambiando, soprattutto in tema di mobilita, avvicinandosi inevitabilmente a forme culturali più dinamiche, per questo motivo è necessario saper gestire il cambiamento sostenendo le fasce più fragili della popolazione in questo processo. Ciò che conta è soprattutto avere un’agenda urbana efficace in merito all’accessibilità e alla vivibilità di insediamento delle grandi aree urbane: «Quello della cura delle fasce più deboli per avere residenze dignitose e non per forza periferiche è un grande tema sociale. Credo ci voglia principalmente inclusione, perché ogni volta che una città alza muri è morta, si impoverisce e genera rabbia». Mantenere vivo il tessuto sociale indipendentemente dal processo di risanamento dei quartieri, però, richiede un certo grado di attenzione al rapporto tra economia e spazi. Giovanni Semi, docente di Sociologia delle Culture Urbane all’Università di Torino e autore del volume Gentrification. Tutte le città come Disneyland? (il Mulino) spiega che spesso il processo di riqualificazione si occupa del quartiere e non degli effetti: «C’è un problema di ottica: se punto i fari sui centri che risorgono sto mettendo ombra sulle periferie e sulle aree che ricevono gli 'scarti' del processo di risanamento.
Quando gli esseri umani si spostano, si ledono relazioni sociali e si perdono attività lavorative. Queste conseguenze non devono portare a ricercare un immobilismo urbano, però è vero che molto spesso per come vengono raccontate le riqualificazioni c’è un apparato retorico che non tiene pienamente conto della vulnerabilità delle fasce più deboli e di come la trasformazione incida ad esempio sul ricambio di attività commerciali. Per questa ragione è fondamentale che le amministrazioni pongano grande attenzione all’accompagnamento delle trasformazioni, cercando di non spaccare la cittadinanza, lasciando per esempio che una parte della popolazione venga inevitabilmente isolata; in un’area in cui ci sono quote crescenti di esclusi da diversi ambiti, è normale che alla lunga venga covato del risentimento».
Questa difficoltà influisce ovviamente anche sui comportamenti delle persone, come conferma Marco Costa, Responsabile del Laboratorio di Psicologia Ambientale presso l’Università degli Studi di Bologna: «L’influenza tra ambiente e comportamenti è biunivoca poiché l’uomo è ancora molto ancorato ai luoghi in cui vive. Il sentimento di estraniamento o identità che può creare un territorio varia soprattutto in funzione dell’ambiente urbano. Il senso di appartenenza viene ampliato dal processo motivazionale che si instaura quando le persone si sentono coinvolte nei processi decisionali e sono impegnate nell’avere cura in prima persona delle realizzazioni urbanistiche; l’attaccamento ai luoghi o agli ambienti non è così diverso da quello nei confronti delle persone.
Questo attaccamento è tanto maggiore tanto più le persone rimangono stabili su un territorio; se per questioni lavorative le persone sono costrette a muoversi, può avere alcuni aspetti positivi, ma riduce inevitabilmente l’attaccamento». In ultima analisi, è di rilevante importanza l’intervento sul tema della sociologa urbanaIrene Ranaldi, specializzata nella ricerca sul rapporto tra identità locale e mutamento sociale: «Le classi sociali più fragili sono destinate ad una migrazione senza fine. La frammentazione e la precarietà di ogni aspetto della vita ci costringe ad agire la nostra drammatizzazione quotidiana per brevi periodi in molti luoghi frammentati, complice anche l’esplosione delle professioni creative che prescindono dalla presenza in un luogo, ma necessitano solo di testa e wifi.
Si tratta senz’altro di aspetti affascinanti dell’epoca che stiamo vivendo, anche se non credo che alla base ci siano mutazioni di sentimenti umani improntati a una improvvisa volontà di generosa solidarietà; ma appunto, una sorta di resilienza economica che porta molti a mettere insieme le poche briciole possedute da ciascuno in un’epoca selvaggiamente neoliberista ». Restando sul tema, Ranaldi amplia il discorso alle amministrazioni: «Sono favorevole alla progettazione partecipata, ai focus group, alle interviste in profondità sulle esigenze degli abitanti. Ma ad un certo punto gli esperti di una materia devono porre una sintesi e mettersi a lavorare. Altrimenti il processo non avrebbe mai fine».




.png?dt=1735409680626&Width=300)
.png?dt=1735409680626&width=677)











