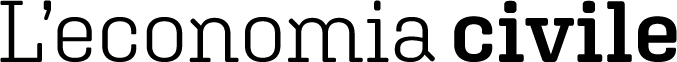undefined - Web
Fino a non molto tempo fa a fumare erano soprattutto gli uomini, il consumo di sigarette tra le donne era piuttosto contenuto. Col passare degli anni questa differenza di genere si è ridotta parecchio, un po’ perché molte più donne fumano rispetto a una volta, un po’ perché anche gli uomini hanno modificato il loro comportamento nei confronti del tabacco. La vera differenza che si nota, invece, è tra classi sociali: oggi a fumare sono prevalentemente le persone con istruzione più bassa o un reddito inferiore.
L’esempio della sigaretta è il più semplice, quasi un classico, per spiegare un altro tipo di trasformazione, quella che riguarda la durata della vita: nei Paesi a bassa mortalità, cioè quelli in cui i progressi economici, sociali e sanitari hanno portato a un aumento complessivo del benessere, e di conseguenza a un allungamento della vita media, a morire prima sono i più poveri. Non è sempre andata in questo modo, nel senso che – proprio come il caso del fumo, o dell’abuso di alcol – per lungo tempo le disparità nella mortalità sono state determinate dal genere, oppure, in contesti come gli Stati Uniti, dal gruppo etnico di appartenenza. Da qualche anno la disuguaglianza nei tassi di mortalità è sempre più una questione legata all’istruzione o al reddito.
Prendiamo l’Italia. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili il tasso di mortalità standardizzato nel 2021 è stato di 131,8 decessi per 10mila residenti. Il dato è però più alto per chi ha solo la licenza elementare (148,6) rispetto ai laureati (108,6), e la differenza è particolarmente marcata nelle fasce centrali di età, tra i 30 e i 69 anni, quelle in cui i decessi sono potenzialmente evitabili. La mortalità tra i meno istruiti è più alta di 1,3 volte rispetto a quella dei laureati. Ovviamente ci sono ancora differenze tra maschi e femmine, come tra Nord e Sud, ma quella tra classi di reddito o di istruzione è la più marcata. Nel 2021 il Covid è stato responsabile del 9,3% della mortalità complessiva in Italia, ma all’interno di questa causa di decessi il dato che riguarda le persone meno istruite è stato molto più alto rispetto a chi aveva un titolo più elevato: superiore del 65% per gli uomini e del 67% per le donne. Quanto si registra in Italia accade in tutti i Paesi ad alto reddito, anche con accenti più marcati, indicando che vi possa essere un legame con l’evoluzione del sistema economico e della cultura che lo caratterizza.
In un articolo pubblicato a fine gennaio sulla Population and developement Review, Isaac Sasson, professore di Sociologia all’università di Tel Aviv, ha sostenuto la necessità che la ricerca demografica indaghi di più attorno alle vere cause delle disuguaglianze sociali nella mortalità. Lo studio evidenzia che dal 1975 a oggi in 23 Paesi a bassa mortalità il divario tra uomini e donne nell’aspettativa di vita alla nascita è sceso in media del 25%, che negli Stati Uniti il divario tra bianchi e neri è diminuito del 52% e i guadagni di longevità hanno riguardato praticamente solo i laureati, mentre in molte nazioni sono cresciute nettamente le differenze legate all’istruzione, al reddito o al lavoro. Tanto che in questi anni si è incominciato a parlare dell’istruzione come di una sorta di «vaccino sociale».
Anche se il 90% delle cause di mortalità può essere attribuito a fattori casuali, il peso crescente della classe sociale nel determinare la durata della vita dovrebbe far riflettere su cosa stia alimentando questo motore di disuguaglianze. Sasson chiama in causa l’ascesa del «capitalismo liberale meritocratico», ovvero la possibile deriva di un sistema economico che negli ultimi anni ha visto aumentare la concentrazione della ricchezza, accentuarsi le disuguaglianze di reddito, diminuire la mobilità intergenerazionale, cioè la possibilità che i figli stiano meglio dei padri. Al di là delle possibili interpretazioni, il problema di fondo è come affrontare la questione in termini di politiche pubbliche, sanitarie ma anche di welfare previdenziale.
La migliore o peggiore salute, così come la durata della vita, dipendono anche da comportamenti individuali, come fumare, bere alcolici, mangiare male o fare poca attività fisica, tuttavia la disperazione a monte di stili di vita autodistruttivi può essere determinata dall’esclusione sociale o lavorativa, mentre l’impatto sulla salute dei lavori usuranti, dello stress per un’esistenza più difficile, il fatto di abitare in contesti più inquinati, o di non poter accedere alle cure perché troppo costose, sono tutti elementi che andrebbero considerati prima di cedere a una lettura meritocratica della longevità. Porre l’attenzione sulle scelte individuali e sulla responsabilità personali può giustificare politiche che legittimano le disparità, anziché preoccuparsi delle cause che le alimentano, soprattutto se le cure sono sempre meno accessibili. Il paese in cui i divari più ampi tra classi sociali quanto a tassi di mortalità sono gli Stati Uniti, ma la tendenza dice che il contagio è in corso da tempo.