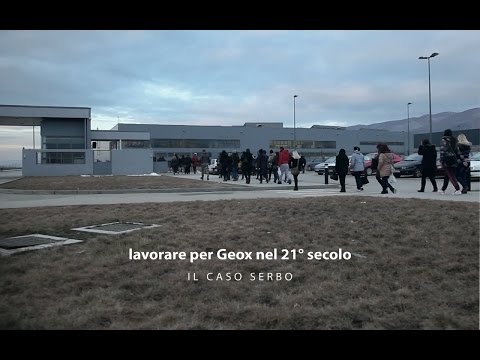
Gli addetti ai lavori lo definiscono reshoring. E’ il trasferimento, in direzione contraria, delle attività produttive che erano state delocalizzate in Estremo oriente e in altri paesi a basso costo di lavoro. I calzaturifici italiani stanno riportando in Europa la produzione perché nei paesi dell’ex patto di Varsavia i salari oggi in alcuni casi sono più bassi che in Asia. Flessibilità sul lavoro, maggiore libertà di licenziamento, salari bassi anche nel Vecchio Continente stanno di nuovo rendendo appetibile la manodopera europea. La definizione Made in EU o Made in Italy suggerisce qualità del prodotto e degli standard di lavoro. Caratteristiche che spesso restano solo sull’etichetta, perché le eleganti scarpe disegnate in Italia vengono poi prodotte in Serbia, Albania (ma anche Birmania e Indonesia) da lavoratori in condizioni miserabili. Oppure in piccoli
laboratori non sempre in regola da parte di “terzisti” in Italia, che pagano stipendi contrattati al di sotto dei contratti di categoria, ma anche della soglia di vivibilità, come in Salento dove 600 euro al mese non è un’eccezione.
E’ l’analisi delle Campagne Abiti Puliti e Change your shoes che lanciano la nuova inchiesta Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive di tre marchi globali delle calzature, realizzata dal Centro Nuovo modello di sviluppo (Cnms) e Fair. Il comparto calzaturiero è uno dei più attivi nel mondo, con 23 miliardi di paia prodotte nel 2015. E un caso esemplare delle
strategie italiane è quello della Geox che, nel gennaio 2016, utilizzando gli oltre 11 milioni di euro messi a disposizione dal governo serbo, ha aperto un impianto di produzione a Vranje, in Serbia. In cambio l’azienda italiana doveva assumere 1.250 lavoratori e pagare salari superiori del 20% a quello minimo legale. Un anno dopo, a dicembre 2016, molti lavoratori serbi lamentavano la
mancata applicazione di quest’ultimo impegno. Le cose sono cambiate quando le proteste dei lavoratori, dei media serbi e le pressioni di Change you shoes hanno spinto l’azienda ad introdurre alcuni correttivi.
Lo schema produttivo più diffuso è quello della filiera mista. La scarpa viene progettata in Italia, la tomaia – cioè la parte superiore - a volte è prodotta nel nostro Paese, il resto e l’assemblaggio avviene all’estero. Geox ad esempio sceglie i cosiddetti terzisti capo filiera, quelli cui l’azienda affida le produzioni che poi spesso vengono di nuovo affidate a subfornitori, solo all’estero. Diverso l’approccio di Tod’s che i terzisti li sceglie prevalentemente in Italia, distribuiti tra Marche, Abruzzo, Puglia. Più alcuni in Romania per la linea Hogan Rebel. Prada fino al 2015 intratteneva rapporti col gruppo cinese Stella International
Holding, che dispone di calzaturifici in Cina, Vietnam, Indonesia e Bangladesh. Con la perdita di competitività dell’Asia però oggi Prada sta tornando a produrre in Italia e nell’Europa dell’Est: Romania, Serbia, Bosnia Erzergovina, ma anche Turchia.
Il marchio e la distribuzione incassano circa il 60% del prezzo finale, il resto è diviso in maniera sempre meno equa scendendo in fondo alla filiera. L’avvocato Eugenio Romano spiega che Tod’s nel Salento, in Puglia, ha praticato «prezzi inferiori almeno del 25% rispetto a quelli praticati per le stesse lavorazioni nei calzaturifici marchigiani». Una precisa scelta commerciale, sostiene l’avvocato, che i vertici aziendali giustificano che nel “tacco d’Italia” le aziende godono della cosiddetta “flessibilità salentina”. «Le aziende che cuciono tomaie a mano per Tod’s - dice il titolare di un azienda – lo fanno fare, spessissimo in nero, nelle case alle operaie espulse dal settore. Il compenso è tra 0,70 e 0,90 centesimi al paio. In 12 ore guadagnano tra i 7 e i 9 euro». Ma c’è di peggio. Nelle Marche ad esempio a luglio 2011 sono stati scoperti solifici che facevano lavorare in nero anche immigrati pakistani e cinesi.
La federazione dei terzisti nel 2013 era arrivata a stipulare con la Cisal un contratto peggiorativo che fissa la paga base di un operaio a 710 euro al mese che, decurtata degli oneri sociali e delle trattenute fiscali (in media il 20%), si riduce a un netto di neanche 600 euro al mese. Somma considerata dall’Istat al di sotto della soglia di povertà. Abiti Puliti e Change your shoes chedono dunque alle grandi aziende del settore di garantire lungo tutta la filiera condizioni di rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza, diritti sindacali. E soprattutto di rendere trasparente la filiera stessa, pubblicandone la tracciabilità: indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi per portare alla luce le aree più opache della produzione.
.jpg?width=300)
.jpg?width=677)













