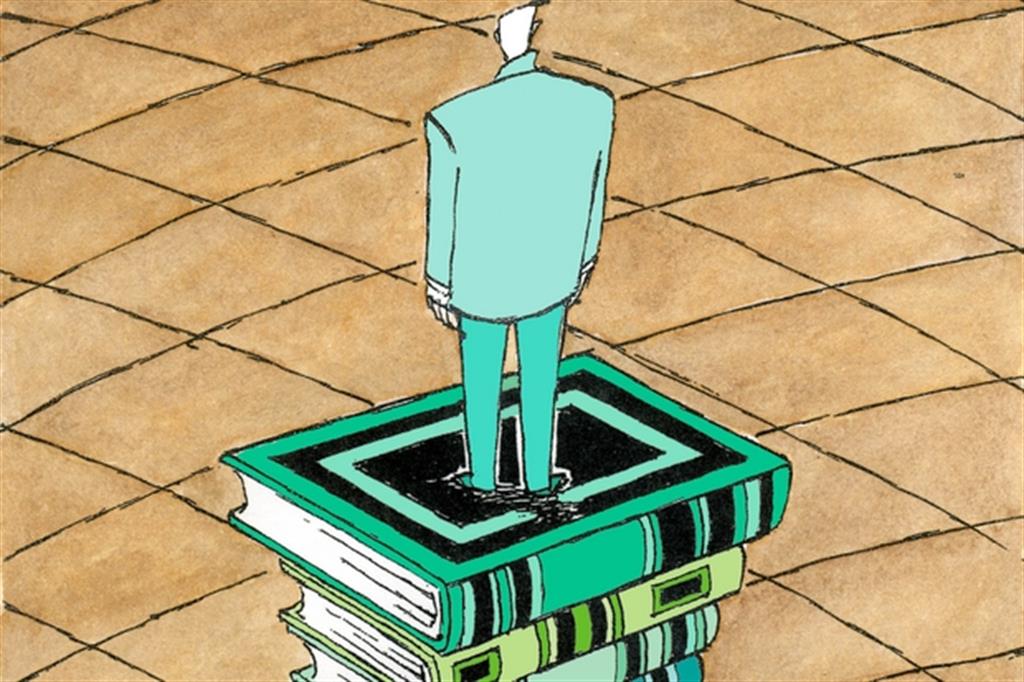
Quando Robert Louis Stevenson, adolescente, lavorava sugli autori più amati (da Orazio a Baudelaire, da Villon a Whitman, da Defoe a Hawthorne, da Keats a Dumas), ripetendo a memoria le loro pagine, riscrivendole, imitandole al punto di scrivere dei “falsi d’autore”, esercitava il talento del futuro scrittore. Che con i suoi capolavori, massimo L’isola del tesoro, vediamo assai distante dagli autori imitati nell’adolescenza. Questa operazione, che fu definita dal Furnas «immersione nella lingua dei suoi predecessori», era l’esercizio per la liberazione della propria originalità. Ogni volta che s’imbatteva in una pagina interessante, la rileggeva e imitava all’infinito. Questo, ricordava, fu più o meno il modo in cui imparò a scrivere. Certo, aggiungeva, non era il modo per essere originali.
Ma originali si nasce, non si diventa. E, concludeva, se si è nati originali, «c’è qualcosa in questo allenamento che libererà le ali dell’originalità». Questa trascrizione significa la ricerca di un collegamento con ciò che sta alle spalle, lo scavo nella tradizione, che corrisponde al lavoro di traduzione: che, in letteratura, è un viaggio, in cui l’autore si avventura. Come insegna Bonnefoy, tradurre è una delle modalità con cui un poeta, uno scrittore, si rapporta con la tradizione, e con i maestri che in essa sta cercando. Su queste pagine Massimiliano Castellani ha messo a fuoco un fenomeno che pare insignificante per la nullezza teorica, ma in realtà preoccupante in una prospettiva antropologica. «La meglio gioventù della narrativa italiana che “non legge i classici”, o rivendica il diritto, sancito da Daniel Pennac, di abbandonarli e non finire il libro», è un fenomeno grave, parallelo, quando non simbiotico, all’autoproclamazione di scrittori e poeti sui propri blog, nel delirio che investe questa realtà in teoria utile, in realtà degenerata. Una volta a sparare cretinate erano i tifosi del Bar Sport, che spiegavano convinti gli errori di Lippi, di Capello, di Ancelotti. Ma va detto che, pur esemplari da Bar Sport, capivano qualcosa di calcio, grazie ai quotidiani e alla televisione. Ora proliferano scrittori che non hanno cognizione di letteratura nemmeno virtuale, e ne proclamano i nuovi fondamenti. Siamo abituati a simili imprese da parte di Aristotele, Dante, Shelley, Eliot, e loro colleghi a noi contemporanei. La letteratura non è un mondo, è una versione, in quanto un’anima fondante, del mondo. Nel quale puoi trovare sorsi di felicità o abissi d’angoscia. Cercando, nel loro contrasto e limine, vita e conoscenza. Se ti pesa, come all’indolente figlio di papà pesa studiare storia perché la professoressa non è comprensiva con le sue fregole, lascia perdere. È un lavoro serio e duro, agognante la gioia, per travaglio e agone, per aspera ad astra.
Lo scrittore spesso contrasta la letteratura dominante del suo tempo. È critico verso certi modelli riconosciuti che non lo soddisfano. Io lo sono stato, negli anni Ottanta, contro un cerebralismo eccessivo e per il recupero dell’anima. Lo sono ancora. Ci sono scrittori fondamentali per la modernità che, pur riconoscendo, non amo: Proust, Joyce. Non li amo avendoli attraversati e avendo trovato piste che mi parevano più affini alla mia costellazione. Ma se non li avessi letti non avrei una coscienza complessa della letteratura della mia epoca: la cognizione del tempo in Proust è stata importante per Luzi, è centrale per Attilio Bertolucci, per Lalla Romano. L’Ulisse di Joyce, scrissi quindici anni fa, è stato a mio parere sopravvalutato, ma posso permettermi questa opinione conoscendolo, e avendo tradotto, in parte, l’“originale” di Omero, a cui mi dedico dalla pubertà. E quindi quando ritengo più omerico l’Omeros di Derek Walcott, o le poesie ulissiche di Wole Soyinka, ho diritto di parola. Tra l’altro, senza il da me non amato Ulisse di Joyce, non sarebbe nata qual è la prosa di Wole Soyinka, il grande scrittore africano che scelse la lingua inglese per ricrearla, e lo fece, anche grazie a movimenti e impulsi linguistici che trovò in Joyce. Il grande Yeats cercava (e trovò) una poesia più vicina alla sua anima originaria e perdurante per millenni (passando dai modelli di Shakespeare a quelli di Dante, fondendoli), perennemente interrogandosi sulla letteratura del suo tempo e del suo recente passato. «La nostra speranza moderna », per la quale si è rivenuta «la gentile, la sensibile mente », ha però perso «l’antica scioltezza della mano», creando il rischio di poeti malati di razionalità, “critici”, «creatori a metà,/ timidi, aggrovigliati, vuoti e confusi». Non rifugge dal suo tempo, che dura da almeno un secolo e si protrarrà per tutto il Novecento, vi attinge e inappagato cerca una nuova via.
Mario Luzi traversa il suo tempo, attinge al canone simbolista che teorizza in un’antologia esemplare, e continuamente, confrontandosi con i suoi contemporanei e con i maestri alle spalle, da Eliot a Montale a Campana a Pound, critica una disanimazione nella poesia del Novecento. «Spesso il poeta di quel secolo non ha proposto nulla perché non desiderava nulla… È come se la sua anima si fosse moltiplicata e dispersa. Se adesso ci ripenso un po’ a posteriori, è perché il Novecento è stato un po’ il mio secolo, ci sono dentro, e mi accorgo che anche quei poeti che amiamo sono spesso di un’umanità rinunciataria, afflitta e rassegnata. Credo che l’ultimo poeta pieno, nel senso di vita e anima, sia Rilke». Nel presente, nel suo divenire, nutrito dal passato. Il poeta si forma nel suo tempo, all’ombra dei classici. «Un classico non appare se non quando una lingua e una letteratura sono mature, e la sua deve essere l’opera di una mente matura », scrive Eliot in Che cosa è un classico?. Poi ogni modello ci può ammaliare o lasciare indifferenti pur se ammirati: ma è lì, resta, lo dobbiamo guardare. Per trovare la nostra via. Che per uno scrittore non è mai una sua esclusiva invenzione, ma la scoperta di una rotta, di una costellazione.
















.jpg?dt=1734709380762&Width=300)
.jpg?dt=1734709380762&width=677)