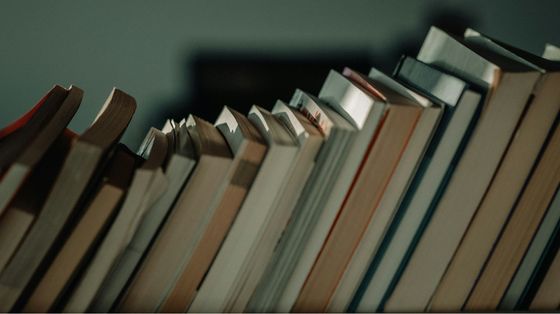Pace ed Europa: così Paolo VI fu ispirato dal sogno di san Benedetto
A Montecassino sessant’anni fa la proclamazione del padre del monachesimo come patrono del continente da parte del Pontefice che sin da giovane aveva fatto sua la spiritualità benedettina

Sessant’anni fa, il 24 ottobre 1964, Paolo VI, di cui si celebra oggi come ogni 29 maggio la memoria liturgica, consacrò la chiesa dell’Abbazia di Montecassino, ricostruita dopo il devastante bombardamento che l’aveva drammaticamente rasa al suolo vent’anni prima, il 15 febbraio del 1944, e sulle cui rovine infuriarono per mesi le battaglie, ricordate nei giorni scorsi anche da papa Francesco con un messaggio. Dall’antica Abbazia fondata da san Benedetto, che proprio in quella circostanza Paolo VI, con la lettera apostolica Pacis Nuntius, proclamò patrono principale dell’Europa, il Papa lanciò il suo accorato appello alla pace e alla cessazione di tutte le guerre. «Così celebriamo la pace. Vogliamo qui, quasi simbolicamente, segnare l’epilogo della guerra; Dio voglia: di tutte le guerre! Qui vogliamo convertire “le spade in vomeri e le lance in falci” (Is 2, 4); le immense energie, cioè, impiegate dalle armi a uccidere e a distruggere, devolvere a vivificare e a costruire; e per giungere a tanto, qui vogliamo rigenerare nel perdono la fratellanza degli uomini, qui abdicare la mentalità che nell’odio, nell’orgoglio e nell’invidia prepara la guerra, e sostituirla col proposito e con la speranza della concordia e della collaborazione; qui disposare alla pace cristiana la libertà e l’amore. La lampada della fraternità abbia sempre a Montecassino il suo lume pio ed ardente». In quella «fortezza non delle armi, ma dello spirito», risorta dalle macerie della guerra, Paolo VI espresse l’auspicio che la società europea delle nazioni potesse attingere «linfa nuova alle radici, donde trasse il suo vigore ed il suo splendore, le radici cristiane, che san Benedetto per tanta parte le diede e del suo spirito alimentò».
All’Abbazia di Montecassino Montini fu particolarmente legato fin dai suoi anni giovanili e la spiritualità benedettina esercitò sempre una suggestiva influenza sul suo animo. Infatti i primi segni della vocazione al sacerdozio furono legati proprio all’assidua frequentazione avuta dal futuro Pontefice con una comunità di monaci benedettini di Marsiglia che, esule dal 1910 a causa della legislazione soppressiva francese, fu ospitata in un convento a Chiari, nel Bresciano, fino al 1922. Spesso unico ospite, da ragazzo Montini assisteva alle cerimonie liturgiche di questa piccola comunità, attratto da quelle «armonie che sembravano essere colloquio tra cielo e terra». «Questa impressione – confiderà, anni dopo, Paolo VI – che la preghiera fatta direi per se stessa e da nessuno ascoltata e condivisa, se non da quelli stessi che la proferivano e dal cielo cui era rivolta, fu scolpita nella mia anima, ancora molto giovanile, e rimase uno degli argomenti, uno dei motivi, per cui mi fu caro dare la mia vita al servizio del Signore». In questo ambiente il giovane Montini che, all’insaputa dei suoi stessi familiari, già nel 1913 stava maturando la sua vocazione sacerdotale, espresse il desiderio di diventare monaco benedettino all’abate della comunità, il quale, con lungimiranza e sguardo profetico, scorgendo in lui un «temperamento attivo» e inadatto alla vita claustrale, lo dissuase. Nel 1919, partecipando a un convegno della Fuci nell’Abbazia di Montecassino, Montini considerò che «dopo Roma, per noi credo non ci sia santuario ove più il sentimento della tradizione cristiana c’investa più fortemente e ci renda naturale la smania di non esserne indegni, ma d’esserne umili, oscuri anche, e dispersi ma vigili e convinti continuatori». Quello «spirito benedettino», nel quale ampiamente si ritrovava, «domina direi quasi aristocratico – annotava da Montecassino – nella liturgia perfetta nell’esclusione di tutto quello che noi aggiungiamo al culto di iperbolico e di artificiale, perché tutto è squisito, preciso, perfetto».
Ai “ritiri minimi” che Montini, assistente Fuci,
organizzava per i giovani a Roma
nell’abbazia di San Paolo fuori le Mura,
guidata da Ildefondo Schuster,
si presentava anche il poeta Trilussa
Divenuto prete, raccontò a uno dei monaci di Chiari di aver passato il 29 maggio 1920, «il giorno solenne» dell’ordinazione sacerdotale, «nella pace tranquilla e superiore che exsuperat omnes sensus e che l’augurio benedettino ripete con cristiana saggezza». Qualche anno più tardi, visitando Subiaco nel maggio del 1923, Giovanni Battista scrisse al fratello Lodovico che «la meta non fu inferiore all’attesa». L’ascetismo benedettino, la sua «perseverante preghiera» e la sua «suggestiva e ingenua tranquillità» stavano «ormai come sogno, come tipo di rinnovamento, nel cuore delle nuove generazioni pensanti e credenti ». E proprio a Subiaco Montini volle tornare mezzo secolo dopo, l’8 settembre 1971, da Papa, in un singolare “pellegrinaggio” compiuto per invocare la protezione e l’assistenza di san Benedetto e chiedere preghiere, in vista del Sinodo che sarebbe cominciato poche settimane dopo.
Da assistente ecclesiastico del circolo romano della Fuci, don Montini – che spiegava la liturgia domenicale avvalendosi dei Messalini dell’abate e liturgista di Subiaco Emanuele Caronti – sperimentò con gli universitari romani l’esperienza dei cosiddetti “ritiri minimi”, momenti di meditazione interiore e di conferma e riaffermazione della propria fede. Come luogo dei ritiri il futuro Papa scelse l’abbazia benedettina di San Paolo fuori le Mura, che, nella Roma del 1923, era circondata dalla campagna verdeggiante, lontana dal rumore della città che ancora non l’aveva inglobata. Piccoli gruppi di fucini si recavano insieme a lui nel monastero e, in una delle cappelle interne all’abbazia, venivano ascoltate le riflessioni proposte da don Montini. Talvolta i giovani non si trovavano da soli, ma c’erano altri ospiti in cerca di un ristoro spirituale: «Io vidi – testimoniava Federico Alessandrini, che a quel tempo era impegnato al fianco di Montini nella Fuci romana e nazionale – inginocchiato con la testa fra le mani, in quella grande cappella, il poeta romanesco Trilussa». Ai ritiri gli universitari erano accolti dall’abate benedettino, che era allora il futuro cardinale e arcivescovo di Milano Alfredo Ildefonso Schuster. «Nessuno di noi – riferì Alessandrini ricordando anni dopo quei momenti – avrebbe pensato di assistere al dialogo di due futuri arcivescovi di Milano».
Lo stesso Montini, diventato pastore della Chiesa ambrosiana, si definì «non pur successore, ma quasi discepolo del cardinale Schuster», al quale si sentì legato da «devozione» e «amicizia » fin da quando, agli albori del suo sacerdozio, aveva lui stesso partecipato a un ritiro predicato a San Paolo proprio dall’abate Schuster che «poi sempre, seppur non frequentemente, fedelmente però, mi fece godere della sua confidenza». Il monaco Aureli Escarré, abate del monastero benedettino di Monserrat, in Catalogna, scriverà nel marzo del 1956 al presule ambrosiano che sembrava riverberarsi in lui «quella soave carità che si irradiava dall’anima santa di Sua Eminenza il cardinale Schuster ». Forse fu anche la spiritualità benedettina sbocciata nei monasteri, edificati spesso sulle alture dei monti, a orientare Montini nell’indicazione di un motto episcopale quando, dopo la nomina del novembre 1954, il nuovo arcivescovo di Milano, che aveva nel suo stemma anche una montagna a sei cime, indicò il versetto Cum ipso in monte (tratto dalla liturgia della Trasfigurazione, solennità che si celebra il 6 agosto, proprio il giorno nel quale, nel 1978, morirà Paolo VI). Tale espressione, che sembrava più appropriata per un intento di vita monastica e contemplativa, ai suoi collaboratori non parve adatta alla missione pastorale dell’arcivescovo della più grande metropoli italiana, e pertanto Montini scelse infine come motto In nomine Domini.
Anche negli anni dell’episcopato, così come aveva fatto in gioventù, il futuro Papa trascorse parte delle sue vacanze estive in alcuni monasteri benedettini, quasi disegnando le tappe di una singolare “geografia spirituale” ispirata al carisma di san Benedetto. Montini fu infatti ospite nei monasteri svizzeri di Einsiedeln, Engelberg, San Gallo, Saint-Maurice, Sarnen e si recò anche presso quelli tedeschi di Maria Laach e Beuron. Pur essendo stato più volte invitato dalla comunità monastica di Montserrat, con la quale intratteneva uno scambio epistolare, Montini non si recò mai nell’abbazia catalana, tuttavia mantenne frequenti contatti con l’allora priore di quel monastero, Gabriel Brasó, che apprezzava quale studioso di liturgia e autore di un volume Liturgia e spiritualità, ispirato anche – come confidato da Brasó in una lettera all’allora arcivescovo di Milano – dalle «illuminate dottrine» espresse da Montini «su questi argomenti dalla Segreteria di Stato». Nel 1969 Paolo VI accolse in Vaticano padre Brasó – divenuto presidente della congregazione benedettina sublacense –, chiamato a predicare gli esercizi quaresimali alla Curia romana.
Già nel corso dell’episcopato milanese l’arcivescovo Montini aveva espresso l’auspicio che, «se un giorno l’Europa sarà unita, il Santo di Norcia sarà proclamato patrono dell’Europa, perché tutta l’Europa ha attinto dagli insegnamenti di questo gigante del cristianesimo». Come già indicato, sarebbe stato proprio Montini, un anno dopo la sua elezione al pontificato, a realizzare questo auspicio, recandosi personalmente nell’amata Montecassino, riedificata sulle rovine belliche del 1944, che apparve a Paolo VI come il «trofeo di tutta l’immane fatica compiuta dal popolo italiano» per la ricostruzione del Paese «terribilmente straziato» dalla guerra. E dalla Montecassino risorta, che nell’edificio materiale trova la sede e il simbolo della sua irradiazione spirituale, il Papa invocò per la «nostra vecchia e sempre vitale società» il ritorno alla fede, che l’ordine benedettino diffuse «nella famiglia dei popoli», e l’unità, a cui san Benedetto, «il grande Monaco solitario e sociale ci educò fratelli».
© RIPRODUZIONE RISERVATA