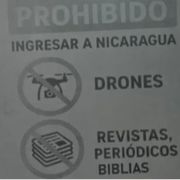«Ho ritrovato tutti i ragazzi portati via», speranza nell’inferno di Kherson
di Nello Scavo
Volodymyr Sahaidak aveva già salvato 52 bambini dalla deportazione. Altri 15 erano stati trasferiti in Crimea: ora stanno rientrando in Ucraina

È al tramonto che il tiro si fa più intenso. La guerra che svanisce dai media, a Kherson è quella di sempre. Anche peggio. Ogni boato, una spallata d’aria che butta giù anche gli stormi in cerca di piccoli pesci sul grande fiume. Non ci sono veri rifugi, solo qualche scantinato. Alcune volte fanno da riparo, altre diventano una tomba coperta di macerie. Tre morti, ieri. Tutti civili. Volodymyr però sorride. Non per incoscienza. Aveva fatto una promessa. E l’ha mantenuta. È il direttore del centro di accoglienza per ragazzi vulnerabili. Ne aveva salvati 52 dalla deportazione. Altri 15, portati dai russi e tenuti in un’ala separata, non era riuscito a nasconderli. All’inizio di luglio era venuto nella redazione di Avvenire. «Li troverò», disse. Lo ha fatto. Lo annuncia mentre percorriamo le stanze con i letti vuoti, le pareti con i disegni dei bambini, le altalene vuote spinte dallo spostamento d’aria. «Siamo riusciti a far trasferire quei 15 bambini dalla Crimea alla Russia e con un pretesto dalla Russia alla Georgia, dove i diplomatici sul posto hanno organizzato il rimpatrio».

In alto i droni ronzano minacciosi sulle nostre teste. Il parco giochi abbandonato, il campetto da calcio con le reti smagliate. Chissà perché dall’alto vengono a rovistare qui. «Trasmettono le posizioni ai russi», dice Volodymyr Sahaidak che da Kherson se n’era andato solo dopo che era riuscito a far fuggire nei territori controllati dagli ucraini l’ultimo dei 52 bambini. I droni osservano, poi precipitano all’impazzata. E uccidono. Si sobbalza a ogni deflagrazione. Il tiro dell’artiglieria e quello dei mortai è impreciso e imprevedibile. Un metro più in qua e sei vivo. Oppure giri l’angolo dietro casa e non torni più indietro. Dopo l’alluvione di giugno, quando la distruzione della diga di Khakovka aveva sommerso l’intero distretto fino alle spiagge sul Mar Nero, i russi sono tornati addosso alla riva opposta del Dnepr che taglia in due l’abitato. Piove ogni genere di ordigno: razzi Grad, artiglieria pesante, colpi di mortaio. Cinque boati al minuto, notte e giorno. Più le raffiche dei mitra e i colpi dei cecchini, che possono uccidere anche a oltre due chilometri di distanza. Perciò ci sono ponti che nessuno attraversa più. E famiglie rimaste divise dal 24 marzo 2022, quando i corpi speciali di Mosca presero la città affogando nel sangue le manifestazioni nonvolente.

Ma i bambini di Volodymyr sono tutti vivi, tutti salvi. Ora il direttore ha un solo pensiero: «Fare più bello il nostro centro e ospitare i ragazzi, e se occorre anche le loro famiglie». Lo dice mentre accarezza le foto sull’albero della felicità, dove i volti dei bambini sono appesi ai rami. Malinka, che ha tre anni, Sasha il doppio, e poi i più grandicelli, quelli cresciuti in fretta mentre alla sera, con i russi fuori dal cancello, dovevano incoraggiare i più spaventati. Non c’è retorica nelle parole di Volodymyr. Pensa al futuro ma non riesce a smaltire la rabbia per quella sua collega che sempre a Kherson, nell’altra struttura cittadina, ha consegnato oltre 50 ragazzini ai russi. Su di lei pende un mandato di cattura, ma nessuno sa dov’è. «Probabilmente in Crimea o Russia», ipotizza Volodymyr, mentre sgrana gli occhi azzurri e cerca nei giocattoli abbandonati di fretta la misura per raccontare alla larga dall’odio. Non è facile. Specie quando il rombo dei missili e dei droni dopo una giornata di martellamenti arriva nel buio della sera e non lascia neanche il tempo di supporre da che parte cadrà, chi morirà stavolta. Unica consolazione, sapere che i bambini sono fuori portata e che stanotte non dovranno sentire il frastuono della guerra. Volodymyr dice d’essersi abituato alle deflagrazioni. Ma non ci si abitua mai alla guerra: è solo un modo per non farsi piegare dalla paura.
Quei 15 bambini e portati a Kherson per essere trasferiti in Crimea non è la sola cosa che a Volodymyr fece rabbia in quei giorni. Insieme a un sacerdote aveva deciso di nascondere i più piccoli nei locali attigui di una chiesa. Lì i russi non entravano mai. Ma la responsabile regionale per i diritti dell’infanzia ebbe l’infelice idea di far sapere via Facebook che i minori venivano tenuti al riparo, sotto la custodia di una comunità cristiana. Il giorno dopo i soldati russi li avevano portati via. Prima della guerra la struttura contava 50 dipendenti per 52 bambini. «Adesso siamo rimasti in tre», spiega il direttore. A ciascun collaboratore aveva affidato uno o più bambini per facilitare la fuga oltre le linee russe. Poi finalmente, ci mostra l’elenco. È la “lista di Volodymyr”. Ci sono i nomi dei piccoli, i loro recapiti, le informazioni più delicate sul perché fossero finiti in un centro di riabilitazione psico-sociale. Il dottor Sahaidak la scrisse in ucraino nella speranza che i russi non capissero. «Per loro è peggio di una lingua straniera», dice con un’espressione sorniona. In effetti gli uomini a volto coperto gettarono per aria i libri del doposcuola: «È spazzatura ucraina», urlarono. Ma “la lista” non la capirono. Fuori continua il fracasso. Dobbiamo allontanarci in fretta. Prima, ci mostra un dipinto su una parete. Lo stavano realizzando i ragazzi prima della guerra. È rimasto incompleto. Ci saluta: «La prossima volta lo troverete finito. Sarà bellissimo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA