La nostra impronta sul pianeta: possiamo consumare meno Terra?
Se tutti avessero il nostro stesso stile di vita, avremmo bisogno delle risorse di quasi 2,7 «pianeti»
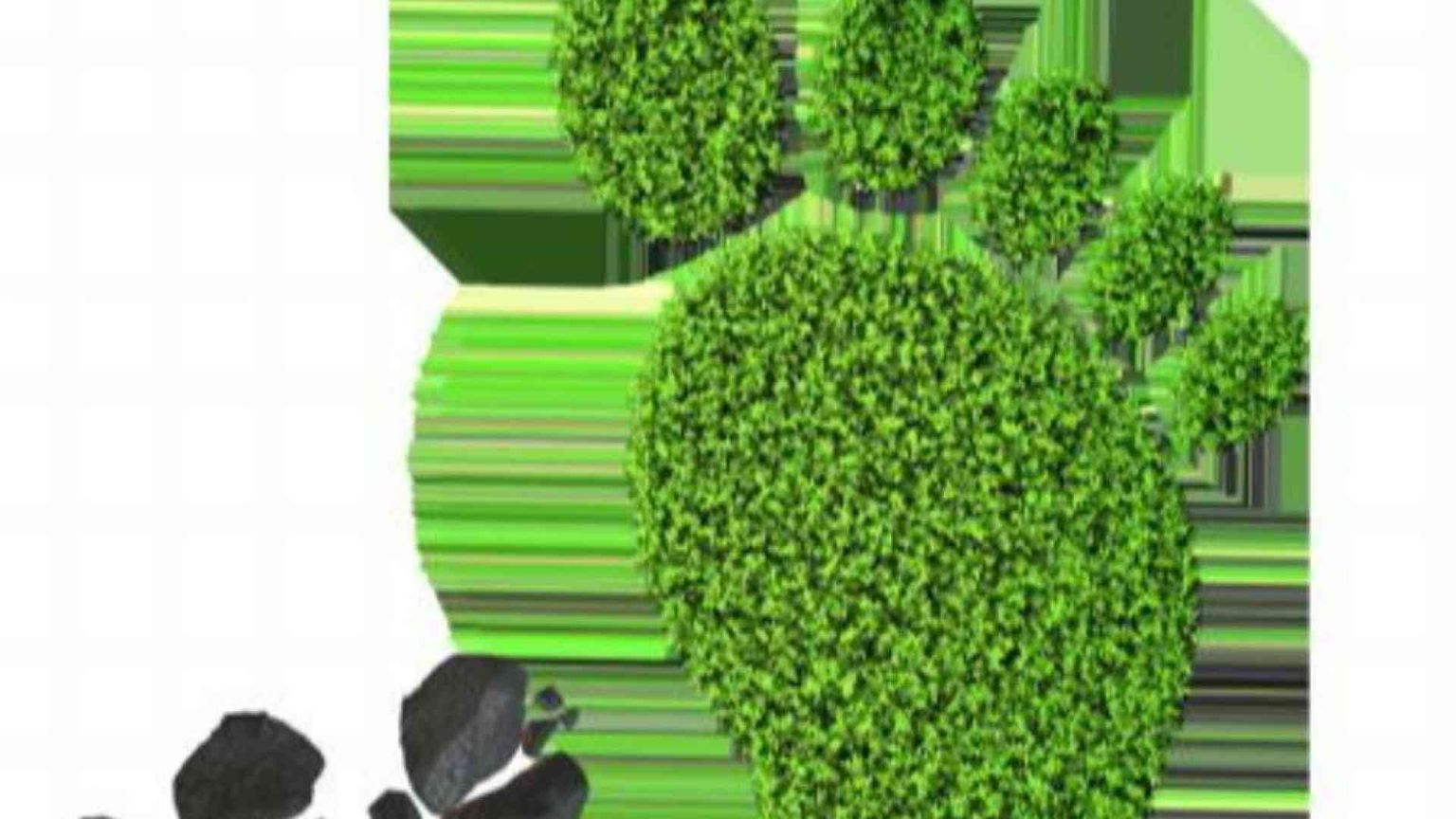
Qual è il nostro impatto sul pianeta? Come è possibile calcolare quante risorse della Terra stiamo utilizzando? E se il consumo fosse eccessivo e di risorse ne fossero rimaste poche a disposizione? Noi quali responsabilità abbiamo nel frenare il cambiamento climatico?
Nel 2012 l’enciclopedia Treccani aveva inserito, tra i termini nuovi, l’«impronta ecologica» che dà la misura del nostro impatto sulla Terra. Ma che cos’è? Per la prima volta nel 1996 usarono questa definizione l’ambientalista svizzero Mathis Wackernagel e l’economista canadese William Rees nel libro Impronta ecologica. Come ridurre l’impatto dell’uomo sulla Terra. Secondo la stessa Treccani, l’impronta ecologica è «l’indice statistico che confronta il consumo umano di risorse naturali di una certa porzione di territorio con la capacità della Terra di rigenerarle, stimando l’area biologicamente produttiva (di mare e di terra) necessaria a rigenerare le risorse consumate e ad assorbirne i rifiuti».
Più semplicemente, la carbon footprint – utilizzando il termine inglese molto diffuso nella comunità scientifica – è quel parametro che ci indica quanta porzione di pianeta consuma una determinata attività, sia essa la produzione di un bene, l’organizzazione di un evento o la vita di un essere umano. È il risultato del rapporto tra quello che consumiamo e le risorse che la Terra riesce a garantire. L’impronta ecologica indica, ad esempio, la superficie coltivabile necessaria per produrre tutti gli alimenti, ma anche la superficie di cui abbiamo bisogno affinché la Terra possa assorbire le sostanze nocive generate durante la produzione di beni, in modo che non creino pericoli per l’uomo. Assieme all’impronta ecologica va dunque considerata la biocapacità di un ambiente: sono considerate «biologicamente produttive» quelle terre e quelle acque utili a produrre biomassa e quindi a rigenerare risorse naturali che nel loro insieme costituiscono, appunto, la biocapacità di un ambiente.
L’unità di misura della carbon footprint è l’ettaro globale (Gha) e il valore ottenuto viene poi confrontato con la superficie effettivamente a disposizione per poter stabilire quanti «pianeti» servirebbero se l’intera popolazione mondiale consumasse le risorse calcolate. Un’impronta si può ritenere sostenibile laddove corrisponda al valore di 1 «pianeta», vale a dire se nell’arco di un anno consumiamo materie prime e produciamo inquinamento in una quantità tale che la Terra riesca a produrre, assorbire. E noi? Domanda cruciale: quanto siamo distanti ancora da comportamenti e pratiche sostenibili che portino a un’efficienza energetica globale? L’impronta ecologica media di un cittadino italiano è pari a circa 4 ettari globali, mentre la biocapacità media dell’Italia è di 1 ettaro globale. Se l’impronta ecologica media di un italiano venisse divisa per la biocapacità media mondiale, cioè la quota di risorse disponibili per ciascun abitante della Terra che equivale a 1,6 ettari globali, il risultato di questa divisione mostrerebbe chiaramente che stiamo consumando troppo. E se tutti avessero il nostro stesso stile di vita, avremmo bisogno delle risorse di quasi 2,7 «pianeti».
Vediamo qualche altro dato. La maggior parte degli scienziati che si occupano di cambiamento climatico ritiene che entro il 2070 gli esseri umani potranno immettere nell’atmosfera solo 1 trilione di tonnellate in più di anidride carbonica se, in termini di riscaldamento globale, si vuole che la Terra rimanga al di sotto dell’obiettivo dei 2°C. Dividendo quel trilione per il numero di anni da qui ad allora e per il numero di persone sul pianeta, si trova un volume di emissioni – circa 2 tonnellate – che un individuo può generare ogni anno senza spingere il pianeta al collasso. Dividendo le emissioni generate in America ogni anno per il numero di americani, si ottengono circa 15 tonnellate a persona. Anche la virtuosa Svezia è a 3,6. Americani e svedesi hanno una certa responsabilità anche per le 8 tonnellate pro capite della Cina, considerato il numero di beni di produzione cinese che acquistano. Solo i Paesi poveri rimangono al di sotto della soglia, mentre la media globale è di 4,7 tonnellate. L’Italia, secondo Eurostat, si attesta a 7,1 tonnellate di CO2 per abitante, al di sotto della media europea (7,8).
È evidente da questi numeri che, seppur non consumiamo tutti allo stesso modo e ci sono Paesi ad altissima impronta ecologica, che usano molte più risorse di quanto ne hanno a disposizione, ad esempio l’Italia, nel complesso il bilancio globale del pianeta rimane, comunque, negativo. Tra i Paesi a minore consumo ci sono quelli africani. Ma il continente africano è anche quello con la crescita demografica più tumultuosa al mondo. E così, nonostante il basso livello di sviluppo di molte aree e la grande disponibilità di risorse, anche l’Africa ha cominciato in anni recenti a consumare di più, in termini di impronta pro capite, rispetto alla propria biocapacità. Ci sono Paesi come lo Zambia o il Mozambico dove l’impronta è molto bassa. E poi c’è la Nigeria la cui impronta ecologica è drammaticamente aumentata negli ultimi 50 anni, passando da 0,84 ettari globali pro capite a 1,07. Contestualmente, grazie all’aumento della popolazione e allo sfruttamento di molte risorse, la biocapacità pro capite è scesa da 1,07 a 0,64.
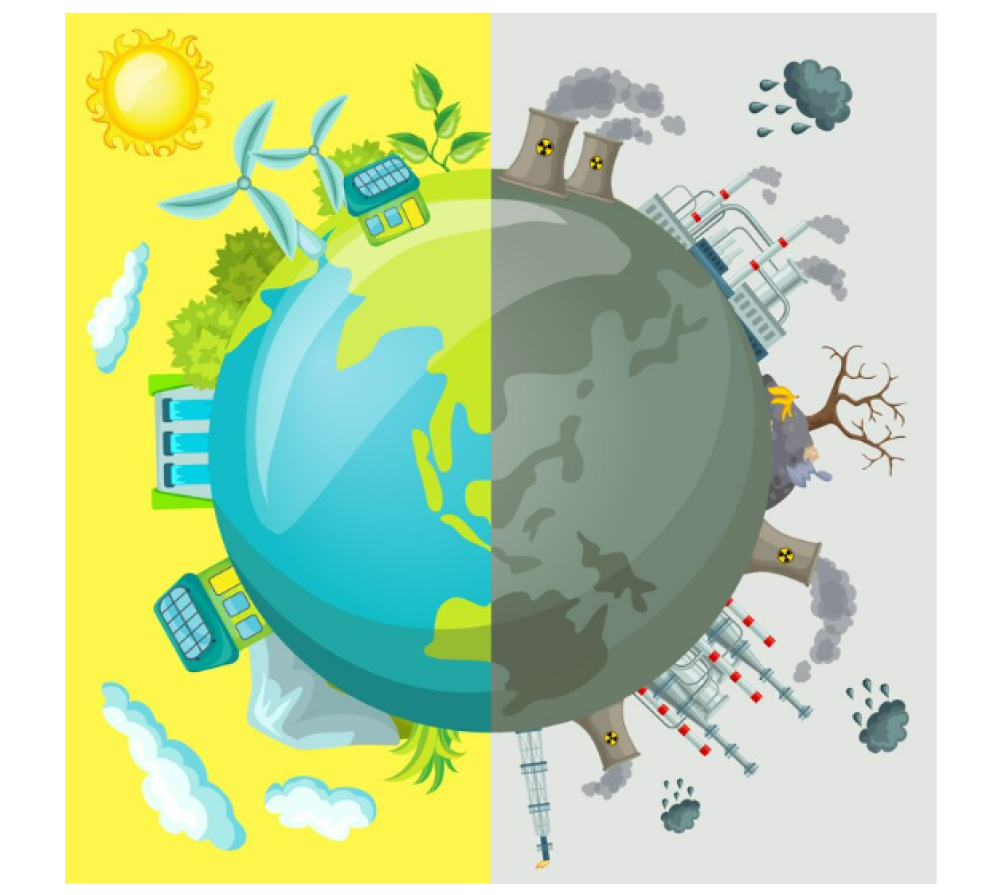
Considerando che ogni attività umana comporta alcune emissioni di gas serra, dobbiamo ritenerci responsabili del cambiamento climatico?
Su questo punto ci sono alcuni studiosi di etica che vanno oltre e sostengono che solo i governi hanno la responsabilità di combattere il cambiamento climatico e che gli individui non dovrebbero sentirsi obbligati a frenare le loro emissioni, oltre gli oneri che i governi impongono loro. Le stime e le ricerche sui danni arrecati dal riscaldamento globale variano ampiamente, certo è che nessuno studio scientifico al mondo li reputa insignificanti; recentemente si è stimato che la crisi climatica potrebbe causare 14,5 milioni di morti entro il 2050, secondo un’analisi del World Economic Forum (Wef). Di fatto, il riscaldamento globale sta già danneggiando i mezzi di sussistenza di molte persone, si pensi ai pastori e gli agricoltori delle regioni più povere del mondo colpiti da alluvioni. E a livelli ancora più estremi, la crescente frequenza e intensità di calamità naturali come siccità, inondazioni, tempeste e ondate di caldo causate dal riscaldamento globale ha già causato la morte di migliaia di persone nel mondo: una tragedia che peggiorerà man mano che la temperatura del pianeta aumenterà. Va ricordato che il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, avvicinandosi alla soglia degli 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale, fissata come limite dall’accordo di Parigi. Quello che però è altrettanto evidente è che gli individui non possono controllare completamente il volume delle emissioni di CO2 che causano.
Nella maggior parte delle società è difficile partecipare alla vita quotidiana senza partecipare ad alcune attività che producono carbonio. Dove i trasporti pubblici funzionano male, è difficile non guidare la propria auto. La maggior parte dei clienti rispetto al consumo dell’elettricità non può scegliere se utilizzare l’energia eolica o il carbone. E dato che pochi supermercati distinguono sistematicamente tra prodotti ad alta intensità di carbonio e prodotti rispettosi del clima, è difficile sapere cosa sia meglio acquistare e questo richiede una quantità di tempo e di attenzione che non tutti hanno a disposizione. Viene da chiedersi, dunque, se sia giusto ritenere i singoli cittadini responsabili delle emissioni, laddove le strutture sociali lasciano poche alternative al causare emissioni. Se i comportamenti individuali sono indubbiamente preziosi sforzi, la questione veramente urgente è spingere i governi a limitare le emissioni molto più severamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







