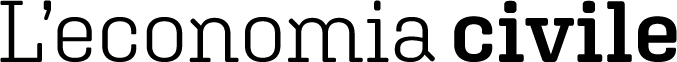.jpg?width=1024)
Donald Trump si prepara a salire sull'Air Force One il 5 aprile del 2025, mentre l'aria dei motori gli scompiglia i capelli - Reuters
«Dio mi ha salvato per uno scopo: rendere il nostro Paese più grande che mai», dichiara Donald Trump commentando l’attentato del luglio 2024 ai propri danni. « Il destino ha voluto così, Dio ha voluto così. Una missione difficile e onorevole, difendere la Russia, è stata posta sulle nostre spalle», dice Vladimir Putin ai generali dell’esercito russo nel febbraio 2025. Due leadership in storica antitesi si trovano all’improvviso appaiate nella ricerca di una contiguità con il divino, nella visione profetica della guida politica, nell’idea del comandante in capo come emanazione diretta del soprannaturale.
Il tratto esoterico del potere, che in Europa abbiamo conosciuto nel secolo scorso, sale per la prima volta sul palcoscenico dell’amministrazione statunitense. Peter Thiel, miliardario investitore della Silicon Valley e intellettuale di riferimento di Trump, recupera il concetto di apocalisse nel significato letterale del termine greco: come disvelamento. Lo fa in un editoriale del 10 gennaio sul Financial Times, la bibbia laica della finanza mondiale. Rimuovere il velo che separa l’uomo dalla verità è concetto caro a Nietzsche e recuperato poi in anni successivi da Heidegger che parlava più specificamente di aletheia, l’identità greca tra i concetti di rivelazione e di verità. Rimuovere quel velo è il compito del nuovo messia. Che poi la verità in questione non investa il senso della vita ma i vaccini anti-Covid, poco importa: quella che può apparire una classe dirigente poco istituzionale e dai modi scomposti radica invece le proprie fondamenta nel pensiero filosofico più raffinato, che da sempre ispira a torto o a ragione le destre più identitarie. L’esoterismo del potere associato alla figura di un solo uomo è tipico dei regimi orientali.
Lo sostenne già Ernst Jünger nel suo saggio Il nodo di Gordio del 1953, in cui la semidivinità dell’intoccabile potere orientale viene contrapposta allo spirito libero d’impostazione occidentale, impegnato a dimostrare con tutte le forze che «il libero governo è superiore ai dispotismi» e che le istituzioni sono ben più sacre rispetto agli uomini e alle donne di potere che ne sono via via i temporanei, mortali custodi. In occidente l’atto di arbitrio – dice Junger – viene considerato una macchia, e anche quando mira al bene «getta un’ombra sull’impresa». Nell’antica Roma il principe riflette la maestà, in oriente la incarna. Da una parte l’uomo è sostituibile, dall’altra è insostituibile.
È dunque l’America, oggi, ad affiancarsi alla concezione del potere di quel levante di cui è stato tradizionale nemico. E l’avvicinamento profondo nell’idea messianica della guida politica non può che sostanziarsi nella ben più superficiale sfera economica: l’imposizione a tappeto di dazi doganali riconduce la potenza trainante della globalizzazione verso una forma di vivere economico in cui la politica va alla ricerca di un nuovo spazio rispetto al mercato. Non lo fa in vista di una maggiore redistribuzione, ma verso un’economia pianificata in salsa occidentale, quella in cui il volto del più forte sveste ogni maschera e si mostra per ciò che davvero è: il martello che batte sull’incudine del debole. Gli equilibri di potere hanno sempre dettato – sarebbe ingenuo nasconderlo – i rapporti economici tra Paesi.
Oggi però il complesso di relazioni tra stati sovrani viene ridotto a mero rapporto di forza, dove l’arma economica è la vecchia tariffa all’importazione, in vista di quell’autosufficienza produttiva rispetto al resto del mondo già ricercata da regimi assai poco democratici, e a noi assai vicini, circa un secolo fa. Mentre dal Rapporto Beveridge alle lezioni oceaniche di Michael Sandel le scienze sociali sostenevano la creazione di modelli di welfare sempre più avanzati, veniva gettato il nuovo seme dell’antica legge della giungla; mentre la teoria economica, da Kahneman a Thaler, faceva passi da gigante verso l’interpretazione psicologica delle scelte di consumo e risparmio, si preparava il ritorno di una mera logica transazionale, in cui ogni concezione dell’economia come applicazione di valori condivisi cade nel vuoto valoriale imposto dallo svilimento delle istituzioni.
Con una mano il messia in arrivo dal mondo degli affari richiama l’economia a un ruolo subalterno alla politica; con l’altra applica proprio alla politica le più elementari regole economiche del dare e dell’avere, riducendo la complessità del mondo a una partita doppia di schematica ispirazione contabile. Le norme valse finora vengono abbandonate, se ne scrivono di nuove, si consolidano le posizioni di forza. Ma gli Stati Uniti sono davvero così dominanti come si pongono nelle negoziazioni internazionali? Scrive Jünger: «Chi rovescia la scacchiera ammette di aver perso la partita, e fa appello a una legge diversa dalle regole del gioco».