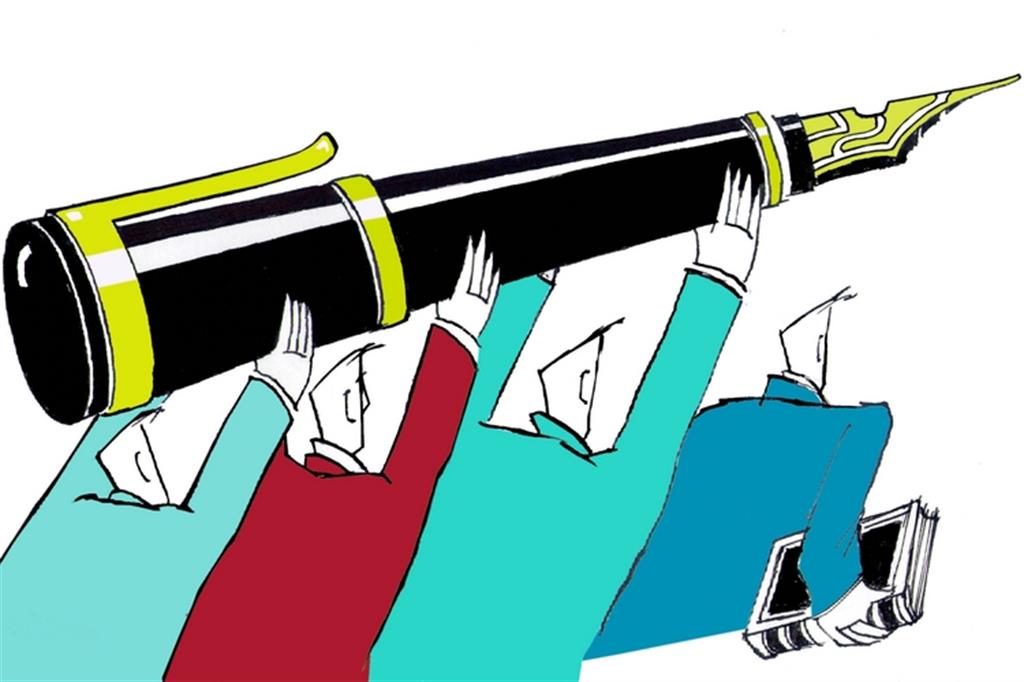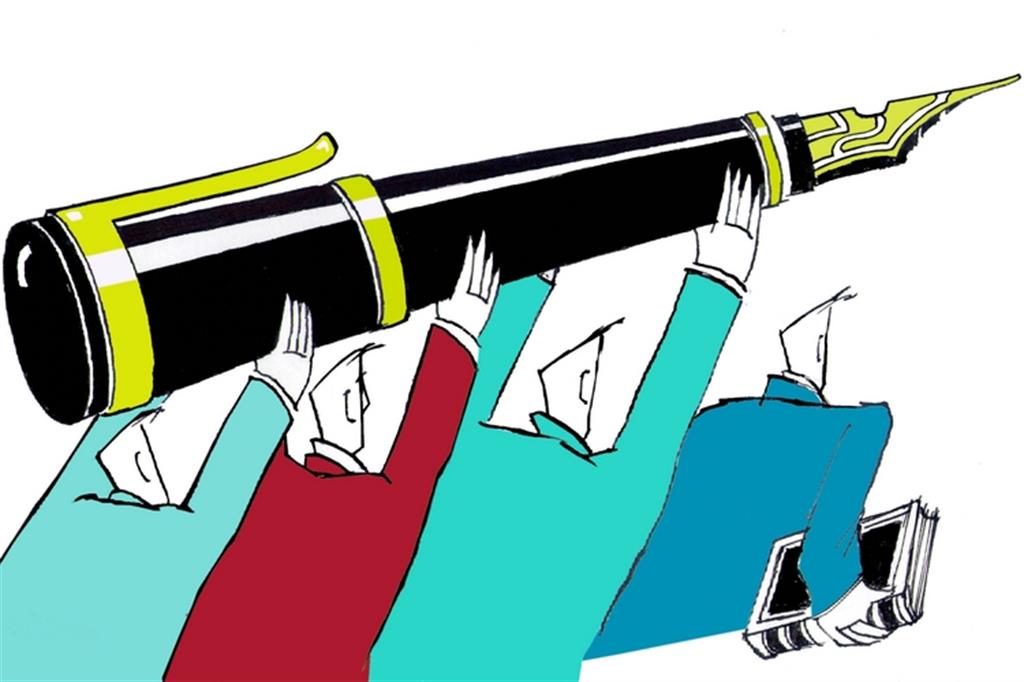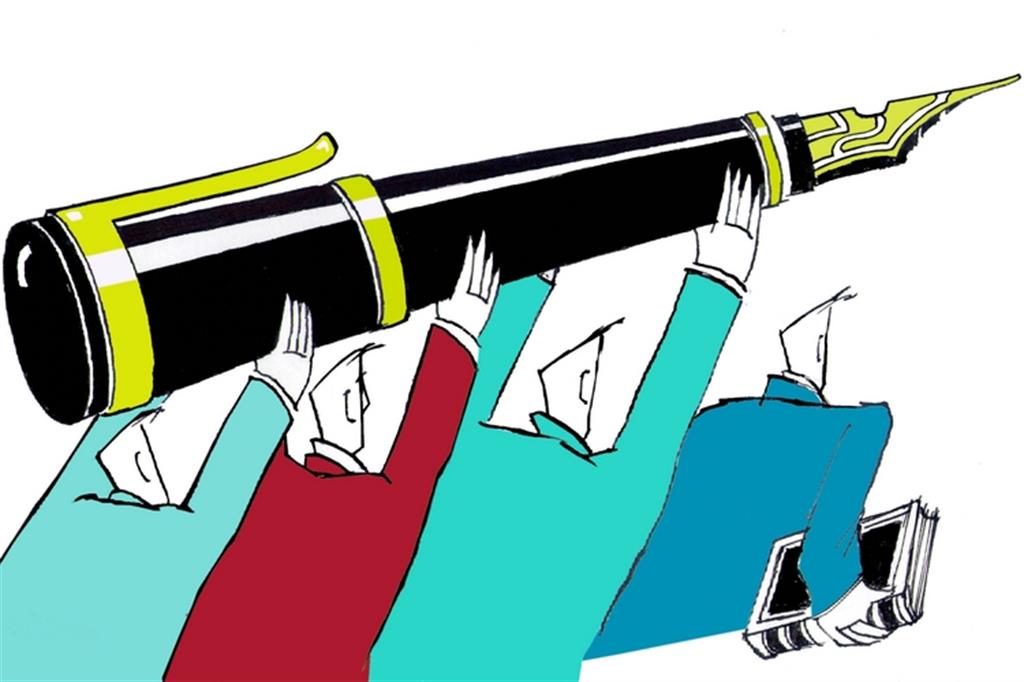Rispetto ai narratori degli ormai troppo mitizzati anni ’80 – quando apparivano sulla scena i vari Pier Vittorio Tondelli, Enrico Palandri, Andrea De Carlo, Ippolita Avalli, inaugurando quella che sarebbe stata subito salutata, con una certa euforia, come la nuova narrativa italiana – di che specie sono gli esordienti di oggi? Che idea di romanzo propongono? Che scrittura praticano?Io partirei da qui, dalla fascetta promozionale per il primo libro della siciliana Carmela Scotti,
L’imperfetta (Garzanti), già finalista al Premio Calvino, firmata da Carmen Pellegrino, anche lei esordiente lo scorso anno con
Cade la terra (Giunti), ma ormai celebrata sulle pagine dei giornali e sui social network. Scrive Pellegrino: «L’esordio fulminante di una voce arcaica eppure così nuova, che affila tutte le parole per una via di salvezza. Echi di Elettra e di Antigone risuonano nell’Imperfetta. Una storia che ci riguarda tutti». Ove non sfuggirà il rilievo dato all’aggettivo arcaico (per una lingua culta e ricercata, carica di echi, sostanzialmente anti-comunicativa) e al sostantivo salvezza (in merito a una scrittura che riscatta e redime). Carmen Pellegrino, per essere più chiari, è la narratrice dei paesi estinti o in via di estinzione, che s’è inventata il termine di “abbandonologa”, in vista d’una insolita e inedita disciplina, già registrato dalla Treccani, per dire di chi va «alla ricerca di borghi abbandonati, edifici pubblici e privati in rovina (…), di cui documentare l’esistenza e studiare la storia». Una giovane donna, Pellegrino, la quale, però, sembra arrivare da un altro tempo e aver letto tutti i libri, lavora sulla prosodia e sul lessico come nessun coetaneo saprebbe fare, e rastrema la lingua con una consapevolezza e una maturità che lascia stupiti. Niente di sorprendente allora che la Scotti (o il suo editore), abbiano chiesto proprio a lei di fare da madrina a un romanzo, come
L’imperfetta, che va in una direzione analoga, concentratissimo su ritmo, poeticità della parola e azzardo metaforico. Così Scotti, per definire la vita della protagonista Catena, in seguito alla morte dell’amatissimo padre: «Dopo è stato solo un precipizio, un tempo spaccato, come il fuoco d’artificio nella notte, in mille pezzi e poi più niente».Quella di Scotti è una fiaba nera ambientata in una Sicilia atavica e di sortilegi, in cui una famiglia ormai ostile costringe la figlia adolescente orfana di padre, nata per così dire male, a una perigliosa fuga in un bosco che potrebbe sembrare quello di orchi e streghe. Ma c’è un aspetto che qui cade in perfetto taglio: l’importanza che hanno i libri nel percorso, diciamo così, di emancipazione di Catena. Aspetto che ci riporta a un altro brillante esordio recente:
Finché dura la colpa (Gaffi) di Crocifisso Dentello. Per dire che entrambi i narratori, quanto al rapporto tra letteratura e mondo, è sempre la salvifica azione della letteratura, alla fine, a chiudere la partita. Ho citato scrittori che, con la forma romanzo, non vogliono avere un rapporto facile e conciliato: requisito specifico della collana “i chiodi” di Pendragon, varata da un giovanissimo fuoriclasse della critica come Matteo Marchesini, la quale, nell’ultimo anno, ha pubblicato due notevoli esordienti: l’italo-iraniano Nader Ghazvinizadeh della raccolta di racconti
I cosmonauti, straniante ricognizione antropologica sul nostro oggi, e il Nicola Barilli di
Italia in autunno, ilarotragico romanzo bolognese dedicato all’instabile Paese dei trentenni. Piccoli editori crescono, insomma: e nel segno d’una letteratura di ricerca che le grandi case hanno quasi abbandonato. Come la Nottetempo del ventiduenne Giorgio Ghiotti di
Rondini per formiche che, in un romanzo dedicato a due giovanissimi fratelli, d’una giovinezza inquietante e insieme giudiziosa, può non per caso citare in epigrafe Amelia Rosselli (da un suo verso il titolo) e Giorgio Manganelli. Senza dire d’un rinnovato e sempre più deciso impegno della Giunti nella narrativa italiana, la quale, dopo Pellegrino e il sardo e venturoso Cristian Mannu di
Maria di Ísili (che nasce sotto la stella mitico-antropologica dell’indimenticabile Sergio Atzeni), ci consegna
La grande A della ventottenne Giulia Caminito, un’altra bambina nata male, cresciuta dagli zii nella leggenda non edificante d’una madre scappata nel continente nero per chissà che loschi traffici: una mia Africa che diventa subito nostra, per una storia freschissima e, insieme, disillusa. Prima di tirare le fila di questo discorso vorrei segnalare, però, anche l’elegante esordio nel romanzo di Lorenza Pieri, con
Isole minori (edizioni e/o), scritto in una lingua di nostalgie e lontananze mediterranee. Due sorelle, la storia piccola, ma lunga quarant’anni, di una famiglia, e la Storia grande del Paese: ma con al centro un’isola, il Giglio, di appartata e selvaggia bellezza. Per un libro assai suggestivo che si fa forte, non si sa se vagheggiamento utopico o crocevia leggendario della memoria, di quel sentimento che Gesualdo Bufalino volle una volta definire come “isolitudine”. In conclusione, forse, ce lo possiamo chiedere: che differenza c’è tra i fondatori della nuova narrativa italiana degli anni ’80 e gli epigoni di questo secondo millennio ormai conclamato? Ecco: se quei pionieri, dopo il Calvino terminale di
Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), ma anche l’Eco del
Nome della rosa (1980) – in forza d’una quasi assenza di rapporto con la tradizione (ma anche con la sua negazione avanguardistica) – conoscevano lo stupito ritorno, al grado zero, d’una pura e ingenua volontà di racconto, gli esordienti di oggi sembrano perseguire, all’opposto, un tentativo di rifondazione del rapporto con la tradizione e con le più diverse possibilità espressive della lingua italiana. Se il rischio dei primi era un analfabetismo culturale di ritorno, quello dei secondi si traduce, talvolta, nella retorica dell’iperletterarietà.