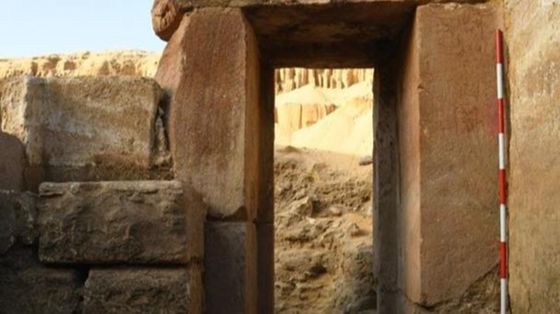Quanto è rischioso vivere ai tempi degli esseri umani più ricchi di sempre
di Pietro Saccò
Nella storia dell'Occidente la grande ricchezza dei non nobili era accettata in un equilibrio di pesi e contrappesi che oggi si è rotto. Qualcosa è cambiato dagli anni '80. Colloquio con Guido Alfani

Probabilmente siamo i contemporanei degli individui più ricchi della storia dell’uomo. Nessuno ha mai avuto patrimoni dal valore assoluto paragonabile a quelli di Bernard Arnault, Jeff Bezos o Elon Musk, che con oltre 200 miliardi di dollari di ricchezza si contendono il primo posto nella classifica mondiale dei super miliardari stilata da Bloomberg.
Certo, dipende da che cosa intendiamo quando parliamo di ricchezza. «Il nobile bretone Alano il Rosso, così chiamato per il colore della barba, grazie alle sue imprese militari per conto di re Guglielmo, il conquistatore dell’Inghilterra, arrivò ad accumulare un patrimonio stimato attorno al 12% del prodotto complessivo del Paese. Un livello a cui non si avvicina nessuno dei grandi ricchi delle nostre democrazie di oggi. Però il rapporto tra patrimoni e Pil non è il parametro migliore per confrontare la ricchezza nella storia» ci dice Guido Alfani, docente di Storia Economica all’Università Bocconi.
Lo scorso dicembre Alfani ha pubblicato con la casa editrice dell’Università di Princeton il libro As Gods Among Men, che significa “Come dei tra gli uomini” (a ottobre arriverà in Italia, tradotto da Laterza). È una sorta di storia della ricchezza e più precisamente del ruolo dei grandi ricchi in Occidente nel corso dei secoli. Lo studio di Alfani ha avuto una vasta eco negli Stati Uniti, dove il dibattito sulle immense fortune dei supermiliardari e l’aumento delle diseguaglianze è molto acceso. «Il metodo più sensato per confrontare la ricchezza di un ricco di oggi e di uno del passato è guardare ai redditi e al lavoro – spiega –. Ci chiediamo: quanto lavoro, quanti lavoratori è in grado di pagare una persona? Se usiamo questo parametro vediamo che i grandi ricchi di oggi sono più ricchi di chiunque sia mai esistito sulla Terra, anche perché possono muoversi su scala mondiale. Una figura come Jeff Bezos può esistere solo dentro un’economia globalizzata».
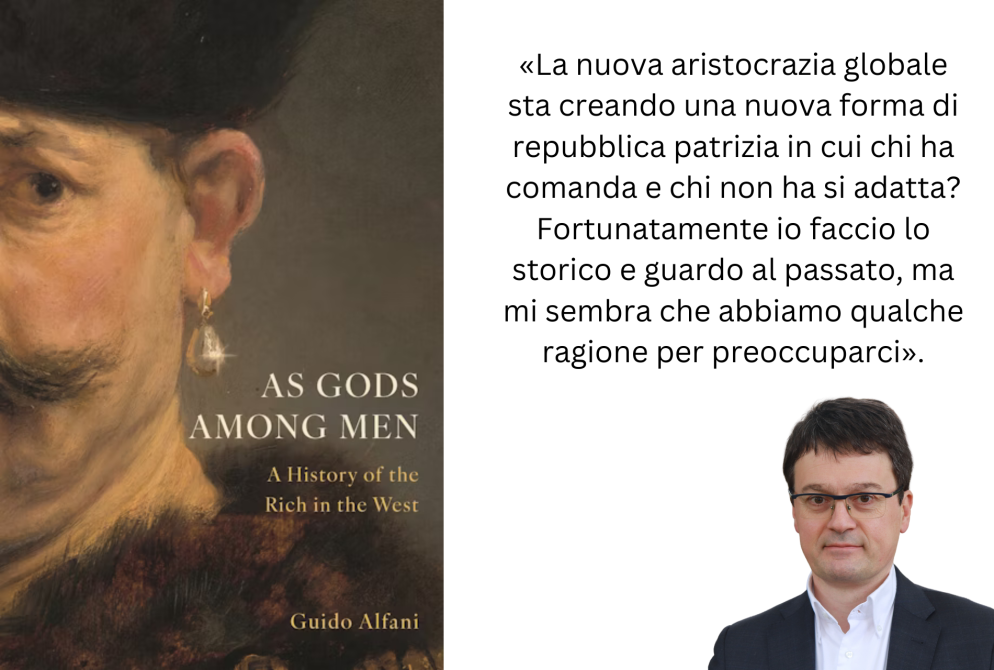
Quando i ricchi erano granai magnificenti
La questione centrale però non è quanto siano ricchi i super miliardari, ma che effetto ha la loro presenza all’interno della nostra società. Nella tradizione occidentale, spiega Alfani, la ricchezza dei nobili non era un problema sociale: «Per secoli è stata considerata normale e del tutto accettabile l’esistenza dei nobili che avevano maggiori risorse, perché allo stesso tempo avevano anche maggiori doveri verso i sudditi. Nel sistema feu dale la disuguaglianza era molto ampia, ma era concettualizzata dentro un sistema ordinato di contraccambio. La ricchezza come problema si pone quando emergono i ricchi non nobili: cittadini capaci di accumulare risorse sfruttando le opportunità economiche che si aprono in certi momenti della storia. Ad esempio, con la rivoluzione commerciale del medioevo, l’apertura delle rotte commerciali a lunga distanza, e lo sviluppo di un sistema finanziario per farle funzionare. Già allora, teologi come Tommaso d’Aquino suggerivano ai governi di vietare queste attività, perché queste persone diventavano troppo ricche e quindi grandi peccatori. Ma i teologi non sono riusciti a imporre il loro punto di vista».
Quando la ricchezza dei “ricchi non nobili” è emersa come un problema sociale, la società occidentale si è costruita un nuovo equilibrio di pesi e contrappesi: ha iniziato a considerare i grandi ricchi una sorta di riserva di denaro disponibile nei momenti di emergenza. Nel XV secolo, l’umanista toscano Poggio Bracciolini nel De Avaritia concettualizza l’idea dei ricchi come granai di denaro a cui attingere nelle fasi complicate, così come si farebbe con i cereali in un momento di carestia. Allo stesso tempo i ricchi del medioevo e dell’età moderna erano amati per la loro magnificenza: rendevano belle le città con palazzi, giardini e monumenti, costruivano monasteri e biblioteche, finanziavano gli artisti. «La magnificenza è diversa dalla munificenza – fa notare Alfani – perché non è generosità pura e semplice: è trasformare la ricchezza privata in beneficio pubblico per dimostrare la propria grandezza e rivendicare il diritto di governare. È quella di Cosimo de’ Medici che salva Firenze dalla bancarotta ma praticamente se la compra. Il tutto con molta chiarezza, senza ambivalenze».
Quando invece è lo Stato a salvare i ricchi
I grandi ricchi hanno conservato questo ruolo di “granai magnificenti” fino al secolo scorso, con modalità diverse: ancora durante la Prima guerra mondiale il cancelliere dello Scacchiere britannico convoca i banchieri della City e gli spiega che serve denaro per finanziare l’esercito, e quindi o le banche lo prestano “spontaneamente” allo Stato o lo Stato se lo prende. A un certo punto della storia recente, però, i super ricchi hanno smesso di accettare questo ruolo di grande riserva di denaro per il resto della società.
Ovviamente è impossibile dire con precisione quando sia successo, ma Alfani indica come momento di rottura gli anni Ottanta: «Certamente le piattaforme politiche di Ronald Reagan e Margaret Thatcher hanno cambiato radicalmente l’agenda. Si diffonde l’idea che lo Stato debba tassare e intermediare il meno possibile dell’attività economica mentre si indebolisce l’idea che i servizi vadano forniti dallo Stato e si debbano tassare i più abbienti per poterli pagare. Questo approccio diverso e più individualista conquista la politica a tutti i livelli: quasi nessuno si presenta alle elezioni dicendo che occorre alzare le tasse, anche se si tratta di alzarle soltanto sulla parte più ricca della popolazione a beneficio di tutti gli altri. Il dibattito sul tema della tassazione, negli Stati Uniti come in Europa, si è fatto molto ideologico. Di sicuro molti politici credono che parlando di tasse non si vincono le elezioni».
L’esito di questo ribaltamento di prospettiva si è visto con chiarezza durante l’ultima grande crisi finanziaria, quando si è deciso di usare i soldi dello Stato per salvare le banche dopo il crack di Lehman Brothers: «È stato il momento in cui abbiamo visto concretamente l’inversione – ricorda il professore –, il passaggio da una situazione in cui il rischio del debito pubblico è privatizzato perché garantito dai grandi ricchi a una in cui i rischi privati dei miliardari sono collettivizzati, come avviene quando si usano i soldi pubblici per il salvataggio statale di istituti “troppo grandi per fallire”».

Repubbliche patrizie, in una nuova forma
È un fatto che l’aumento delle diseguaglianze all’interno dell’Occidente sia iniziato proprio negli anni Ottanta. Negli ultimi anni si è fatta strada la percezione che la ricchezza di questi super ricchi sia un problema. «I miliardari possono decidere di non essere più la riserva di soldi dello Stato, ma la richiesta da parte della società perché invece mantengano questo ruolo rimane. Negli appelli di movimenti come quello dei Patriotic Millionaires, cioè i ricchi che chiedono di pagare più tasse, la consapevolezza della situazione è profonda. In uno dei loro appelli, In Tax we trust, lo scrivono chiaramente: “L’alternativa è tasse o forconi”. È esattamente quello che sarebbe successo nel medioevo se qualcuno avesse provato a tenere il grano da parte in un anno di carestia. Nella nostra storia i ricchi hanno sempre saputo che, se non avessero risposto alle aspettative del popolo, avrebbero rischiato la rivolta».
Ecco allora il punto finale: davvero la crescita delle diseguaglianze sta mettendo a rischio la nostra democrazia? «Non lo so, ma di sicuro questo problema non sparirà da solo – avverte Alfani –. In teoria, in una democrazia se la popolazione vuole che i ricchi contribuiscano di più alla spesa comune voterà di conseguenza. Il rischio che vedo però è una sorta di ritorno, in una nuova forma, alle repubbliche patrizie del Cinquecento, come quelle di Venezia o di Genova. Cioè, un sistema in cui sulla carta decide il popolo, come dovrebbe essere in una democrazia, ma nei fatti sono dei nuovi “patrizi” a controllare il voto. Per tutta l’Età moderna i ricchi hanno redistribuito le ricchezze con soluzioni diverse, come le confraternite o l’apertura delle scuole per i poveri. Nel frattempo, le diseguaglianze aumentavano ma la gente non si ribellava proprio perché riceveva qualcosa. Le società però stavano cambiando: magari all’inizio i poveri hanno l’orto o un pezzo di vigna, ma alla fine dipendono completamente dalla benevolenza dei ricchi. Questo è il problema: la nuova aristocrazia globale sta creando una nuova forma di repubblica patrizia in cui chi ha comanda e chi non ha si adatta? Fortunatamente io faccio lo storico e guardo al passato, ma mi sembra che abbiamo qualche ragione per preoccuparci».
© RIPRODUZIONE RISERVATA