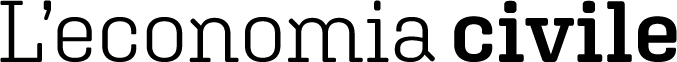Ansa
A ridosso dell’elezione di Trump e subito dopo la pandemia, il mondo del marketing e della comunicazione ha aderito a un movimento di pensiero introdotto da uno dei padri della disciplina. Sotto le insegne del “Brand Activism” di Philip Kotler, la quasi maggioranza del top management di tutto il mondo si trovava a reclamare il proprio posticino nell’agone della politica, con schieramenti più o meno fulminei tra le fila di chi militava per conquistare il proprio sacrosanto diritto. Dall’arcobaleno delle comunità lgbtqia+ al pugno guantato di nero del movimento Black Lives Matter, passando ovviamente per il verde dell’ambientalismo, il blu degli oceani e il rosa di Barbie femminista con sfumature di rosso Mee Too. Le ricerche segnalano l’attenzione – e le intenzioni d’acquisto – da parte delle nuove generazioni di consumo, il “woke” tutto sommato fa chic e non impegna più di tanto, i fondi d’investimento diventano più generosi e le borse ricompensano. Poi sono arrivate due guerre.
All’inizio la prima ha accesso qualche timida forma di protesta, qualche maison ha chiuso i propri negozi in Russia, alcune multinazionali hanno spostato altrove i propri uffici all’ombra del Cremlino, forse più preoccupate per le sanzioni economiche che per una reale avversione pacifista all’invasione dell’Ucraina.
Ma sul secondo fronte, esploso dopo l’attentato terroristico di Hamas del 7 ottobre, la presa di posizione si è fatta più controversa. E anche rispetto alla difesa dell’Ucraina, contro l’aggressione di Putin, i brand non sanno esattamente come muoversi. Perché da una parte si litiga per una nuova fornitura di armi agli eserciti ucraini, dall’altra però restiamo attaccati al cordone ombelicale di un Paese che resta il primo fornitore di gas per la maggior parte dei Paesi Nato interessati dal conflitto. Ed è proprio su questi temi che le marche preferiscono un poco dignitoso silenzio, perché qui il terreno si fa più scivoloso. La guerra purtroppo ha smesso di essere un tabù ed è più difficile argomentarla rispetto alla sfilata del gay pride con il carro brandizzato e i campioncini di prodotto distribuiti come dentro a una fiera commerciale. Intanto “Tutti gli occhi su Gaza” fa milioni di condivisioni online con un’immagine artefatta e prodotta dall’intelligenza artificiale, mentre le foto vere di reporter che muoiono con la macchina fotografica in mano (oltre 130 giornalisti/e sono morti dal 7 ottobre nella striscia di Gaza - Fonte Altraeconomia) sono censurate dalle piattaforme digitali per non turbare i budget degli inserzionisti. E così, per onorare gli algoritmi, l’attivismo diventa manierismo digitale, la pubblicità rientra nei ranghi dell’intrattenimento, si fa meno civile e teme che insistere sui diritti alla fine non ripaghi gli sforzi. Altrimenti perché la birra Bud Light avrebbe dovuto ritirare la sua campagna con testimonial una modella transgender e attivista dopo le proteste dei suoi consumatori?