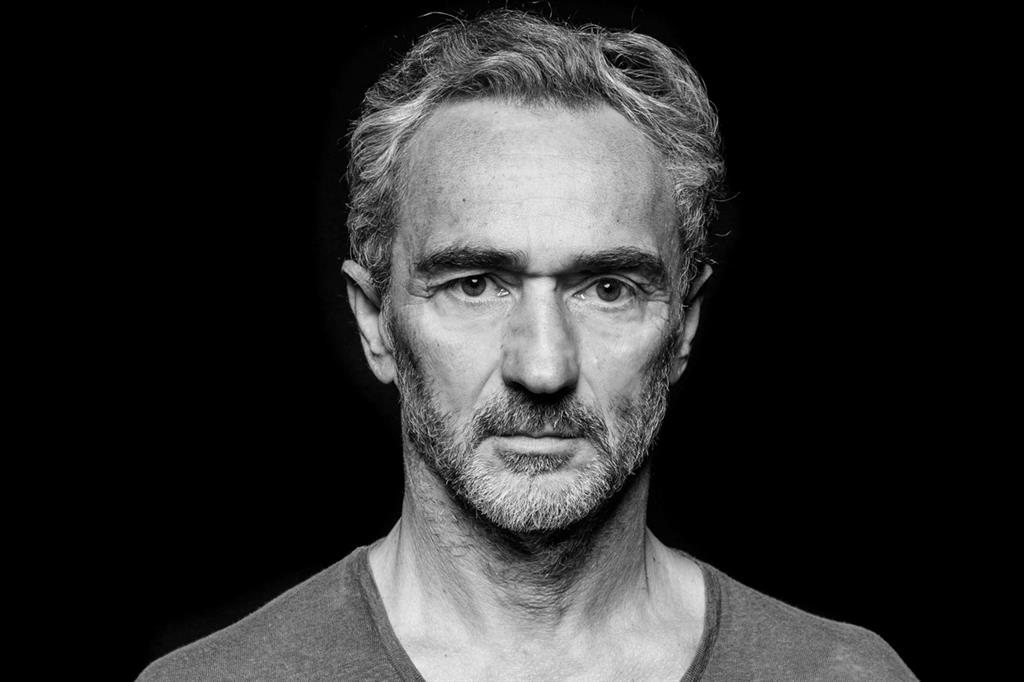
Il coreografo francoalbanese Angelin Preljocaj (Joerg Letz)
«La danza deve sporcarsi le mani con la realtà, non può restare un’isola felice». Una realtà che ha i colori della violenza. Il nero. Come nera è la polvere che in scena sollevano i ballerini. Angelin Preljocaj ha voluto un tappeto di detriti neri sul palco del Teatro alla Scala. Foglie morte, forse, perché la musica di Franz Schubert racconta un viaggio d’inverno, Winterreise appunto. Che è il titolo del balletto che stasera (e sino al 9 marzo) va in scena al Teatro alla Scala, prima creazione per il Corpo di ballo milanese del coreografo nato da genitori albanesi rifugiati politici in Francia.
«Da tempo pensavo a un lavoro sui ventiquattro lieder di Schubert per voce e pianoforte sulle poesie di Wilhelm Müller: il musicista li ha scritti a pochi mesi dalla morte e sono impregnati di malinconia. Assoli, passi a due, a tre, momenti corali con dodici danzatori in scena – racconta Preljocaj, classe 1957 – dove non c’è un ballerino che incarna il viandante della Winterreise, ma dove tutti fanno rivivere le sensazioni che musica e poesia trasmettono».
Un “viaggio d’inverno” quello raccontato da Schubert che non può non far pensare ad altri viaggi, quelli di migliaia di persone che attraversano il Mediterraneo, Angelin Preljocaj.
«La danza parla con il corpo, è la sua forza dirompente. E quelli che si vedono da mesi nelle immagini dei telegiornali sono corpi di uomini che si spostano, popoli martiri, genti che vanno in altri paesi sfidando la sorte e mettendo la loro vita in pericolo, mettendo in conto che potrebbero morire. Ma lo fanno, forzano il loro corpo in questo viaggio della speranza. L’arte deve farsi interrogare da ciò che succede nel mondo. Deve farlo anche la danza che non è estranea agli eventi della vita e alla loro durezza. A volte mi chiedo: perché c’è violenza nei tuoi lavori? E rispondo: perché c’è violenza nel cinema e nella letteratura? C’è tutto questo perché l’arte deve parlare del nostro mondo. Perché la danza dovrebbe essere l’unica forma d’arte che vive felice? Non può essere così, anche la danza deve farsi carico di una parte della miseria e della violenza del mondo altrimenti è solo un’illusione, non un riflesso di ciò che siamo e del nostro presente».
Un’attualità presente anche nella sua Winterreise?
«Il viaggio raccontato da Schubert assomiglia alla vita, quindi richiama inevitabilmente ciò che accade nel mondo. Immagino questo viaggio in un non luogo dove è presente l’inverno, ma dove troviamo anche il germe di altre stagioni. Pensavo da tempo a una coreografia sulla Winterreise e quando il direttore del Corpo di ballo Frédéric Olivieri mi ha proposto un nuovo lavoro nell’ambito del progetto di balletti su musiche da camera la Scala mi è parso subito il luogo ideale per creare sulle note del ciclo di Schubert: la voce del baritono Thomas Tatzl, il pianista James Vaughan, i dodici danzatori del Corpo di ballo milanese che sia in compagnia che in Scuola di ballo hanno già avuto modo di confrontarsi con il mio stile e il mio linguaggio danzando Annonciation, Le parc, La stravaganza e Larmes blanches».
Come è stato il lavoro di creazione?
«Molto stimolante. Insieme abbiamo cercato di fare diventare movimento attraverso il corpo la scrittura di Schubert. Nella Winterreise la danza diventa un terzo linguaggio che si fonde con quello della musica e della poesia, diventa una scrittura di movimento creata per far venire a galla e rendere visibili le emozioni perché lo spettatore possa fruire tutti i tre diversi livelli di questo viaggio. Un dialogo intimo con chi sta in platea fatto di parole, di note e di gesti. Da tempo i danzatori scaligeri hanno familiarità con lo stile contemporaneo. Per me è stato un piacere lavorare con loro per la facile adattabilità che hanno dimostrato: sono abituati a cambiare stile in fretta, ad apprendere il linguaggio del coreografo che lavora con loro di volta in volta e a farlo proprio».
Come vive il rapporto con le sue coreografie? Ne è geloso o le lascia “libere” una volta create?
«I miei lavori sono parte di me perché c’è sempre qualcosa di personale che viene messo in una creazione, qualcosa che viene dall’interno dell’artista. Una volta che hanno debuttato, però, mi piace lasciarli liberi. Un’opera d’arte, tanto più se viva e palpitante come un balletto, deve respirare, viaggiare, varcare confini: se si è troppo gelosi non si riesce a trasmettere a più persone possibili il messaggio che si voleva lanciare. Per il New York City Ballet ho creato La stravaganza che è poi approdata alla Scala, ma a New York non si balla come a Milano, lo stile e la sensibilità sono differenti e vederla in America e in Italia ha un sapore diverso: ogni compagnia interpreta una coreografia con la propria sensibilità, la propria cultura, è lo stesso linguaggio, ma parlato da qualcun altro con il proprio accento».
Il suo “accento” coreografico dove lo ha imparato?
«La mia è una storia un po’ buffa. Avevo dieci anni e una mia compagna di classe mi aveva prestato un libro: dentro c’era una foto di un personaggio che non conoscevo. Aveva una tale bellezza e un fascino di estasi nel suo viso che mi sono chiesto: chi è? cosa fa? Cosa lo porta a questo stato di luce interiore che gli illumina il viso? Come faccio a provare anch’io quelle sensazioni? Ho scoperto dalla didascalia che era Rudolf Nureyev. Quando ho restituito il libro alla mia amica le ho chiesto di andare a danza con lei. Al tempo facevo judo e sono andato alla prima lezione con i pantaloni bianchi che indossavo in gara. Tutto è iniziato da lì».
E come ha deciso, dopo anni come danzatore, di diventare coreografo e di fondare una sua compagnia, il Ballet Preljocaj, che oggi ha sede ad Aix-en-Provence?
«Già da piccolo avevo il desiderio di esprimere qualcosa che sentivo mio. La collaborazione da danzatore con grandi coreografi come Zena Rommet, Merce Cunningham o Dominique Bagouet mi ha fatto capire che quella era la mia strada: lavorando con loro ho imparato a comporre, ho acquisito gli strumenti del mestiere per esprimermi e per creare quello che oggi è il mio linguaggio».











