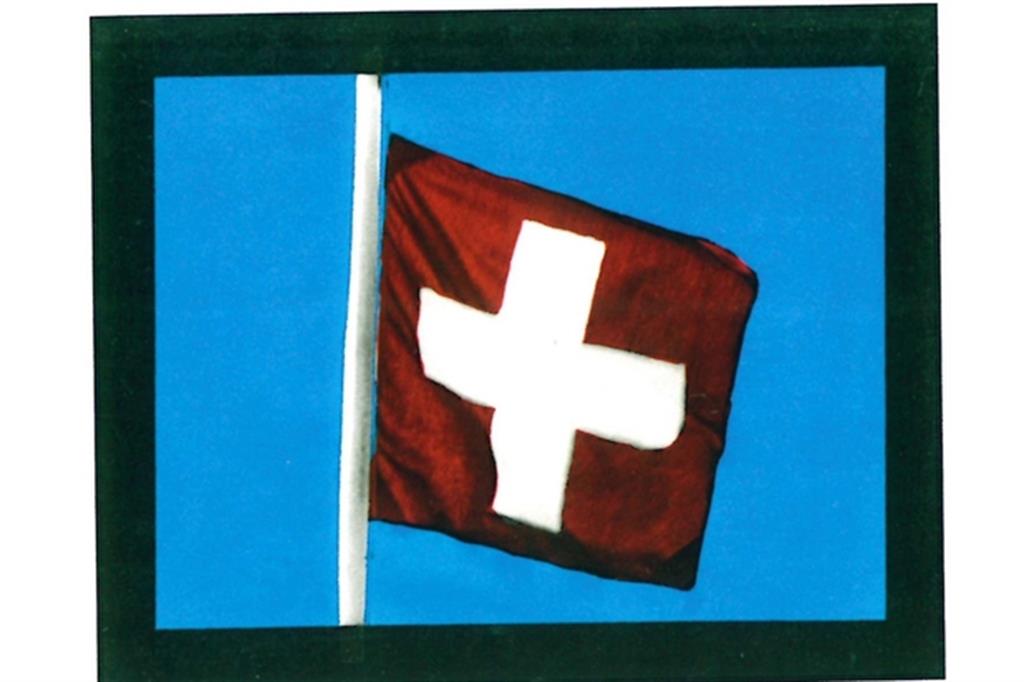
Ha aperto sabato scorso, sino al 6 agosto, alla Kunsthaus di Aarau – cittadina capoluogo del cantone svizzero Argovia – l’antologica, curata da Madeleine Schuppli, “Swiss Pop Art. Forme e tendenze della pop art in Svizzera dal 1962-1972”. Cinque anni di preparazione, cinquantuno artisti presenti, dai più anziani Jean Tinguely e Friedrich Kuhn, a Markus Müller (1943 Suhr) e Barbara Davatz (1944 Zurigo). Tinguely (Friburgo 1925-Berna 1991) apre con la scultura Frigo Duchamp( 1960) di grande forza espressiva – si dedicherà solo più tardi alle macchine dada e ludiche. Kuhn dalla breve vita (Gretzenbach 1926Zurigo 1972) è la presenza più originale dell’intera mostra. Eccentrico al movimento pop, in polemica si direbbe con il movimento stesso e la “servitù” americana dei contemporanei, Kuhn carica l’immagine di forti venature melanconiche, di ironia e disincanto e inventa forme. Markus Müller – forte anche di una formazione italiana – è, in questa mostra, con Peter Stämpfli (Deisswil/Stettlen 1937) l’artista svizzero più proprio al movimento internazionale.
A Müller e Stämpfli i curatori della mostra dedicano gli spazi più ampi, sia per la loro importanza di merito sia per le dimensioni delle loro opere, sia infine perché le due appartenenze artistiche più esplicite alla poetica pop. Stämpfli più concettuale. Müller più pittore, carico di proprie autonome invenzioni. Qualcosa ancora in questo preambolo per la pittrice Davatz. Barbara Davatz è, non l’unica, ma la più esplicita leader di una pittura swiss pop, di un pop-cartolina elvetica (oh mia patria, oh mia Elvetia) tutto coniugato sulla manipolazione delle icone e loghi abusati dalla folk-art della piccola patria. Boschi carichi tuttavia di inquietudine, montagne, animali da cortile, fattorie immerse nel silenzio e nel mistero. In mostra c’è un polittico della Davatz che si apre con un uomo in costume tradizionale (il trachtpangermanico: calzoni di cuoio, cappello con la piuma eccetera), e procede, con un rovesciamento iconico dell’Heimatschutz, per quadretti con paesaggi, animali da cortile, che diventano immagini cariche di suspense, mondo chiuso, xenofobico, incestuoso anche, anteprima del delitto.
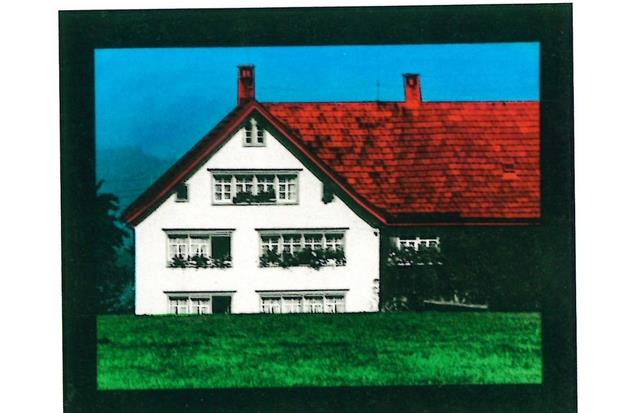
Sì, c’è una “via elvetica” alla pop. È quella della Davatz, di Emilienne Farny che spostatasi a Parigi ne dipinge le periferie con un approccio quasi naif, del più anziano e autorevole Samuel Buri qui presente con le tele condotte per pixel: montagne, montanari nudi e atletici alla Hodler che soffiano dentro il corno della Alpi al sole di un avvenire. Allora, per mettere ordine, c’è voluto un notevole coraggio a imbarcarsi in questa impresa. Se c’è uno spazio del mondo anti- pop questo si chiamerebbe Svizzera, se c’è un assenza di panorama urbano questo è per i laghi, gli alpeggi e per le valli svizzere, le tante tal. Il pop è – di contro – la resa artistica della oggettificazione del mondo, il panorama urbano dove dominano i manufatti d’uso comune (la bottiglia di Coca, la scatola di spaghetti, l’interno dell’automobile, il vagone della metropolitana...) e attorno a loro si genera un racconto, un’epica addirittura, del quotidiano. Lo sguardo – nostro, del pittore – non può che fermarsi sull’artificio. Bob Indiana, artista pop americano in mostra a Locarno, dipinge segnali, frecce, numeri, e dice: «Ci sono più segnali che alberi in America. Ci sono più segni che foglie. Per questo penso a me stesso come a un pittore del paesaggio americano».
Il pop va in parallelo allo sviluppo industriale degli anni Sessanta e lo dipinge. Dopo il rifiuto di ogni dato oggettivo del linguaggio informale, dopo l’insorgenza anarchica e antistorica della fine anni Quaranta e anni Cinquanta (Gorky, Wols, Pollock), l’arte si accende negli anni Sessanta di una nuova rappresentazione della oggettività. L’immagine muta intrinsicamente, alla radice. Il processo di modificazione della immagine del dato reale (lo sguardo attorno a noi) inizia a fine Ottocento con la fotografia, procede con le sequenze del cinema e infine con i frames e la trasmissione per pixel televisiva. Giustamente il catalogo curato dalla Schuppli inizia il racconto-pop nel 1957, con la installazione della televisione in bianco e nero in circoli, luoghi pubblici collettivi, poi a colori nove anni dopo. Molti degli artisti presenti ad Aarau aderiscono sia alle modalità di una “immagine televisiva”, come alle cronache e all’iconologia del tempo. E sono automobili, traffico, frigoriferi, grandi pomodori e pudding. Si partecipa alle cadenze del movimento internazionale ma non se ne vive la condizione.
Sono qui – ma indistinti, usurati dal tempo – gli storyteller, i partecipi della figurazione in voga: l’allunaggio, i piloti dello spazio con caschi e tute, l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, di Martin Luther King, la guerra in Vietnam con pure intense immagini e una impaginazione concitata. In un anfratto della mostra – si snoda per due piani – è collocato un juke-box d’antan: monumentale, simbolo, icona e oggetto del tempo. E sono i Simon&Garfunkel con le musiche per Il laureato, i Rolling Stones, i Beatles con Yellow submarine e Sgt. Pepper, John Lennon con Imagine… Americana e inglese la musica pop così come fu prima di tutto americana e anche londinese la pittura, l’opera pop. Nel 1964 la Biennale di Venezia sancisce la vittoria dell’opera d’arte dell’oggetto sulla pittura esistente (informale, materica, espressionismo astratto). Il padiglione americano è dei grandi artisti pop e il premio della Biennale è per Robert Rauschemberg, caposcuola pop e mediatore. Milano e Parigi da sempre poli di formazione e gravitazione per gli artisti svizzeri – o direttamente negli Usa come per lo scultore Metzler – favoriscono l’approccio al nuovo movimento artistico. Così è per il ticinese Renzo Ferrari (Cadro 1939) formatosi a Milano, presente in mostra con una propria partecipazione alla immagine- oggetto e alla vicenda pop: riflette sulla mutazione bionica della figura umana e sarà questa una costante del suo lavoro.








.jpg?dt=1734709380762&Width=300)
.jpg?dt=1734709380762&width=677)

