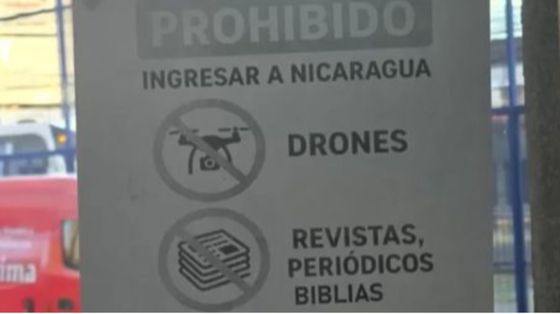Il bambino del Donbass e il suo inutile peluche
È un’immagine che passa per un istante su un tg, dal Donbass. Ma né bombe, né macerie, né morti. Semplicemente un pullman carico di bambini e ragazzini, decentemente vestiti e coperti contro il freddo. Sono i bambini ucraini considerati, a ragione o spesso a torto, senza famiglia, che vengono portati, o deportati, in Russia. Il frammento che mi si stampa negli occhi è un bambino forse sui quattro anni, che sui sedili appaiati siede da solo. Accanto, qualcuno gli ha messo un coniglio di peluche, nel pietoso tentativo di dargli un compagno. Ma il piccolo pare del tutto indifferente a ciò che gli è attorno, rannicchiato in una posizione quasi fetale. Il peluche, gli altri bambini, gli abiti, finalmente, dopo i mesi in rifugi o campi profughi, caldi: al bambino nulla di tutto questo importa. Vuole solo e soltanto la sua mamma. Il suo sorriso, il suo profumo sono l’unico paradiso che conosce. E questo paradiso si è frantumato, forse sotto le bombe, mentre la sua casa crollava. Poi un gran buio, poi luce, di nuovo: ma la mamma, scomparsa. Così che, se guardi bene, c’è una piccolissima immensa apocalisse in quel figlio che si stringe come nel grembo della mamma, mentre lo portano via. Diventerà russo. Forse non ricorderà nemmeno un giorno questo pullman, e la sua casa di un tempo. Magari ci sarà una selezione? I più belli, i più intelligenti adottati, gli altri, magari, nei brefotrofi. Ordine, disciplina. Impareranno il senso della Patria, dell’onore, della guerra. E non appena avranno diciott’anni, gli metteranno in mano un fucile. Ma qualcosa di strappato, una radice divelta resterà in quei figli rubati. L’ombra di un volto fantasmatico ormai, di un abbraccio, di uno smarrito paradiso. Uomini alti e forti saranno, ma lesi, feriti nelle fondamenta. Importati in massa come giovani alberi, che, tanto, crescono in qualsiasi terreno. Calpestando, quindi, negando ciò che è un uomo. Trent’anni fa per “Avvenire” andai a Francoforte. Accadeva che i figli di ricchi minacciati nei Paesi arabi o in Libano o in Afghanistan venissero spediti soli, a otto o dieci anni, in aereo in Germania, con un biglietto in tasca: “Adottateli, da noi non diventeranno grandi”. Era la prima volta che si presentava un simile fenomeno, la Germania ne era impietosita. Quei bambini venivano provvisoriamente accolti in un grande collegio nella Foresta Nera, un posto bellissimo, non una tenda da profughi. Andai a vederli, era febbraio, nevicava. Gli ospiti erano accuditi e coccolati. Ma me ne rimase in mente uno che scorsi all’ultimo, andandomene, appena varcato il portone. Aveva la pelle nocciola e forse otto anni, e grandi occhi neri bellissimi. Da dietro il vetro della finestra fissava assorto quel bosco bianco, quel mondo ignoto. Un pozzo di nostalgia struggente nei suoi occhi, che non posso dimenticare – un piccolo cedro del Libano trapiantato in Baviera. Ce l’avevano mandato i genitori, per il suo bene. Ma quanto, evidentemente, soffriva anche lui la sua apocalisse. Fratello del futuro bambino del Donbass che varca il confine russo, oggi, con un posto vuoto accanto, un inutile peluche, e una sola domanda che gli scoppia in petto: tu, le tue braccia, il tuo seno, tu, dove sei. Li faranno marciare un giorno col fucile in spalla, in fila, come soldatini di legno, marceranno al passo dell’oca. Ma non estirperanno quell’ombra, quella nostalgia ostinata di un Eden perduto. (Mi chiedo a volte, quel bambino con gli occhi neri alla finestra in Baviera, oggi, chissà).
© riproduzione riservata
© riproduzione riservata
© RIPRODUZIONE RISERVATA