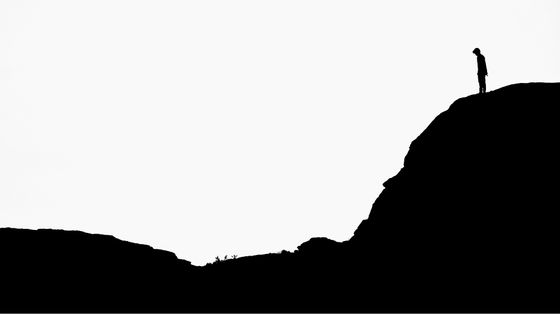Lo Stato non deve «dare morte»
di Redazione
Caro direttore,anche sul "Corriere della sera" non poteva mancare, il 13 luglio, un ponderoso intervento a commento della «legge sul testamento biologico» approvata il giorno precedente alla Camera e che sarebbe «una ferita alla laicità dello Stato». Tutto compreso nel titolo dell’articolo di Michele Ainis, che, dopo un’iniziale buona impressione, comincia a far rimpiangere – a me che leggo Corsera e Avvenire – il professor Grevi. Fra i tanti punti interrogativi che ho segnato: 1) «L’articolo 32 della Carta repubblicana disegna la salute come un diritto, non già come un dovere». Lapalissiano: il «dovere» è dello Stato, che deve tutelare il «diritto alla salute» e, a maggior ragione, il «diritto alla vita», dei singoli suoi componenti. Contro tutti, ma proprio tutti, anche il titolare apparente; 2) «La medesima norma permette trattamenti sanitari obbligatori, purché per legge e in nome dell’interesse generale». Lapalissiano, ma il primo interesse generale è l’integrità del corpo sociale, cioè di tutti, ma proprio tutti, i suoi componenti; 3) Conclusione dell’articolo: «Sarebbe meglio abbandonare questa legge imperativa, affidandosi a un giudizio reso caso per caso». In teoria posso condividere, perché concordo che «ogni caso è diverso», ma la realtà è un’altra cosa: anche per il furto non ci sarebbe bisogno di una legge! Purtroppo l’uomo è imperfetto e lo Stato deve cercare di contenere le imperfezioni. Chiude, Ainis, con l’aforisma di Thoreau: «Se il governo decide su questioni di coscienza, allora perché mai gli uomini hanno una coscienza?». Già: ma allora perché esiste lo Stato?
Mario Grosso, Gallarate (Va)
Non commento quando posso farne a meno il commento di un altro giornale, caro signor Grosso (ma confesso di non riuscire a nascondere l’incredulità che mi ha provocato, ieri, la sprezzante vignetta corrierista sull’omino che annaffia una pianticella su un letto d’ospedale: so che cosa hanno ingiustamente sofferto genitori e parenti di persone in stato di minima coscienza, i cosiddetti “vegetativi”...). Vorrei però rispondere alla sua ultima domanda, per quanto lei la porga con intenzione e intonazione retoriche e, dunque, in modo già conclusivo. Prima però mi sembra indispensabile una premessa: la legge che ha già fatto due tratti di strada in Parlamento e che ora tornerà all’esame del Senato è sulle “dichiarazioni anticipate di trattamento” (Dat) sanitario e non “sul biotestamento”, come si continua a scrivere e a dire. Una distinzione non formale, perché riafferma un principio cardine della nostra civiltà giuridica: la vita umana è un bene indisponibile, e dunque non è argomento da testamento.E veniamo alla questione. Lo Stato esiste per tutelare e dare sostegno ai cittadini, alla loro vita e, perciò, alla loro salute. Non esiste per “amministrare e somministrare la morte”. Di questo sono profondamente convinto anch’io, e penso che le situazioni in cui lo Stato fa invece proprio questo – amministra e somministra la morte – rappresentano orrori da cancellare. Non riesco, insomma, ad accettare l’idea di uno Stato davvero civile che sia anche boia, in qualunque maniera, in base a qualunque invocazione: giustizia, democrazia, progresso, tradizione, libertà... La trovo terribile sia quando si tratta di una “sanzione”, di una pena capitale, irrogata dall’alto (da un giudice, da un apparato...) sia quando si tratta di un “servizio” preteso dal basso (da una gran folla o da un cittadino che – in nome dell’autodeterminazione – chiede di farla finita). Dare la morte non è un servizio pubblico. Così come l’eutanasia non è una conquista umana, ma l’esecuzione di un uomo o di una donna consenzienti o presunti tali, ma non per questo meno vivi o – come si è incredibilmente detto in un caso celeberrimo – «già morti» nel momento in cui li si uccide.Ho purtroppo, e da tempo, la sensazione che su tutto questo si faccia volutamente confusione al cospetto dell’opinione pubblica, e che si cerchi in ogni modo di abbattere il confine che c’è tra “terminare” una vita e “accompagnarla” nel tratto più duro e faticoso e, a maggior ragione, in quello finale. Una persona malata non più guaribile o gravemente disabile, resta comunque curabile perché c’è sempre una cura – anche solo palliativa, cioè tesa a togliere dolore – per chiunque (lo dico non per sentito dire, ma per esperienza di vita, di famiglia e di amicizia). E c’è un limite, che la legge sulle Dat afferma in modo netto, quello del rifiuto dell’accanimento terapeutico, cioè di azioni mediche eccessive, insensate e inutili. In conclusione: anche se è verissimo che ogni vicenda umana è diversa – tutti meritano il ristabilimento per legge di fondamentali certezze: “sì” a cure adeguate e ben proporzionate e “no” all’accanimento chirurgico, farmacologico e meccanico, no alla morte procurata e, soprattutto, “no” alla morte per fame e per sete di chi non è in grado di alimentarsi e idratarsi da solo. Ogni vita è degna. Ogni persona merita queste attenzioni. È su un fronte così importante che lo Stato può e deve fare tutto ciò che è necessario. Nulla, al contrario, deve fare per far dare morte.
Non commento quando posso farne a meno il commento di un altro giornale, caro signor Grosso (ma confesso di non riuscire a nascondere l’incredulità che mi ha provocato, ieri, la sprezzante vignetta corrierista sull’omino che annaffia una pianticella su un letto d’ospedale: so che cosa hanno ingiustamente sofferto genitori e parenti di persone in stato di minima coscienza, i cosiddetti “vegetativi”...). Vorrei però rispondere alla sua ultima domanda, per quanto lei la porga con intenzione e intonazione retoriche e, dunque, in modo già conclusivo. Prima però mi sembra indispensabile una premessa: la legge che ha già fatto due tratti di strada in Parlamento e che ora tornerà all’esame del Senato è sulle “dichiarazioni anticipate di trattamento” (Dat) sanitario e non “sul biotestamento”, come si continua a scrivere e a dire. Una distinzione non formale, perché riafferma un principio cardine della nostra civiltà giuridica: la vita umana è un bene indisponibile, e dunque non è argomento da testamento.E veniamo alla questione. Lo Stato esiste per tutelare e dare sostegno ai cittadini, alla loro vita e, perciò, alla loro salute. Non esiste per “amministrare e somministrare la morte”. Di questo sono profondamente convinto anch’io, e penso che le situazioni in cui lo Stato fa invece proprio questo – amministra e somministra la morte – rappresentano orrori da cancellare. Non riesco, insomma, ad accettare l’idea di uno Stato davvero civile che sia anche boia, in qualunque maniera, in base a qualunque invocazione: giustizia, democrazia, progresso, tradizione, libertà... La trovo terribile sia quando si tratta di una “sanzione”, di una pena capitale, irrogata dall’alto (da un giudice, da un apparato...) sia quando si tratta di un “servizio” preteso dal basso (da una gran folla o da un cittadino che – in nome dell’autodeterminazione – chiede di farla finita). Dare la morte non è un servizio pubblico. Così come l’eutanasia non è una conquista umana, ma l’esecuzione di un uomo o di una donna consenzienti o presunti tali, ma non per questo meno vivi o – come si è incredibilmente detto in un caso celeberrimo – «già morti» nel momento in cui li si uccide.Ho purtroppo, e da tempo, la sensazione che su tutto questo si faccia volutamente confusione al cospetto dell’opinione pubblica, e che si cerchi in ogni modo di abbattere il confine che c’è tra “terminare” una vita e “accompagnarla” nel tratto più duro e faticoso e, a maggior ragione, in quello finale. Una persona malata non più guaribile o gravemente disabile, resta comunque curabile perché c’è sempre una cura – anche solo palliativa, cioè tesa a togliere dolore – per chiunque (lo dico non per sentito dire, ma per esperienza di vita, di famiglia e di amicizia). E c’è un limite, che la legge sulle Dat afferma in modo netto, quello del rifiuto dell’accanimento terapeutico, cioè di azioni mediche eccessive, insensate e inutili. In conclusione: anche se è verissimo che ogni vicenda umana è diversa – tutti meritano il ristabilimento per legge di fondamentali certezze: “sì” a cure adeguate e ben proporzionate e “no” all’accanimento chirurgico, farmacologico e meccanico, no alla morte procurata e, soprattutto, “no” alla morte per fame e per sete di chi non è in grado di alimentarsi e idratarsi da solo. Ogni vita è degna. Ogni persona merita queste attenzioni. È su un fronte così importante che lo Stato può e deve fare tutto ciò che è necessario. Nulla, al contrario, deve fare per far dare morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA