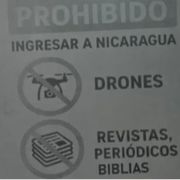Raqqa, le fosse del Daesh nel silenzio del mondo
Una decina di chilometri a sud dell’Eufrate in Siria, il più grande cimitero comune: «Ci sono almeno 3.500 corpi»

Su di una rumorosa chiatta trainata da una carrucola, assieme a sgangherati furgoncini e vecchie moto di fabbricazione cinese, si attraversa l’Eufrate dove gli argini millenari digradano in uno slargo di comoda ghiaia per l’approdo, a poco più di un tiro di schioppo dalla sede del Consiglio civile di Raqqa. Poi si procede per una decina di chilometri verso sud, lungo tortuose stradine contornate di campi ben coltivati: si raggiunge senza fatica il distretto di Kasrat. Passato l’incrocio principale del villaggio, attraversati sempre più isolati casolari e ovili con vecchi portoni di legno, con due curve a gomito di una carreggiata ormai divenuta di sterrato, si giunge ai campi del “Centro di ricerca agrario” del governo siriano.
Tre donne a capo coperto, accovacciate sulle gambe – con loro forse pure un paio di bambini a “razzolare” fra i campi – raccolgono degli ortaggi, oltre un sentiero rialzato che probabilmente segna il confine delle due proprietà. Il silenzio della campagna dell’antica Mesopotamia sembra parlare: “Benvenuti” al Centro agrario di Fikherka, “benvenuti” alle porte dell’inferno.
Non una insegna, nemmeno del filo spinato o uno steccato rudimentale a delimitare – fosse solo per un naturale sentimento di pietà – la più tremenda delle semine di morte. Solo una dozzina di uomini in tuta blu, tutti giovanissimi tranne il capo squadra e il medico legale, camminano con pale e picconi in spalla costeggiando un filare di alberi. Basta avanzare di qualche metro su quella striscia di terra battuta per iniziare a scorgere in prospettiva le prime buche nel terreno. Cunicoli di grigio cemento scoperchiati da poco: le fosse delle vittime del Daesh. «Sono tombe singole, perché qui quelli del Califfato seppellivano i loro affiliati: probabilmente chi cercava di scappare o aveva commesso dei reati», spiega il capo del “Quick responce team” della municipalità di Raqqa. Tutte le mattine, dallo scorso gennaio, è iniziato il tremendo lavoro di riesumazione dei cadaveri. «La gente del posto racconta, durante la dominazione del Daesh, di urla nella notte, di un via vai di camion carichi di persone che tornavano vuoti. Come anche di trattori ed escavatori che andavano e venivano lungo i campi», riferisce sempre il responsabile degli operai della municipalità.
Con una mascherina a coprire naso e bocca, si procede verso due piazzette di terreno, dove una sonda ha incontrato una lastra di cemento a una trentina di centimetri dalla superficie. Pochi colpi di pala servono a spostare la terra, mentre con soli due o tre colpi di piccone ben assestati il cemento del coperchio della prima si frantuma. Nel fetore nauseabondo, fra mosche aggressive, inizia il tentativo di identificazione. «Sono dei bambini», dice Asaad Muhammed, 55 anni. È lui il medico legale che, con le mani ricoperte da guanti da chirurgo, srotola lento un lungo panno, probabilmente un lenzuolo ormai ingiallito: «Due sono neonati», precisa. E mette con gesto pietoso i resti in un grande sacco di plastica bianco. «Il terzo avrà un anno». Nessuno parla, mentre il dottor Muhammed annota il tutto su delle schede raccolte in un quadernone ad anelli. Poi, con pennarello indelebile, scrive un codice di identificazione su un lato del sacco. Si passa alla seconda tomba: è quella di un uomo. Il cadavere, riposto nel sacco, viene ispezionato: «Un colpo di pistola alla testa e uno al ventre» dice sicuro, indicando i fori del proiettile, il medico legale. Sempre nel silenzio assoluto compila una nuova scheda e chiude il secondo sacco bianco. Se mai qualcuno venisse in futuro a ricercare i corpi di un parente, avrebbe questi pochi dati per cercare di dare un nome a poveri resti ormai putrefatti.
Si procede così, ogni giorno dalle 8 alle 11 di mattina, tempo permettendo: sei, otto, fino a una decina di tombe al giorno. «Sinora abbiamo trovato circa 300 corpi. In queste tombe singole il 40 per cento sono bambini di meno di un anno o donne in gravidanza», spiega l’assistente legale. Probabilmente questa la fine di molte delle “spose del jihad” e dei loro figli. I cadaveri sono trasportati all’obitorio per essere, poi, sepolti in un cimitero per gli sconosciuti costituito in questi ultimi mesi dalla municipalità per le vittime del Califfato.
«Stimiamo che sia la più grande delle fosse comuni di Raqqa», spiega il capo degli operai in tuta blu. Potrebbero essere tra i 900 e i 1.100 i corpi nelle tombe singole.
Sul lato opposto del podere del Centro agrario avvenivano le esecuzioni di massa dei civili. «Non abbiamo ancora iniziato a scavare, ma dovremmo trovare delle grandi fosse con una quarantina di corpi tutti assieme». Si stima che potrebbero esserci altri 2.500 cadaveri. In questi casi nemmeno una precisa catalogazione è possibile.
Ci sarà una azione legale, si aprirà un processo internazionale per questi crimini contro l’umanità? «Non so. Forse», ti risponde il capo del Quick responce team. La stessa risposta alla municipalità di Raqqa, dove nessuno pensa a rivolgersi a una autorità internazionale: «Appena arrivati abbiamo rimosso le teste mozzate conficcate nelle cancellate. Adesso la gente vuole dimenticare», risponde Sena Hassan al-Hamed, la giovanissima copresidente della municipalità.
Chi non riesce a dimenticare è il dottor Asaad Muhammed: «Ero presente a Raqqa durante la dominazione del Daesh: cercavo di lavorare di nascosto per salvare le persone. Prima ho sofferto tanto per questo lavoro. Ora per me è diventata una attività normale», conclude con il volto inespressivo.
Ormai è quasi mezzogiorno, il turno di lavoro è finito. Un operaio in tuta blu, seduto all’ombra di un secondo filare di alberi, prega Allah rivolto alla Mecca. L’unico gesto di misericordia mentre le tre donne nel podere accanto, curve a terra, continuano a raccogliere nel silenzio ortaggi. Un silenzio che pare inghiottire Fikherka, la porta dell’inferno di questo XXI secolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA