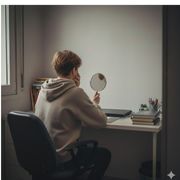"A spasso per Torino con mio figlio autistico"
Possibile immaginare una città a misura di bambini autistici? Alberto Vanolo, docente di geografia politica, racconta le sue "passeggiate situazioniste" con Teo. Per riflettere e denunciare

Un padre e un figlio in giro per la città di Torino che cosa hanno da raccontarci? Partiamo da questa domanda, apparentemente ordinaria, per sfogliare il bel libro, appena edito da Einaudi, dal titolo La città autistica, scritto da Alberto Vanolo, professore di Geografia politica ed economica all’Università di Torino. L’autore, alternando un tono colto a uno più caldo e sentimentale, senza perdere di vista neanche accenni di ironia, ci racconta alcune scene di vita urbana con suo figlio Teo, che ha una diagnosi di autismo. Le pagine di Vanolo descrivono giornate con “passeggiate situazioniste” o con curiose “esplorazioni psicogeografiche”.
Che cosa indicano questi termini? Al di là delle definizioni, Vanolo, da scienziato e da padre, spiega come la branca della psicogeografia, decisamente accanto ad aspetti più strettamente pedagogici, è un insieme di tecniche e strategie per l’esplorazione dello spazio urbano, che mira a enfatizzare l’idea di perdersi e aprirsi alla casualità degli incontri e delle possibilità. Lo strumento cruciale della psicogeografia è rappresentato dalle cosiddette “strategie di deriva”: camminare, perdersi, passare improvvisamente in spazi urbani differenti, sovvertire i significati e gli usi dello spazio, attraverso capovolgimenti di senso. Queste strategie possono rappresentare un buon modo per ripensare le nostre città, anche in relazione ad alcune disabilità, tentando di garantire una maggiore libertà di movimento a chi ha delle difficoltà nella gestione dello spazio.
“L’idea di una città autistica – precisa Vanolo – non riguarda solamente le dimensioni sociali e culturali e non si riduce alla necessità di educare e far maturare una cittadinanza tollerante, inclusiva, informata e aperta alle molteplici forme di neurodiversità, o di garantire alle persone autistiche l’accesso a spazi, risorse, esperienze e servizi. Il progetto ha una dimensione politica assai più radicale, che riguarda l’invocazione di un diritto alla città, l’orgogliosa affermazione di una presenza e di una differenza, il confronto fra modi radicalmente diversi di fare le cose e di vivere lo spazio urbano”.
Andando nel concreto della quotidianità, il padre descrive alcune giornate con suo figlio Teo, incontrando soggetti e situazioni che costruiscono discorsivamente la loro realtà, proprio come quando ci si ritrova dinanzi alla classica domanda “lei ha un figlio autistico?”, accanto a stupide considerazioni, come “mi spiace, che peccato”.
Quale potrebbe essere allora la tentazione di un padre, se non quella di mimetizzare le neurodivergenze di un figlio, per non risultare troppo al centro dell’attenzione? Al contrario, in altri casi, si potrebbe essere tentati di enfatizzare le differenze, pur sapendo, però che l’atteggiamento più naturale è quello di non fare o dire nulla, né per evidenziare, né per dissimulare.
Al tempo stesso, però, quest’atteggiamento non deve corrispondere a un lassismo e anzi dovrebbe perseguire, con forza, l’idea che la questione della riconoscibilità dello spazio pubblico non è marginale, altrimenti si rischierebbe di perdere di vista caratteristiche fondamentali delle neurodivergenze, che hanno la necessità di essere tutelate e accolte, affinché nulla sia incompatibile con la vita sociale. Tutto questo equivale a dire che c’è la necessità di un patto sociale, in grado anche di valorizzare le peculiarità delle persone autistiche e non solo.
Qui il professor Vanolo, pensando a suo figlio e a tantissimi altri bambini e ragazzi, conclude che, spesso, i temi riguardanti le disabilità dovrebbero partire da una riflessione ineludibile, anche se dura: vi è una base di coercizione e di insistenza, nei processi di insegnamento, che si deve considerare ineliminabile (tanto in ambito educativo, tanto in quello familiare).
“Mio figlio Teo – dice l’autore- oggi ama andare in bicicletta, ma per raggiungere questo traguardo non si è trattato di imparare con calma, attraverso errori e piccoli tentativi, come suo fratello. Per lui è stato un processo estenuante, in cui lo costringevo a prove quotidiane e imposizioni, che generavano i suoi rifiuti e, occasionalmente, anche rabbia. Solo al termine di quel percorso di apprendimento, molto faticoso, l’andare in bicicletta è diventato per Teo un piacere”. La giusta modalità, secondo altri, potrebbe essere, invece, un insegnamento che ridimensioni la parte impositiva, rispettando maggiormente la soggettività, come nel caso delle famosissime tecniche ABA, basate su una ingegneria comportamentale scrupolosamente mirata, in grado di rinforzare alcuni schemi di comportamento attraverso piccole ricompense.
Esistono, anche qui, delle perplessità, poiché, come sottolinea Vanolo, spesso è fin troppo semplicistico immaginare che si tratti di un intervento misurabile in assoluto, come se non si tenesse ben in conto la sfera emozionale della specificità della persona. Torna qui al centro l’idea, più complessa e sfaccettata, di una città autistica, che sappia considerare anche l’esigenza, per alcune persone neurodivergenti, di limitare l’intensità degli stimoli sensoriali nello spazio pubblico, a partire da quelli visivi e acustici. E’ ben noto che alle persone autistiche piacciono gli spazi piccoli e controllabili, per cui gli interventi di design urbano e salute pubblica non dovrebbero ignorare questa caratteristica, peraltro confortevole e salutare anche per tutte le altre persone, spesso fin troppo drogate dal caos circostante.
Queste pagine vogliono suggerirci l’idea che il contatto con le persone autistiche potrebbe permettere di sovvertire alcuni assunti di base, per imparare a guardare in maniera nuova (o forse antica) alle nostre città, riuscendo a valorizzare nuovamente la lentezza, il tempo dilatato, un frammento di un’esperienza bella ripetuta tantissime volte, solo per il piacere di rivivere un momento lieto. Questi comportamenti non renderanno Teo, o altre persone con neurodivergenze, delle persone migliori, ma saranno, un giorno, le città stesse a essere migliori, sapendo guardare, con attenzione, a chi ha delle percezioni diverse dalle nostre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA