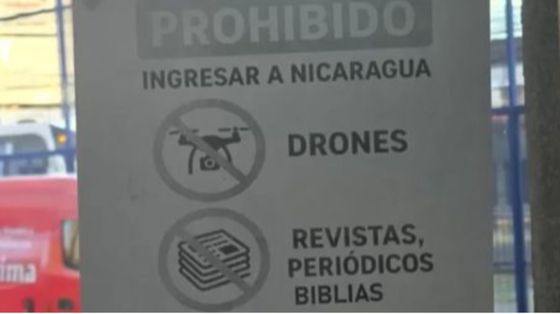La “maturità” è solo annuncio di prove più grandi
Oltre quarant’anni di mezzo, figli, lavoro, malattie: eppure il linoleum verde dell’Aula magna del Liceo Parini di Milano, e le mie scarpe da tennis bianche che scalciavano impazienti in attesa delle tracce di italiano, sono ancora qui, nei miei occhi. I banchi disposti lontani fra loro, e da un banco all’altro sguardi di naufraghi. Non avevo dormito quella notte, per il gran caldo – l’afa lombarda di quando non c’erano i condizionatori, e solo da una finestra aperta si sperava un refolo di vento. Non avevo dormito, in realtà, anche per la cattiva coscienza di alunna svagata e irrequieta. A mezzanotte, rassegnata – l’ignoranza ormai evidentemente irrimediabile – presi un libro a caso dal comodino. Lo lessi fino all’alba: Uno, nessuno, centomila, Pirandello. La prima traccia letta dalla presidente di Commissione, il mattino dopo: Pirandello. Che un Dio pietoso aiutasse i somari?, mi chiesi sbalordita. La mia penna prese a correre sul foglio protocollo nell’aria silenziosa e bollente dell’Aula nagna. E dunque, al tema pensò la Provvidenza. Alla traduzione dal greco, no: mi sentivo un disperso in mare che risalga centimetro per centimetro una corda logora, verso la murata. Consultavo freneticamente il dizionario, un severo Rocci che non collaborava affatto. («Traduzione creativa», commentò poi un commissario, ironico). Volle la sorte però che venisse estratta per gli orali la “D”, e dunque la mia “C” ultima. Un paio di settimane per rattoppare i buchi peggiori. Di materie, allora, se ne portavano solo quattro (erano i tempi in cui la scuola che chiedeva troppo era “fascista”). Io avevo scelto italiano, e pregavo ardentemente per filosofia come seconda. Andò così, altrimenti sarei ancora su quel banco ad arrancare su una qualche maligna equazione di fisica, di quelle tutte incognite e potenze che mi si ingarbugliavano fra le dita sudate, per finire inesorabilmente in un numero periodico gonfio di zeri. Avevo veramente paura, in quel mattino di luglio, se in bicicletta verso scuola pensai: un piccolo incidente, appena un braccio rotto, e darei l’esame a settembre, e avrei il tempo per aprire le pagine vergini dei libri di chimica, algebra, trigonometria. Fra Leopardi e Kant, invece, me la cavai con dignità. Ma quel fortunato Pirandello mi aveva procurato un nove in scritto. Mio padre ne fu orgoglioso – non gli raccontai com’era andata. L’alunna sempre altrove con la testa se ne uscì dalla maturità con un ottimo, non meritato, voto. La mia prima premura, a casa, fu di prendere i libri di algebra, chimica e fisica e buttarli nel bidone in cortile (come fosse ieri, quel “tumf” sonoro). Liberata, come chi si sia lasciata un temibile ostacolo alle spalle. Tenerezza, provo nel rivedermi con lo zaino della montagna nello specchio dell’ascensore di casa. A 19 anni, non sai. “Matura”: comincia la vita adulta. E tutto mi sembrava bello e accessibile, la vita intera da scrivere. Gli stessi occhi avevano gli studenti in tv l’altro giorno, all’uscita dei licei. Non bisogna dirlo a quei ragazzi, che dopo sarà tutto un continuo misurarsi, col lavoro, con le difficoltà, con le persone amate: provare, perdere, riprovare, ricominciare. Fino al giorno, lontano, di prove più dure. Allora, al ricordo di quell’esame sorrideranno. Come del primo giro in bicicletta, a cinque anni: quando finalmente si fila veloci, in equilibrio, quando finalmente ti credi “grande”. © riproduzione riservata
© RIPRODUZIONE RISERVATA