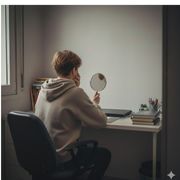«Volete aiutare i figli? Non risolvete i problemi al loro posto»
di Luciano Moia
Il pedagogista Fabrizio Travaini ai genitori: non dispensate i figli dalle fatiche per esentarli dalle sofferenze, ma stimolateli pretendendo impegno e fatica. Così saranno adulti responsabil

Sono pagine che danno speranza quelle di Fabrizio Travaini. Pagine che aprono a nuove prospettive nei confronti degli adolescenti, vittime di una vulgata che parla sempre e soltanto di disimpegno, di sballo, di ritiro sociale. Narrazione a senso unico che fa torto ai ragazzi e agli educatori. Perché quando riusciamo a coinvolgerli, quando decidiamo di affidare loro responsabilità adeguate, quando mostriamo che la loro sorte ci sta a cuore, quando concediamo loro il tempo necessario per crescere senza bruciare le tappe, scopriamo che Non sono cristallo ma diamante che è infatti il titolo del libro scritto dal pedagogista (sottotitolo, Adolescenti in un mondo terribilmente affascinante, In dialogo, pagg,151, euro 16) in cui sintetizza la sua esperienza di educatore in una comunità per minore, di insegnante in un istituto superiore, ma soprattutto di adulto che cerca di proporre ai ragazzi “sfide stimolanti, pennellate pedagogiche che accendano l’entusiasmo, non risposte ineccepibili ma – come si legge nel libro - domande giuste”.
Attenzione, il breve ma intenso saggio, la cui lettura sarà utile a chi frequenta quotidianamente ragazzi e ragazze impegnati nella terribile avventura di crescere nella nostra epoca confusa e contraddittoria, non propone ricette educative miracolose, non fa sconti sul piano dell’impegno necessario a comprendere e accompagnare gli adolescenti. Anzi, prima di arrivare ai capitoli propositivi, mette in fila quattro “elefanti” che ingombrano il cammino degli adolescenti, quattro trappole che dobbiamo imparare a conoscere per comprenderne il significato e aggirarne i rischi.
Primo “elefante”, quello che lei chiama “ricerca del senso perduto”, cioè il venir meno della religione come punto di riferimento. La fatica di educare alla fede riguarda tutti, genitori e catechisti in primis. Lei non nasconde le difficoltà ma si mostra convinto che non tutto sia perduto. Ma dove nasce questa convinzione?
Non mi sentirei di definirla una vera e propria convinzione, quanto piuttosto una speranza fondata sulla fiducia. I ragazzi e le ragazze che abitano ed esplorano questo mondo postmoderno, hanno indubbiamente messo in discussione i dogmi della fede cattolica e in larga misura abbandonato o lasciato in stand - by percorsi catecumenali pensati per loro. Le criticità legate all’incomunicabilità tra le nuove generazioni e l’istituzione Chiesa sono un dato che necessariamente deve farci interrogare turbandoci, muovendo dentro noi adulti quella sana inquietudine, che provano gli “smarriti di cuore”, tanto cara al cardinale Carlo Maria Martini. Credo sinceramente che questo sia il punto di partenza indispensabile. Ricominciare accettando la condizione di perdita di equilibrio che stiamo vivendo in primis noi adulti, storditi da questo scuotimento esistenziale, sempre più in difficoltà nello stare a galla in una realtà che ci ribalta voracemente come un mare in costante agitazione. Prendere consapevolezza che siamo i primi che arrancano faticosamente nella relazione col Signore, nella preghiera, nella presenza agli appuntamenti liturgici. Questo non per inasprire in noi sensi di colpa e scoramento, ma per meglio comprendere le priorità nella nostra vita come cristiani.
Rispolverare la promessa di sequela che abbiamo espresso in un lontano passato, quando da adolescenti o giovani abbiamo formulato la nostra regola di vita o quando l’impronta di Gesù si è indelebilmente scolpita nel nostro cuore. Inoltre, vorrei provocatoriamente evidenziare come il fenomeno di allontanamento degli adolescenti dagli oratori e dalla religione in particolar modo, non implica necessariamente il fatto che gli adolescenti abbiano perso interesse per la ricerca spirituale. Le domande di senso sulla vita e sull’universo, abitano il cuore dell’uomo sin dalla Rivoluzione Cognitiva dell’Homo Sapiens, non sono prerogativa esclusiva di una specifica religione. Dunque, nonostante gli adolescenti interpretino spesso i sacramenti e le funzioni religiose come mero appannaggio delle generazioni passate, il loro cuore continua ad anelare ardentemente un senso in questa esistenza e qualcosa in grado di riempirla, che possa veramente essere percepito come sacro. Come ho sottolineato nel libro, la forza della Tradizione, le Sacre Scritture e l’impalcatura liturgica cristiana cattolica tanto care alle generazioni passate, non possono essere trasmesse ai nativi digitali mediante le stesse identiche modalità, pena l’attuale diaspora. A tal proposito, la mia fiducia si fonda sull’idea che la Chiesa troverà il coraggio e l’entusiasmo di avvicinarsi e parlare alle generazioni contemporanee, senza demonizzarle o assecondarle passivamente, ma trovando la sua peculiare proposta di autentica ricerca della Verità, come già da due millenni ha dimostrato di saper fare quando le tempeste imperversano.
Un altro “elefante” da lei indicato è rappresentato dalla società della performance, l’obbligo di riuscire a tutti i costi, di essere sempre i primi. Cosa dire ai ragazzi per smontare questo inganno che fa stare male loro e noi?
Possiamo certamente rivolgere loro domande apparentemente retoriche, ma che in realtà possono aiutarli a prendere consapevolezza di quello che ormai è a tutti gli effetti un problema molto serio. “Vuoi riuscire a tutti i costi in che cosa? Vuoi essere il primo dove? Devi farcela per forza per chi? Non esiste nessuna gara”. Non vi è alcuna corsa all’oro per cui valga la pena trascinarsi fino allo sfinimento. Non esiste alcun premio finale che possa farci sentire ripagati degli immani sforzi che abbiamo messo in campo per cercare di raggiungerlo, a maggior ragione se quello che abbiamo inseguito spasmodicamente era solo un bisogno indotto da qualcun altro (social network, influencer, pubblicità, aspettative dei genitori). Però serve che glielo comunichiamo con gli occhi, col corpo, con la testa, col cuore, con il nostro Dna. Tutto di noi deve trasudare autenticità quando rivolgiamo loro queste parole. Se vogliamo essere onesti fino in fondo possiamo riscontrare come già negli ultimi decenni si sono diffuse capillarmente anche all’interno delle mura domestiche delle pratiche educative che si muovono in questa direzione e che assecondano questo cambio di paradigma, non più legato alla prestazione. Il problema è che troppo spesso sono veicolate da adulti che nella realtà sono completamente immersi in vite frenetiche, iper competitive e profondamente concorrenziali. I nostri figli non recepiscono solo ciò che le nostre bocche pronunciano, ma anche e soprattutto ciò che gli trasmettiamo senza dire una sola parola.
Agli adolescenti serve vedere che noi adulti siamo i primi a non avere il terrore di fallire, di capitombolare rovinosamente e sbagliare. Nel libro espongo sei suggerimenti pedagogici che il fallimento può insegnarci. Altrimenti un innocuo quattro in matematica può scatenare una crisi di pianto senza precedenti, con conseguente attacco di panico per la reazione che avranno i genitori. È vitale far evaporare dalle spalle di questi ragazzi il macigno della performance. Non siamo perennemente sul palcoscenico di un reality show con dei giudici famelici pronti a divorarci o osannarci in base ai loro gusti personali. Ai nostri figli non possiamo instillare l’idea per cui bisogna sempre essere all’altezza, perché ogni lasciata è persa e una volta che il treno è passato non puoi farci più nulla. Al contrario siamo chiamati a fidarci di loro, anche e soprattutto quando i risultati scarseggiano o quando le paure sembrano prendere il sopravvento sui loro volti. Proprio perché non esiste nessuna gara e ogni figlio ha bisogni e tempi specifici per maturare, tempi che vanno rispettati e custoditi, mai forzati o “precocizzati” per non rimanere indietro. Fidarci che hanno le competenze e gli strumenti per poter affrontare la vita, proprio come abbiamo fatto noi da giovani e i nostri genitori, nonni, bisnonni, trisavoli e antenati prima di noi. Non credo dunque che la soluzione stia nel risolvere i problemi al posto loro o dispensarli dalle fatiche per esentarli dalla sofferenza, ma stimolarli pur pretendendo impegno e fatica perché questa è l’unica via che permetterà loro di diventare adulti consapevoli e responsabili.
Per superare l’“analfabetismo dialogico”, che ha come modello la contrapposizione violenta da talk show, il suggerimento da lei indicato è il ritorno alla lettura. Non le sembra un consiglio destinato all’insuccesso nel mondo giovanile dominato dalla legge dei social?
Negli ultimi anni si stanno moltiplicando casi di adolescenti che vivono stati depressivi ed ansiosi che nascono e si sviluppano proprio in seno ai social. Il costante paragone con i coetanei e le loro seconde vite virtuali, la rincorsa disperata per accaparrarsi followers, like, cuori e condivisioni, l’urgenza dell’approvazione sociale o il terrore del giudizio altrui sulla base della propria estetica “vetrinizzata” sui social, stanno diventando insopportabili per un numero sempre crescente di ragazzi e ragazze nauseati da queste realtà bidimensionali.
I social network non esistevano vent’anni fa e come tutti i fenomeni che si manifestano seguiranno anche loro un ciclo che è destinato inevitabilmente a trasformarsi. Nessuno può prevedere che traiettoria subiranno, se ancor più ascendente o clamorosamente decrescente, però ritengo essenziale non comprimere le nostre riflessioni sulla dimensione temporale presente. Non sapremo tra un decennio che variazione subirà il mondo dei social e che riconfigurazione vivrà la professione dell’influencer, ma potrebbero anche perdere l’enorme potere ed impatto che hanno sulle vite degli adolescenti di oggi, mentre credo di poter asserire con quasi l’assoluta certezza che ancora ci volgeremo verso Shakespeare, Dante e Dostoevskij in cerca risposte di senso che abbiano il sapore dell’immortalità e dell’universalità.
Infine, l’emergenza ambientale. Ne abbiamo parlato tanto, e con toni sempre allarmanti e catastrofici che adesso si moltiplicano i sondaggi sulla cosiddetta “eco-ansia” degli adolescenti. Invece di informare abbiamo creato le premesse per una nuova sindrome. Come superare questo errore educativo?
Raccontando una nuova storia. Una storia in cui il futuro lungi dall’essere una coltre di nubi minacciose è invece una promessa. Ma non più quella ingenua paventata nei secoli scorsi di un mondo alla totale mercè della nostra volontà dove tutto è a disposizione illimitatamente per l’uomo. Quel futuro edulcorato da ogni asperità è evidentemente irrealizzabile e i danni ambientali che abbiamo generato dalla Rivoluzione industriale in poi sono innegabili. La comunità scientifica ci sta chiaramente allarmando sulle possibili/probabili conseguenze del cambiamento climatico che ci vedranno coinvolti nei prossimi decenni e non sono certo rassicuranti, ma non per questo vanno negate o assurte a oracolo definitivo dell’Apocalisse e dell’inevitabile estinzione del genere umano. Mi spaventa questa narrazione catastrofista che sempre più spesso si diffonde nei canali dei vari social network e mass media. Ho la percezione che questa postura, da zombie viventi, nasconda il desiderio di una resa, la volontà di non fare l’immane fatica di ideare e poi realizzare un futuro alternativo.
Invece credo che anche questa enorme trasformazione ambientale potrebbe essere fonte di una nuova riformulazione della società, di un più equo e consapevole rapporto uomo/natura, della costruzione di paesaggi urbani ecosostenibili. Anche nel libro non mi sono addentrato eccessivamente nei minuziosi dettagli specifici della questione legata alla crisi ambientale, perché riconosco mestamente la mia mancanza di conoscenze e competenze tecniche. Ciò che mi sta a cuore è però sottolineare la questione precipuamente educativa che si cela dietro questa tematica. Siamo chiamati a porre in atto veri e propri gesti di maieutica socratica. Non possiamo fermarci al dato di fatto, al puro e semplice realismo. Altrimenti è inevitabile che la depressione e lo sconforto avranno la meglio. Ci serve grande coraggio e voglia di immaginare un mondo diverso. Forse la citazione potrà risultare datata e cringe, come direbbero gli adolescenti contemporanei, ma “noi non ci fermeremo, non ci stancheremo, di cercare il nostro cammino” per approdare ad una nuova Terra Promessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi