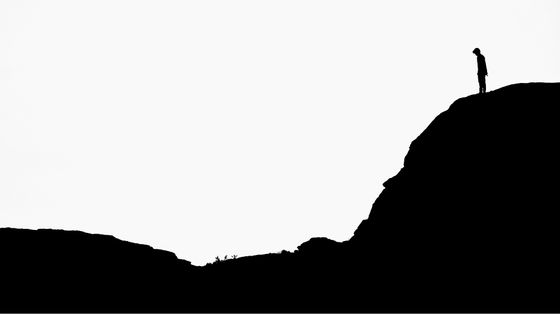Dell’inculturazione,con rosario o cellulare?
di Redazione
I nostri inseguitori si fermarono a poche centinaia di metri dalla loro città. Probabilmente avevano incrociato altri dei di passaggio. In ogni caso ebbi l’impressione che ci dimenticassero con rapidità pari all’entusiasmo con cui ci avevano accolti: eravamo dei messia, poi dei ladri da abbattere, poi più niente... Del nostro passaggio sarebbe rimasta solo quella pietra con incisa la mia espressione più stolida. Avanzavamo nella notte. Fratel Ugo si fermò vicino a un ruscello per pulire la corona del rosario, poi estrasse il suo telefonino. Non c’era campo neanche lì, e poco dopo il cellulare si spense definitivamente per l’impossibilità di ricaricarne la batteria senza elettricità. Dio ci aveva abbandonato? Il soggiorno presso i Barbelioti aveva ridimensionato di molto la mia disposizione al martirio. Mi sentivo ancora pronto a morire per Cristo, senza dubbio, ma non per mano di quella gente, non così, schiacciato sotto i cocci di centomila statue, cancellato dalla faccia della terra. Ai nostri giorni anche il terrorista più scarso può girare e diffondere ovunque i video dei suoi sgozzamenti. E io sarei stato assassinato crudelmente senza neppure a una piccola foto su Instagram. Torturato, avrei gridato nella mia agonia: «Viva Gesù!», con coraggio soprannaturale, e nessuno avrebbe catturato quell’istante per la posterità! Non parlo poi dei miei persecutori: a ogni modo avrebbero mal compreso la mia testimonianza. Per un paio di settimane avrebbero creduto che «Gesù» fosse una formula magica con proprietà afrodisiache, e poi avrebbero inventato un altro nome, con più consonanti e più sillabe. In quelle circostanze, se mi avessero crocifisso, il fastidio più grande che mi avrebbero dato i chiodi è che mi avrebbero impedito di farmi un selfie. Ci sono dunque martiri di cui non abbiamo conservato nessuna memoria? Dei Policarpi e delle Blandine senza Atti né Leggenda aurea e senza neppure la conversione dei loro assassini o degli spettatori del loro trapasso? Le loro parole sono finite nel dimenticatoio. Hanno fatto la fine di quei barboni anonimi che inciampano, annegano nel fiume e il loro corpo non torna più a galla. Nessuno sa che sono morti. E, a parte forse una madre alcolizzata, nessuno sa che sono vissuti. Gesù è probabilmente più vicino a queste persone che a quelli che si servono del patibolo come di una cattedra adatta alla magniloquenza. Certamente io non volevo essere come loro. Volevo darmi fino in fondo – a patto però che si sapesse… E poi rimproveravo a fratel Ugo di non avere avuto il genio dell’inculturazione. Dopo tutto era stata colpa sua, avrebbe potuto tenere un po’ di meno al suo rosario, lasciare che quegli uomini se ne servissero come gli pareva, per lo meno provvisoriamente, il tempo di adattarci ai loro strani costumi e di trovare il modo di comunicare il Vangelo in una forma appropriata. San Paolo sull’Areopago non aveva cominciato dicendo che Cristo era il “dio sconosciuto” che gli ateniesi già celebravano in un tempio empio? Matteo Ricci non aveva pazientemente imparato il cinese per poter discorrere del Salvatore di Israele? E noi, non potevamo tollerare per un minuto che i Barbelioti utilizzassero quella corona come un amuleto per condurli poi, rovesciando il senso della catena, dai loro amuleti alla corona, dai loro idoli all’Eterno? Fratel Ugo mi replicò con un grugnito. Gli veniva del fondo del cuore. Evidentemente, in quel momento, era la parola più caritatevole che poteva offrirmi. Ebbi all’improvviso un’idea luminosa. Dato che il suo cellulare non funzionava più, potevamo tornare dai Barbelioti e darlo loro al posto del suo rosario. Ne avrebbero fatto un altro dio della fertilità, più potente del precedente. Avremmo lasciato che si abbandonassero a questa idea, pur senza confermarla, guadagnando così la loro fiducia e il tempo per conoscerli meglio e annunciare loro un po’ alla volta la vera fede. Fratel Ugo protestò, ma cominciava a far freddo e non eravamo sicuri di trovare qualcosa per la colazione dell’indomani. Per sostenere il mio dire, adoperai queste parole infallibili: «Dobbiamo aprirci all’altro. Dobbiamo andare verso le periferie». Credo che avrebbe potuto strozzarmi in quell’istante. Per lui, non c’era dubbio, la periferia più estrema ero io. Tuttavia si arrese ai miei argomenti. Era anche d’accordo di cedere per un po’ la sua corona se per caso i Barbelioti avessero continuato a ritenerla un dio più potente del cellulare: «Si accorgeranno rapidamente che, al contrario di quanto pensano, nessuno dei due funziona, gli assicurai, e presto li ricupereremo. E dopo avremo ogni agio per insegnargli i rudimenti del catechismo». Ugo mi rispose con un altro grugnito che riassumeva abbastanza bene il suo pensiero. Sulla strada del ritorno, nella mia testa, ripensavo ai costumi particolari dei Barbelioti, elaboravo piani, riflettevo sulle strategie di evangelizzazione e pregavo il Signore di benedire la nostra perseveranza. Eravamo fuggiti, avevamo fallito la prima opportunità, ma ritornavamo umilmente da quei poveri idolatri da cui ci aveva mandato. Questa volta, col soccorso della sua grazia, saremmo riusciti a dar loro qualcosa di più che qualche immaginetta sacra… Ma non ritrovammo mai la strada di Barbel. Non la ritrovammo più. Quando, all’alba, in lontananza, in una radura della foresta, ci apparvero i fumi di un villaggio, erano quelli di un altro popolo. Con altri costumi e altri problemi.
(8, continua. Traduzione di Ugo Moschella)
(8, continua. Traduzione di Ugo Moschella)
© RIPRODUZIONE RISERVATA