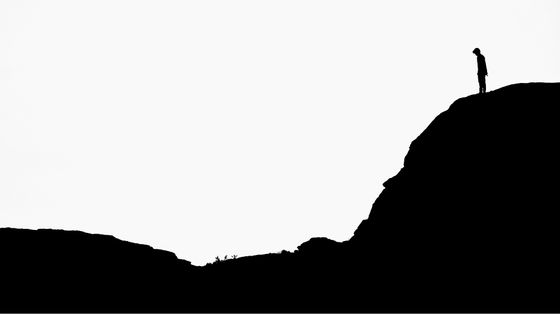È nel deficit di umanesimo la debolezza dei Paesi arabi
Petrolio, lavoro, tasse: riforme senza una base culturale: le monarchie del Golfo in cerca di nuovi assetti

Da qualche tempo il panorama mediorientale s’è arricchito, se ciò non suonasse beffardo, di un ulteriore elemento di instabilità. In effetti, le monarchie del Golfo persico sono sottoposte a uno stress sociale e politico prolungato che sta mettendo in crisi i loro sistemi di sviluppo, e quindi l’intera economia della regione, con le inevitabili ripercussioni politiche e talvolta anche militari. Può essere utile una rapida disamina dei singoli casi, a cominciare dal colosso dell’Arabia Saudita, che soffre d’un improvviso eccesso di febbre. Il dinamismo della stella ascendente di Mohammad bin Salman (soprannominato MbS), figlio del re attuale, primo vice-ministro, ministro della Difesa e principe ereditario ancora giovanissimo per le tradizioni saudite (ha solo 32 anni), pare contraddittorio: se da una parte accarezza i Paesi occidentali (ha il pieno sostegno di Donald Trump) con aperture quali la patente alle donne, l’apertura di cinema e una maggiore tolleranza religiosa, dall’altra apre, uno dopo l’altro, nuovi fronti di instabilità – Yemen, Qatar, Libano, Siria, Iran –, sapendo bene che i mercati, anche quelli del petrolio e del gas, detestano l’incertezza.
Schierati a fianco dell’Arabia Saudita, ecco Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti, che paiono assecondare le scelte del grande vicino. Paiono, perché ognuno di questi Stati ha in realtà i suoi problemi specifici e cerca di risolverli tirando sulla stessa coperta. Il Kuwait dell’emiro Sabah IV ha il problema degli stranieri che sono irrequieti e reclamano salari più alti; il Bahrein dell’emiro al-Khalifa deve fare i conti con la sua maggioranza sciita esclusa dal potere; e gli Emirati faticano a sostenere l’apertura ai mercati mondiali con solo il 12% di cittadini indigeni, mentre debbono stare attenti a non ingelosire i vicini, visto che il loro Pil è già più della metà di quello saudita (348 miliardi di dollari contro 646). L’Oman, da parte sua, resta defilato, privo o quasi di risorse petrolifere, e gode dell’ancora persistente simpatia del popolo per il sultano attuale Qaboos, che è riuscito a mantenere una relativa uguaglianza tra i cittadini, ma non ha eredi e invecchia rapidamente. Lo Yemen meriterebbe un capitolo a parte, primo perché non è una monarchia, secondo perché non ha ricchezze nel sottosuolo, terzo perché è in guerra per la secolare diatriba tra houthi e sunniti di cui recentemente ha fatto le spese l’ex-dittatore Saleh, campione di giravolte imbarazzanti pur di mantenere il potere.
Ancora più complesso è il caso qatariano guidato dall’emiro al-Thani: essendo il più dinamico come economia e soprattutto nella diversificazione degli investimenti, ha creato poco alla volta una frattura quasi insanabile coi suoi vicini. Le intese con l’Iran hanno ingenerato il sospetto di un trust tra i due Paesi, per la possibilità nemmeno tanto remota, dopo la sconfitta cocente dei sunniti in Siria, di far giungere il gas prodotto dai due Paesi direttamente nel Mediterraneo attraverso il cosiddetto 'corridoio sciita' tanto inviso ai sauditi, rendendolo molto più economico rispetto a quello delle altre monarchie del Golfo persico. Dopo cinquant’anni di denaro facile, tali monarchie conoscono anch’esse la crisi dovuta a un prezzo del petrolio non elevato come un tempo e destinato a diminuire ulteriormente. E ciò sia per la maggior offerta dovuta alla scoperta di immensi giacimenti (in Africa, in America Latina, persino tra Libano e Cipro) oggi sfruttabili con le nuove tecnologie di estrazione, sia per l’orientamento dell’industria automobilistica mondiale verso l’ibrido e l’elettrico. Senza dimenticare che i produttori di petrolio sono costretti a mantenere i prezzi più bassi di quanto sarebbe normale per evitare che il petrolio da scisto diventi concorrenziale. L’ultimo dato a disposizione sui fondamentali dell’economia della penisola arabica, nemmeno ipotizzabile anche solo qualche mese fa, parla di un’Arabia Saudita in recessione, con un arretramento di mezzo punto percentuale del Prodotto interno lordo nel 2017. È poco, ma è l’indicatore tanto temuto di un’inversione di tendenza. Non bastano più le diversificazioni negli investimenti dei fondi sovrani delle singole monarchie, operazione attuata da tutti i regnanti seppur in ritardo rispetto al Qatar, per sperare di godere anche in futuro della stessa opulenza sfacciata del recente passato.
Ma c’è di più. Delle società che vivevano sì sul petrolio e sul gas, ma anche sul lavoro sottopagato degli stranieri (26% in Arabia Saudita, 54 in Bahrein, 69 in Kuwait, 82 negli Emirati e addirittura 87 in Qatar) si trovano a dover allontanare i lavoratori stranieri – soprattutto provenienti dal subcontinente indiano e dalle Filippine –, perché cominciano a costare troppo e per giunta inviano all’estero la massima parte del loro reddito, senza consumare nulla o quasi nella penisola. Ma, cosa ancor più grave, i governi debbono 'costringere' i propri cittadini (udite, udite) a pagare le tasse che ora sono costretti a introdurre e addirittura a lavorare, verbo sconosciuto a gran parte di essi, alle donne ma anche agli uomini: Muhammad bin Salman, ad esempio, ha dichiarato che tra vent’anni non ci dovranno più essere lavoratori stranieri in Arabia Saudita. Proprio in Arabia ed Emirati è appena stata introdotta una tassa del 5% simile alla nostra Iva. Ciò sta ovviamente caricando di problemi le popolazioni autoctone, evidenziando non solo i nodi economici e finanziari, ma anche il deficit culturale, soprattutto in ambito umanistico. Si trovano attualmente informatici sauditi, ingegneri qatariani e medici del Kuwait che studiano o hanno studiato all’estero, ma è estremamente difficile assumere insegnanti di lettere locali, storici, psicologi, in altre parole 'umanisti'. Esistono pochissimi istituti universitari per la trasmissione della cultura beduina, solo recentemente valorizzata in taluni Paesi, soprattutto a fini turistici. Il trionfo della tecnologia ha creato enormi città 'fake & glamour', ma senza una vera identità. La stessa religione islamica s’è ancorata alla tradizione wahhabita, ma senza quegli strumenti di ermeneutica dei libri sacri che appaiono più che necessari per avviare le riforme necessarie, in tutti i campi.
Ecco quindi la difficoltà a capire la crisi presente e quindi a modificare i comportamenti delle popolazioni indigene e di cambiare le sue prospettive. La vera riforma vincente per le monarchie del Golfo persico starebbe proprio nella rinascita di un umanesimo arabo – se si vuole anche importato dall’Egitto o dal Libano – che valorizzi quel che resta delle culture locali. I quattro maggiori problemi dello sviluppo delle monarchie del Golfo persico non sono tanto economici, quanto umanistici: la conflittualità tra sciiti e sunniti (un problema eminentemente religiosoumanistico, oltre che politico); la concezione feudale non solo del lavoro manuale ma di ogni impegno che richieda fatica (anche ciò avrebbe bisogno di un sostrato filosofico non secondario); la questione religiosa di come passare dal wahhabismo a una visione tollerante della fede (tema da teologi, psicologi e sociologi); e la necessità di una nuova 'umiltà diplomatica' (che nasce dallo studio della storia). La prima riforma da fare sulla costa occidentale del Golfo persico dovrebbe riguardare proprio gli studi umanistici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA