Volti, gesti e silenzi dal Marocco: così senza paure si tiene la mano di Dio
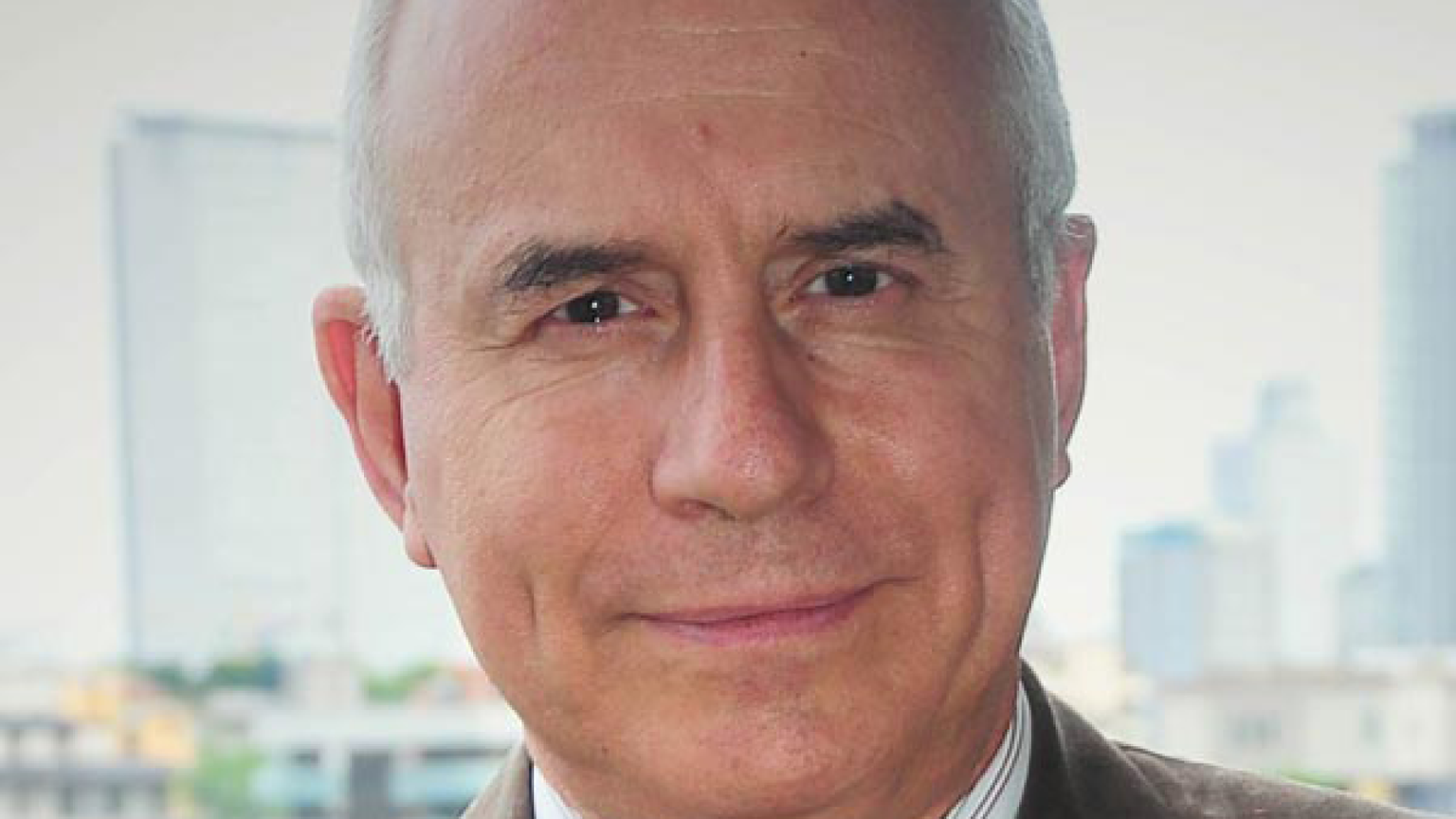
Il coinvolgente racconto di uno scalabriniano, missionario in terra di cultura musulmana, fa vedere e capire l’umile, quotidiana testimonianza e la preghiera di cristiani fedeli al Vangelo della gioia e ai poveri
Caro direttore,
Gabriele, spagnolo, anzi basco, vecchio avvocato, è stato per più di vent’anni collaboratore di Madre Teresa di Calcutta. Passa qualche giorno al monastero trappista di Midelt, sull’altopiano marocchino dell’Atlas (o dell’Atlante). Vi è come di casa e mi mostra il passaporto: quindici visti di entrata in Nepal, quasi altrettanti per l’India. Mi consegna il suo libro sulla grande Santa dei poveri, vista (da lui) da vicino. Qualche sua foto, con un grembiulone insieme con lei e dei lebbrosi, me la indica con orgoglio ed emozione, quasi fosse un trofeo. Mi parla della povertà. «La ricchezza, i soldi ci tradiscono – ripete più volte –. Sì, l’esempio della povera gente, dei piccoli... va bene. Ma, nella Chiesa, l’esempio dovrebbe venire sempre dai responsabili. Finché non c’è questo... non si farà nulla!», sostiene categorico. Così, è stato il gesto dei sette monaci trappisti, martiri di Tibhirine, ormai beati tra i santi. In una cappellina, dedicata a loro, qui notte e giorno palpitano luminose sette piccole luci, un grande ritratto di ognuno, e le preghiere scritte da chi passa... Ma soprattutto il testamento spirituale, originale, redatto con le sue stesse mani da Christian, il priore. E quella forza inaudita di perdono, che ha stupito il mondo. Ma un tale gesto fraterno di umiltà e di perdono si incontra spesso tra i sacerdoti di qui, in Marocco.
Prendendomi delicatamente sottobraccio, père Daniel dice: «Dài, siediti qui, mi puoi confessare?». E l’altro giorno père Michel: «Senti, non partire, prima di avere ascoltato la mia confessione». Oppure, tempo fa un altro: «Fammi questo regalo...». E capisco subito dove vuole arrivare. Qui sembra di costatare l’umiltà e la fraternità di tutta una Chiesa, ritrovandole, poi, puntualmente, nell’animo di ogni suo figlio. Come se si fosse persa ogni traccia di onnipotenza. Questa terra educa all’umiltà, alla «sottomissione allo Spirito». Come invocava un monaco, giorni fa, facendo intravedere, in filigrana, una grande qualità del credente musulmano: la sottomissione a Dio. L’atteggiamento di umiltà è essenziale nell’incontro con l’altro, sottolineava un responsabile della Chiesa. Accennava alla consuetudine delle Organizzazioni occidentali di scendere in Africa, con tutta la loro onnipotenza, mentre invece è necessario inculturarsi, sentirsi corresponsabili, diventare sinergici con le strutture di qui: farsi piccoli. E per la Chiesa nel Maghreb? «Bisogna svuotarsi. Prendere il cammino della kenosis. Accettare di essere inefficaci. Non tanto dirigere, ma piuttosto essere qui, presenti, in un Paese islamico. Solidali. E farlo, come il Cristo, fino in fondo».
Coerenza folgorante. Mi risuonano, allora, le parole di un vescovo venuto a Rabat: «Il centro di gravità della Chiesa non sta in sé stessa. Neppure nel suo rapporto con Dio. Ma sta nella relazione di Dio con il mondo, che ha tanto amato... (cfr. Gv 3,16) e in cui la Chiesa si fa serva e ministra». Sì, anche in e con questo mondo musulmano, di cui ci si fa compagni di viaggio. In una fraternità che prende il sapore del Regno di Dio. Mi sorprendeva giorni fa, su un tappeto appeso alla parete, nella comunità di suor Barbara, un foglio scritto a mano, attaccato con una spilla: «Evangelizzare qualcuno è dirgli: anche tu sei amato da Dio! E non solo dirglielo, ma pensarlo realmente. E non solo, ma far sì che nel modo di comportarti con lui senta che c’è in lui qualcosa di più grande e di più nobile di quello che credeva e risvegliarlo a una nuova coscienza di sé». Per i poveri del quartiere, che queste religiose incontrano ogni giorno, una scoperta semplicemente favolosa. E così, ancora una volta, nel cuore della notte, prima dell’alba, condivido la preghiera con i nostri monaci trappisti. Scendo nella semplice, accogliente chiesa monastica, cosciente di trovarvi dei testimoni di una vita nuova. Inedita. Quella di ogni nomade, di ogni migrante... Camminano sul filo del confine tra un mondo e un altro, tra una cultura, una lingua e un'altra, ben diverse, tra una religione e un’altra, immensamente differenti. Liturgia mista, allora, in francese e in arabo. Quando, però, iniziano i melismi e le melodie della lingua araba mi viene sempre come una stretta al cuore. So che è una lingua di cui i musulmani sono gelosi: lingua sacra, per eccellenza. Si trova sulla bocca stessa di Dio. Ma per i monaci è segno d’amore per questo popolo e per la sua cultura.
Alla fine della liturgia notturna, un trappista spegne tutte le luci e si rimane in un buio completo. Tutti fermi. Immobili. Si può restare così al buio anche più di mezz’ora. Questo tempo per Dio, tutti insieme, in un silenzio prolungato nutre la preghiera, ossigena la nostra anima. Ci fa toccare con mano la gratuità, la fiducia e la nostra povertà. E, naturalmente, la grandezza di Dio. Ci trasporta in quel luogo misterioso e privilegiato dell’incontro con Lui: il deserto dell’anima.
padre Renato Zilio, missionario a Casablanca
Gabriele, spagnolo, anzi basco, vecchio avvocato, è stato per più di vent’anni collaboratore di Madre Teresa di Calcutta. Passa qualche giorno al monastero trappista di Midelt, sull’altopiano marocchino dell’Atlas (o dell’Atlante). Vi è come di casa e mi mostra il passaporto: quindici visti di entrata in Nepal, quasi altrettanti per l’India. Mi consegna il suo libro sulla grande Santa dei poveri, vista (da lui) da vicino. Qualche sua foto, con un grembiulone insieme con lei e dei lebbrosi, me la indica con orgoglio ed emozione, quasi fosse un trofeo. Mi parla della povertà. «La ricchezza, i soldi ci tradiscono – ripete più volte –. Sì, l’esempio della povera gente, dei piccoli... va bene. Ma, nella Chiesa, l’esempio dovrebbe venire sempre dai responsabili. Finché non c’è questo... non si farà nulla!», sostiene categorico. Così, è stato il gesto dei sette monaci trappisti, martiri di Tibhirine, ormai beati tra i santi. In una cappellina, dedicata a loro, qui notte e giorno palpitano luminose sette piccole luci, un grande ritratto di ognuno, e le preghiere scritte da chi passa... Ma soprattutto il testamento spirituale, originale, redatto con le sue stesse mani da Christian, il priore. E quella forza inaudita di perdono, che ha stupito il mondo. Ma un tale gesto fraterno di umiltà e di perdono si incontra spesso tra i sacerdoti di qui, in Marocco.
Prendendomi delicatamente sottobraccio, père Daniel dice: «Dài, siediti qui, mi puoi confessare?». E l’altro giorno père Michel: «Senti, non partire, prima di avere ascoltato la mia confessione». Oppure, tempo fa un altro: «Fammi questo regalo...». E capisco subito dove vuole arrivare. Qui sembra di costatare l’umiltà e la fraternità di tutta una Chiesa, ritrovandole, poi, puntualmente, nell’animo di ogni suo figlio. Come se si fosse persa ogni traccia di onnipotenza. Questa terra educa all’umiltà, alla «sottomissione allo Spirito». Come invocava un monaco, giorni fa, facendo intravedere, in filigrana, una grande qualità del credente musulmano: la sottomissione a Dio. L’atteggiamento di umiltà è essenziale nell’incontro con l’altro, sottolineava un responsabile della Chiesa. Accennava alla consuetudine delle Organizzazioni occidentali di scendere in Africa, con tutta la loro onnipotenza, mentre invece è necessario inculturarsi, sentirsi corresponsabili, diventare sinergici con le strutture di qui: farsi piccoli. E per la Chiesa nel Maghreb? «Bisogna svuotarsi. Prendere il cammino della kenosis. Accettare di essere inefficaci. Non tanto dirigere, ma piuttosto essere qui, presenti, in un Paese islamico. Solidali. E farlo, come il Cristo, fino in fondo».
Coerenza folgorante. Mi risuonano, allora, le parole di un vescovo venuto a Rabat: «Il centro di gravità della Chiesa non sta in sé stessa. Neppure nel suo rapporto con Dio. Ma sta nella relazione di Dio con il mondo, che ha tanto amato... (cfr. Gv 3,16) e in cui la Chiesa si fa serva e ministra». Sì, anche in e con questo mondo musulmano, di cui ci si fa compagni di viaggio. In una fraternità che prende il sapore del Regno di Dio. Mi sorprendeva giorni fa, su un tappeto appeso alla parete, nella comunità di suor Barbara, un foglio scritto a mano, attaccato con una spilla: «Evangelizzare qualcuno è dirgli: anche tu sei amato da Dio! E non solo dirglielo, ma pensarlo realmente. E non solo, ma far sì che nel modo di comportarti con lui senta che c’è in lui qualcosa di più grande e di più nobile di quello che credeva e risvegliarlo a una nuova coscienza di sé». Per i poveri del quartiere, che queste religiose incontrano ogni giorno, una scoperta semplicemente favolosa. E così, ancora una volta, nel cuore della notte, prima dell’alba, condivido la preghiera con i nostri monaci trappisti. Scendo nella semplice, accogliente chiesa monastica, cosciente di trovarvi dei testimoni di una vita nuova. Inedita. Quella di ogni nomade, di ogni migrante... Camminano sul filo del confine tra un mondo e un altro, tra una cultura, una lingua e un'altra, ben diverse, tra una religione e un’altra, immensamente differenti. Liturgia mista, allora, in francese e in arabo. Quando, però, iniziano i melismi e le melodie della lingua araba mi viene sempre come una stretta al cuore. So che è una lingua di cui i musulmani sono gelosi: lingua sacra, per eccellenza. Si trova sulla bocca stessa di Dio. Ma per i monaci è segno d’amore per questo popolo e per la sua cultura.
Alla fine della liturgia notturna, un trappista spegne tutte le luci e si rimane in un buio completo. Tutti fermi. Immobili. Si può restare così al buio anche più di mezz’ora. Questo tempo per Dio, tutti insieme, in un silenzio prolungato nutre la preghiera, ossigena la nostra anima. Ci fa toccare con mano la gratuità, la fiducia e la nostra povertà. E, naturalmente, la grandezza di Dio. Ci trasporta in quel luogo misterioso e privilegiato dell’incontro con Lui: il deserto dell’anima.
padre Renato Zilio, missionario a Casablanca
Che cosa posso dire, caro padre Renato, di altrettanto limpido dopo le sue parole di vita e di vangelo e dopo il silenzio e la preghiera notturna che ha fatto respirare a me e a tutti noi? Che cosa posso aggiungere dal frastuono metropolitano che nel nostro sazio, saccente e bellicoso occidente s’accende anche nel sacrosanto week end, prologo e cuore di un tempo domenicale non più così felice? Attraverso il suo racconto ho visto i volti di donne e di uomini cristiani intenti a camminare il mondo e ad appartarsi da esso, sempre tenendo dietro al Signore della storia anche in luoghi che, qui, pensiamo radicalmente “altri”. E li ho visti farlo con fede, accanto ai poveri e, attraverso i poveri, tenendo la mano di Dio. Grazie, per averci aiutato a ricordare anche in questo modo che il compito dei cristiani è vivere liberi, cioè senza paure, dare ragione della propria speranza amando fratelli e sorelle, e perciò la giustizia, e fare pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA







