Anche il non-ascolto ferisce. Con Staino ci siamo ascoltati
Dal caso suscitato dall’accusa di antisemitismo a un leader politico (Conte) una studiosa trae due profondi messaggi. Il secondo mi aiuta ad abbracciare un amico
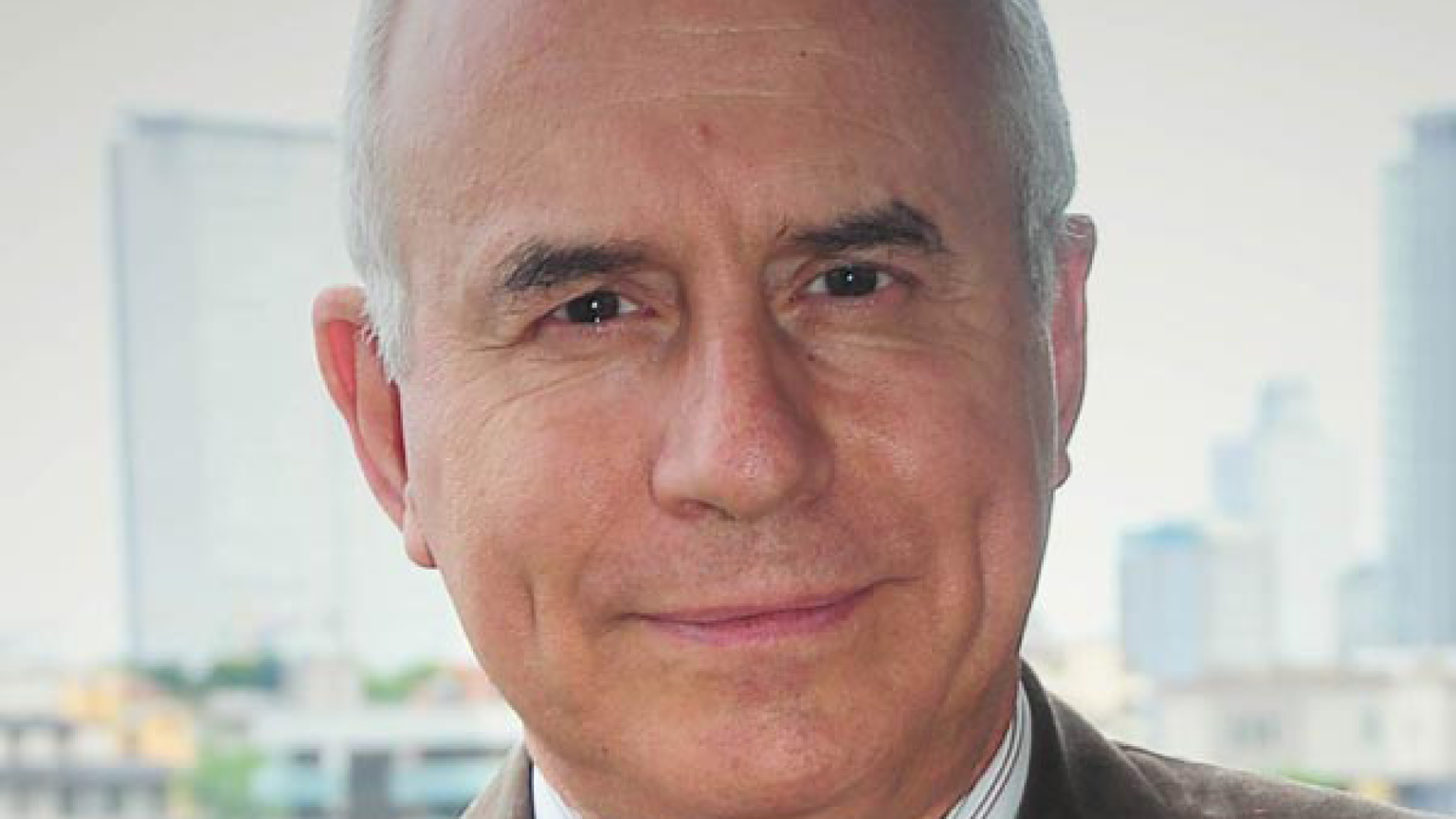
Dal caso suscitato dall’accusa di antisemitismo a un leader politico (Conte) una studiosa trae due profondi messaggi. Il secondo mi aiuta ad abbracciare un amico
Caro Tarquinio, mi ha molto colpito l’accusa di antisemitismo a Giuseppe Conte, giurista ed ex premier italiano, da parte di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. Ho analizzato in un libro la politica dell’attuale leader del M5s e non mi ha stupito che Conte abbia replicato al polemico invito a “a studiare”, per colmare una presunta scarsa conoscenza, richiamando ciò che disse nella visita al Tempio Maggiore di Roma il 18 gennaio 2019, quando definì l’antisemitismo «suicidio dell’uomo europeo».
Mi sono perciò proposta di estrarre il filo di quel discorso (si può ascoltare su YouTube) attraverso quattro opere di scrittori in esso citati: Stefan Zweig dal vecchio mondo asburgico all’avvento di Hitler e alla soglia della seconda guerra mondiale; Romain Gary per il periodo della resistenza partigiana; Paul Celan per l’espressione della catastrofe; Martin Buber per la motivazione aggregante e consapevole quale cifra di riscatto di un’umanità che non vuole perdersi. E ho deciso di affidare a lei questi pensieri forse troppo ampi per essere contenuti nella lettera a un giornale.
Mi sono perciò proposta di estrarre il filo di quel discorso (si può ascoltare su YouTube) attraverso quattro opere di scrittori in esso citati: Stefan Zweig dal vecchio mondo asburgico all’avvento di Hitler e alla soglia della seconda guerra mondiale; Romain Gary per il periodo della resistenza partigiana; Paul Celan per l’espressione della catastrofe; Martin Buber per la motivazione aggregante e consapevole quale cifra di riscatto di un’umanità che non vuole perdersi. E ho deciso di affidare a lei questi pensieri forse troppo ampi per essere contenuti nella lettera a un giornale.
«La libertà dell’agire privato era considerata legittima e sottintesa; la tolleranza non veniva come oggi disprezzata e ritenuta debolezza, ma esaltata quale energia morale», scrive Zweig nella struggente rievocazione autobiografica della società europea cosmopolita e colta che si suicidò nel primo conflitto mondiale. «Chi viveva e lavorava a Vienna si sentiva libero da ogni limitazione e pregiudizio. In nessun altro luogo era più facile sentirsi ed essere europeo e (…) apprezzare l’idea della fratellanza come la più alta e nobile nel mio cuore». Le pagine in cui Zweig descrive l’eccitazione dei viennesi alla notizia dell’inizio delle ostilità sono diventate celebri. Ma le ingenue illusioni vennero brutalmente smentite: «Tutti i cavalli dell’Apocalisse hanno fatto irruzione nella mia vita, carestie e rivolte, inflazione e terrore, epidemie ed emigrazione; ho visto crescere e diffondersi sotto i miei occhi le grandi ideologie delle masse, il bolscevismo in Russia, il fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in Germania, e anzitutto la peste peggiore, il nazionalismo, che ha avvelenato la fioritura della nostra cultura europea. Inerme e impotente, dovetti essere testimone dell’inconcepibile ricaduta dell’umanità in una barbarie che si riteneva da tempo obliata».
«Educazione europea» è il titolo del libro che Adam Dobranski, deuteragonista del romanzo di Gary, sta scrivendo mentre partecipa alla lotta partigiana polacca. Dobranski spiega ai compagni: «Educazione europea: in senso ironico, naturalmente. Per educazione europea intendo le bombe, i massacri, gli ostaggi fucilati, gli uomini costretti a vivere nelle tane come bestie. Ma io, vedi, raccolgo la sfida (…) La verità è che ci sono momenti nella storia, momenti come quello che stiamo vivendo, in cui tutto quello che impedisce all’uomo di abbandonarsi alla disperazione, tutto ciò che gli permette di avere una fede e continuare a vivere, ha bisogno di un nascondiglio, di un rifugio. Talvolta questo rifugio è solo una canzone, una poesia, una musica, un libro. Vorrei che il mio libro fosse uno di questi rifugi e che, aprendolo, alla fine della guerra, gli uomini ritrovassero intatti i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare (…) Raramente gli uomini falliscono, quando si tratta di avvicinarsi gli uni agli altri».
La grande poesia di Celan – in lingua tedesca, la lingua degli aguzzini – è testimonianza di sopravvivenza alla morte che le era destinata e attraverso la quale non ha potuto non passare. Dopo tutte le perdite rimane ancora raggiungibile il canto, la voce: Auschwitz non è indicibile, il problema è dargli la parola in quanto muto, e Celan vi riesce, spinto da un dolore senza rivalsa e senza risentimento; un dolore al quale pertiene una parola creata dal silenzio, conquistata tacendo (das erschwiegene Wort), un distillato dell’anima. L’eredità di Celan non è certo quindi il suo suicidio bensì la rivelazione stessa del senso della poesia: anche «nell’ora che non ha sorelle» rimane possibile concepire la libertà del passo che va verso l’altro, per amore di un incontro.
E si arriva quindi a Buber, sensibilissimo intellettuale socialmente e politicamente impegnato, che, riprospettando l’eredità del misticismo ebraico, ha definito l’etica come responsabilità situazionale dell’uomo, l’esercitarsi dello spirito nel contesto dato, lo sforzo di accettare il campo in cui si è – di gioie, di lavoro, di battaglie, anche disperate, come Giacobbe che fu scelto perché seppe lottare con Dio. Ecco il dialogo buberiano fra Dio e gli uomini: domande di un Assoluto incondizionato, severo e complesso, come severa e complessa è la realtà che ci mette alla prova. Ed ecco la scelta del rapporto con l’altro come “Esso” o come “Tu”. La società umana nasce dall’incontro dei tanti Tu, ed economia, politica, etica sono momenti creativi e aggreganti verso una progressiva concatenazione sociale, da sollecitare, valorizzare, incrementare. Al profondo di questo c’è un nesso di pensiero e azione, una motivazione a intendere la vita come dedizione totale. L’etica mistica ebraica parla proprio di un Mauf, la facoltà di volare al di sopra delle mediocrità, che non è di tutti e non si acquista facilmente, ma cui l’uomo può essere avviato e orientato.
Forse, caro Tarquinio, nel dibattito pubblico bisogna ascoltarsi di più e meglio.
Rita Bruschi, psicologa analista
E si arriva quindi a Buber, sensibilissimo intellettuale socialmente e politicamente impegnato, che, riprospettando l’eredità del misticismo ebraico, ha definito l’etica come responsabilità situazionale dell’uomo, l’esercitarsi dello spirito nel contesto dato, lo sforzo di accettare il campo in cui si è – di gioie, di lavoro, di battaglie, anche disperate, come Giacobbe che fu scelto perché seppe lottare con Dio. Ecco il dialogo buberiano fra Dio e gli uomini: domande di un Assoluto incondizionato, severo e complesso, come severa e complessa è la realtà che ci mette alla prova. Ed ecco la scelta del rapporto con l’altro come “Esso” o come “Tu”. La società umana nasce dall’incontro dei tanti Tu, ed economia, politica, etica sono momenti creativi e aggreganti verso una progressiva concatenazione sociale, da sollecitare, valorizzare, incrementare. Al profondo di questo c’è un nesso di pensiero e azione, una motivazione a intendere la vita come dedizione totale. L’etica mistica ebraica parla proprio di un Mauf, la facoltà di volare al di sopra delle mediocrità, che non è di tutti e non si acquista facilmente, ma cui l’uomo può essere avviato e orientato.
Forse, caro Tarquinio, nel dibattito pubblico bisogna ascoltarsi di più e meglio.
Rita Bruschi, psicologa analista
Ho letto con attenzione e ammirazione la sua lettera, gentile e cara dottoressa Bruschi, e ho deciso di fare un’eccezione a una regola che mi sono dato, consegnandole (non senza aver qua e là tagliuzzato il testo, spero con sufficiente garbo) tutto lo spazio di solito attribuito alle riflessioni dei lettori. La polemica da cui lei prende le mosse è in fondo il serio pretesto per due messaggi. Il primo attiene alla potenza e alla bellezza del contributo della cultura ebraica allo “spirito europeo”, il secondo ai gravi danni che fanno la mancanza di ascolto e la presunzione sulle idee e sulle conoscenze altrui, atteggiamenti che portano allo scontro. Quest’ultima riflessione mi consentirà anche di dire qualcosa su un amico, Sergio Staino, e sulla “scandalosa” collaborazione che avevamo realizzato qui ad “Avvenire”. Il mio modo per dargli, a una settimana dalla morte, ancora un saluto.
Il primo messaggio non ha bisogno, credo, di tante altre parole accanto a quelle che lei magistralmente offre. Tengo solo a ricordare di essere stato e di rimanere tenacemente tra coloro che si spendono per veder valorizzate le comuni «radici giudaico-cristiane» nella coltivazione e nello sviluppo del grande albero dell’Europa federale e della convivenza euromediterranea. È più che mai necessario confermarlo in una fase storica in cui terre e mari della speranza – dall’Ucraina a Israele e alla Palestina – appaiono sconvolti e invasi dai masnadieri dello “scontro di civiltà”, ma anche disertati da uomini e donne feriti da gesti e parole feroci e che perciò stentano a vedere e a fare oltre il dolore e al pur comprensibile risentimento e alla volontà di rivalsa. Eppur si deve.
È bene ascoltarsi, e capirsi. Senza pregiudizi, perché non serve complicare un esercizio d’umanità che, di per sé, già non è semplice. Ci sono persone che ascolteremmo per ore, perché la loro vita si specchia nelle parole, dando a esse luce. E ce ne sono altre che non ascoltiamo abbastanza e così perdiamo l’occasione di capire e di trovare punti di contatto e vie da percorrere insieme.
Ma qui, ora che l’onda dei ricordi di Sergio Staino s’è acquietata, voglio dire che almeno l’errore del non-ascolto e non-incontro il “padre di Bobo” e il sottoscritto non l’hanno compiuto. Ci siamo letti e ascoltati, e così ci siamo capiti e fidati. E, per un bel tempo della nostra vita professionale, lui, il disegnatore (e libero pensatore) Staino, presidente onorario dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, e io, all’epoca direttore di questo giornale di ispirazione cattolica, siamo stati compagni di strada. E pensate un po’ tutto è accaduto nel nome di Cristo, il Figlio di Dio in cui io credo, e il Figlio dell’Uomo che Sergio ha rivelato di amare con le strisce disegnate per “Avvenire” e con alcune memorabili interviste a Marina Corradi e Massimiliano Castellani. Sia lui sia io sapevamo in chi e dove vedere Gesù. Che lui disegnava molto umano, uno “Jesus” circondato da domande anche aspre e capace di battute, domande e parabole sorridenti o sconcertanti o persino urtanti (dice qualcosa, questo, a chi frequenta i Vangeli?).
Strisce graffiate e interpretate incarnando Cristo in questo mondo (e dunque anche nelle relazioni, umane e politiche di oggi). Per questo coraggio e questa libertà anche autoironica qualche suo amico dell’Uaar (non tutti) lo aveva “scomunicato” (mentre qualcun altro nei giorni scorsi ha semplicemente dimenticato di ricordare tra le sue passioni e le sue “eresie” pure questa). Alcuni cristiani (veri o presunti), invece, lo hanno “lapidato”, trascinando nella gragnuola di pietre e nella polvere tossica sollevata persino papa Francesco. Fino a spingere Staino e me a dire basta.
Quel non-ascolto ancora fa male, quelle presunzioni sentenziose (conservo lettere, messaggi, ritagli e invettive, ma non li rileggo) ancora dolgono. Così come fa bene pensare ai nostri incontri, alle telefonate, ai ragionamenti, alle confidenze, agli entusiasmi e alle arrabbiature condivise. Dall’America Latina, dove mi trovo, mando un abbraccio alla moglie Bruna, peruviana di nascita, e ai figli Ilaria e Michele. E a lui, che ora vede bene, una volta di più dico: «Grazie. Jesus sa chi sei, da dove sei venuto e dove volevi arrivare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA







