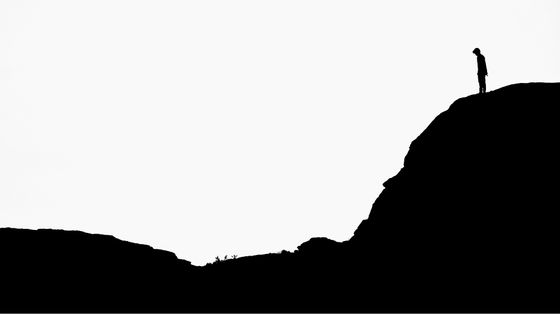Abou che aveva solo 15 anni sfinito da fame, sete e botte
Il corpo martoriato come quello del Cristo in croce, ma con la pelle nera

Aveva quindici anni. Aveva lasciato la Costa d’Avorio e attraverso il deserto era arrivato in Libia. Era stato detenuto e, raccontano le cicatrici sul suo corpo, torturato. Si era imbarcato a Zuara, con tanti altri. Soccorso in mare dalla Open Arms, era stato trasferito sulla nave Allegra. Dieci giorni in isolamento Covid. Ma Abou stava sempre peggio, aveva la febbre, non mangiava, non parlava più. Portato infine in ospedale a Palermo, è morto domenica scorsa.
Aveva quindici anni. Ci sarà chi dice: un altro nero, pazienza. Ma chi ha dei figli pensi a loro, nell’età in cui la prima barba si affaccia pungente sulle guance. Alti d’improvviso come adulti, gli si legge negli occhi l’incertezza e quasi la vertigine della brusca metamorfosi. Spesso, nella testa sono ancora quasi bambini. E dunque – benché Abou fosse nero, e straniero – facciamo uno sforzo di immaginazione: a quindici anni lasciare genitori e fratelli, per conquistare un mondo lontano e ignoto. Scelto per partire, forse, perché era il più forte e audace dei figli, perché lui ce la poteva fare a superare il deserto, la Libia, e il mare. Chissà com’è, a quindici anni, lasciare tutto, chissà che cosa si ha nel cuore. Deve essere un po’ come morire.
Lo sapevano i nostri bisnonni che s’imbarcavano per l’America. Noi, non lo sappiamo più. (Era un nero, un altro, pazienza). Abou viene trasferito sull’Allegra, secondo le denuncia alla Procura dalla tutrice cui, in quanto minorenne, aveva diritto, il 18 settembre. Resta a bordo fra centinaia di migranti in quarantena Covid per dieci giorni. Sono i compagni a dare l’allarme: ha smesso di mangiare e bere, è disorientato, febbricitante. Ha sulla schiena una piaga da decubito. Respira male. Non riesce più a parlare, ma quelle cicatrici sul suo giovanissimo corpo parlano per lui. Tutto il corpo di Abou in realtà racconta: la polvere e la sete del deserto, la prigione, le torture, l’acqua e il sole a ustionare la pelle, in alto mare. Il 28 settembre un medico dispone il trasferimento in ospedale. Abou approda in Italia. Il sogno è raggiunto, ma lui è in fin di vita. Inutilmente i mediatori culturali tentano di parlargli. Tardi, ormai. Abou cade in coma. All’ospedale Cervello di Palermo non c’è posto. Lo trasferiscono all’Ingrassia, dove domenica muore. La Procura ha aperto un’inchiesta. Si farà l’autopsia. Così sapremo esattamente di che è morto il ragazzo. Anche se temiamo di saperlo già: di infezioni accanite sul corpo sfinito da fame, sete, botte, paura, di un migrante poco più che bambino.
La nave in cui per dieci giorni è andato precipitando verso la fine, però, è territorio italiano. E un minore in Italia, anche straniero, ha diritto a ogni tutela. Ma forse non dentro la mischia di quelli che salpano da Zuara, raccattati in mare, tenuti in quarantena al largo, pensati da buona parte d’Italia come intrusi da rispedire a casa loro. Non hai più quindici anni, su questo Mediterraneo: sei soltanto uno straniero. Eppure quel corpo sfinito costellato di cicatrici, se lo vedessimo, non ci ricorderebbe qualcosa?
Qualcosa che, in Italia, abbiamo scritto nella memoria, prima di ogni appartenenza: le fattezze del Cristo in croce, martoriato. È un pensiero che istintivo si affaccia, sentendo questa storia, ma che in tanti siamo velocissimi a cacciare. (Vabbé, aveva quindici anni, ma era nero). E invece chiniamoci un momento ancora su Abou. Aveva gli occhi dei nostri figli adolescenti, e se ne era andato solo da casa, un giorno, in un addio triste come un presagio. Aveva quindici anni ed è morto di malattia e abbandono, in Italia. Quando credeva di essere arrivato in Europa, di essere salvo. A questo pensiero ti prende un senso di vergogna. E forse, intanto, in una casa in Costa d’Avorio c’è una madre che aspetta, ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA