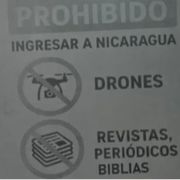La testimonianza: «Gli abiti del rapimento: la custodia della tua vita»
«Quando mi hanno liberata, avevo il niqab che mi aveva dato la mia carceriera. Non volevo gettarlo via. È complicato il rapporto tra te e chi ha in mano le chiavi della tua sopravvivenza»

Quando mi sono rivista allo specchio per la prima volta dopo quegli undici giorni nelle mani del gruppo dei miliziani di al-Nusra, da donna libera, non riuscivo a capire esattamente chi avessi davanti in quell’immagine riflessa. Ero io, sì, un po’ stanca un po’ sconvolta, con un cuore che sembrava stesse per scoppiare. Ma ero anche quello strano esperimento umano che la prigionia per mano di fondamentalisti islamici, che di islamico hanno ben poco, mi aveva fatto diventare. Sono stata con loro solo per undici giorni, in Siria nel 2013, ma sono bastati per rendere quell’immagine allo specchio di me un po’ sfocata. Avevo il niqab che mi aveva dato la mia carceriera e mi sembrava quasi un insulto buttare qualcosa che per lei era così prezioso.
È complicato il rapporto tra te e chi ha in mano le chiavi della tua vita, c’è un gioco di ruoli che permette di limitare imprevedibili cambi di scena. Non volevo gettarlo quel vestito. E non capisco perché, con incomprensibile mancanza di delicatezza, qualcuno abbia pensato che Silvia Romano avrebbe dovuto cambiarsi, buttando via in poche ore quell’immagine di sé a cui si è probabilmente abituata e affezionata in questi 18 mesi spesi in prigionia dentro appartamenti lugubri.
Gli abiti del rapimento non sono qualcosa che si sceglie, sono indumenti calati dall’alto, sono conquiste che possono fare la differenza tra la vita e la morte. È davvero incredibile vedere come il caso della liberazione di questa donna abbia portato l’attenzione solo su quello indossava, senza notare la genuina potenza del suo sorriso, che è sempre lo stesso, che non si è trasformato né con gli abiti, né con la religione, e spero, dopo questo periodo, neanche con le polemiche. Sotto il mio niqab, mentre facevo le prove della nuova me remissiva nella vita con al-Nusra, mi sono chiesta tante volte quanto tempo ci sarebbe voluto a cancellare la me preesistente. E quanto questo conflitto residuale sarebbe rimasto tra una donna intellettualmente libera e laica e un’anima sottomessa dedita solo all’obbedienza e alla preghiera.
Questo tempo di sperimentazione per fortuna io non l’ho dovuto vivere, sarebbe stato umiliante e per evitare l’umiliazione ce l’avrei messa tutta ad autoconvicermi che la nuova Susan meritava comunque di essere amata. Per me tornare indietro, in Italia, è stato semplice come se il nastro della mia vita si fosse solo inceppato. Ma in quel momento, davanti a quello specchio, in Turchia, ho visto le grinze di quel nastro. Mentre toglievo il velo dalla testa e sfilavo i vestiti della prigionia, qualcosa inconsciamente mi diceva che stavo sbagliando. Solo fino a poche ore prima ero con il mio aguzzino che selezionava i brani musicali nel mio cellulare stabilendo ciò che era peccato e ciò che invece era lecito.
Continuerai a fare le preghiere? O ti farai subito portare sulla cattiva strada dai tuoi amici infedeli?», mi chiese. Provate a immaginare la risposta. Togliere il velo per me è stata una scelta razionale. Sono una giornalista e conosco i media, le loro dinamiche, so quale potente mezzo di semplificazione possano essere. Sapevo che non avrei potuto dire qualcosa come: 'Sì porto velo, però... è complicato, ho bisogno di tempo'. La religione va separata dall’esperienza. Forse è solo questo di cui ha bisogno Silvia, solo di un po’ tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA