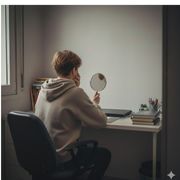«Non ridete quando c'è papà, potrebbe arrabbiarsi»
di Romina Gobbo
Così diceva ai figli Olga Granà, uccisa a colpi d'ascia dal marito pochi giorni dopo la separazione. Nei giorni scorsi durante un convegno a Verona la drammatica rievocazione del figlio

«"Ragazzi, mi raccomando, quando arriva papà, non ridete", questo ci diceva nostra madre. Non potevamo guardare nostro padre negli occhi. Vivevamo nel terrore». Giuseppe Delmonte è un “orfano speciale”, il termine che oggi si utilizza per indicare i figli delle vittime di femminicidio. L'abbiamo incontrato a Verona, al convegno intitolato “Quello che i bambini (non) vedono”, organizzato lo scorso 23 marzo all'Hotel San Marco dall'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. «Il titolo scelto, con il “non” tra parentesi, intende essere volutamente ambiguo - spiega Fortunata Pizzoferro, vicepresidente di un Ordine che riunisce 11.000 tra psicologi e psicologhe -. Richiama il fatto che, quando in famiglia c'è violenza, i bambini spesso cercano di chiudere gli occhi, di non sentire, per proteggersi, ma accade che anche i parenti, i vicini, fingano di non vedere. Così i bambini si sentono abbandonati nel sapere che molti adulti sanno ma non dicono, e possono finire col pensare che forse quella situazione è giusta, o magari se ne sentono colpevoli».
Come accadde a Giuseppe e ai suoi fratelli, per anni intrappolati nel rimorso. «Eravamo stati noi a dire a nostra madre di separarsi. Io avevo tredici anni allora, mio fratello e mia sorella erano già maggiorenni. Ormai eravamo grandi, non c'era più motivo di stare con quell'uomo che ci aveva distrutto la vita. Ventiquattro anni di soprusi, di minacce, di botte. E mai una denuncia, per paura della reazione. Quando insistemmo perché si separasse, lei ci rispose: “Se lo lascio, mi ammazza”. Ma noi, con la nostra spavalderia giovanile, la rassicurammo: “Non ti preoccupare, ti proteggeremo noi”».
Ma la scorta familiare non fu sufficiente. Seguirono cinque anni di stalking pesante, fino all'epilogo. 26 luglio 1997: Olga Granà, 51 anni, viene uccisa con sette colpi di ascia dall'ex marito, Salvatore Delmonte, davanti all'ufficio postale di Albizzate, nel Varesotto. Era andata a ritirare il vaglia postale di 500 euro che il giudice aveva imposto a Salvatore come accordo di separazione. Era il primo, non l'ha mai incassato, perché è rimasta lì sul marciapiede, uccisa con una brutalità inaudita.
«Quando il pubblico ministero ha mostrato le foto in aula, alcune giurate si sono sentite male», dice Giuseppe, che ricorda che in quel periodo per lui e i suoi fratelli «fu il buio totale. Eravamo rimasti completamente soli. Non c'erano tutele, non c'erano leggi specifiche, non esisteva neppure la parola femminicidio. Per le Istituzioni non esistevamo. Decisi di rimuovere tutto. Cambiai casa, amici e lavoro. Per vent'anni mi nascosi dietro la versione che i miei genitori erano morti in un incidente stradale. Non avevo né i mezzi, né la capacità per affrontare un dolore così lancinante».
«Fino a una trentina di anni fa la violenza assistita non era considerata, perché non comporta ferite esterne visibili - spiega Gabriella Scaduto, presidente ReDiPsi Reti di psicologi per i Diritti Umani -. Ma ci sono cicatrici anche sotto pelle. Parliamo di bambini che hanno perso entrambi i genitori, che spesso hanno assistito alla morte della madre per mano del padre, che a volte sono rimasti ore a vegliare il cadavere della madre. Perdono la rete sociale, perché vengono allontanati dal luogo della violenza, sono vittime di stigmatizzazione, di un sistema inadeguato, e a volte anche della narrazione mediatica. Il loro è un trauma dell'anima, rispetto al quale intervenire è complesso».
Oggi Giuseppe è un uomo di 48 anni che, grazie a un percorso psicoterapeutico, ha ritrovato un suo equilibrio. «Ma il trauma te lo porti dentro per sempre. Io lo chiamo ergastolo del dolore», dice. In Italia non esiste ancora un censimento ufficiale, ma le stime delle associazioni registrano circa 2.000 orfani speciali, di età varia. Giuseppe si batte per i loro diritti. «Le cose non sono molto cambiate dal '97. Ancora oggi muore una donna ogni tre giorni. C'è una legge, la numero 4 del 2018, ma male applicata, perché le vittime non vengono prese in carico immediatamente e per ottenere il sussidio ci sono lungaggini burocratiche estenuanti. Per fortuna ad alcune carenze dello Stato, suppliscono le associazioni. Si parla di orfani speciali perché manifestano bisogni speciali e quindi necessitano di risposte speciali. Sono bambini ai quali vengono rubati i sogni; sono bambini che impareranno a convivere col dolore, ma che non saranno mai più felici, perché la mamma è sempre la mamma».
Il padre di Giuseppe è in carcere. Al terzo grado di giudizio gli è stato riconosciuto l'ergastolo. «Ho trovato la forza per andare a visitarlo, perché volevo chiudere col passato. È rimasto lo stesso di allora, non si è mai pentito. Gli ho detto che non ci saremmo più visti, e lui per la prima volta ha abbassato lo sguardo. Lui ha vinto quando ha ucciso mia madre, ma quella volta lì ho vinto io. Non lo odio, non è cosa che mi appartiene, ma oggi lui mi è totalmente indifferente. Mentre uscivo e sentivo dietro di me chiudersi i cancelli, ho provato un gran sollievo. Da lì è cominciata la rinascita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA