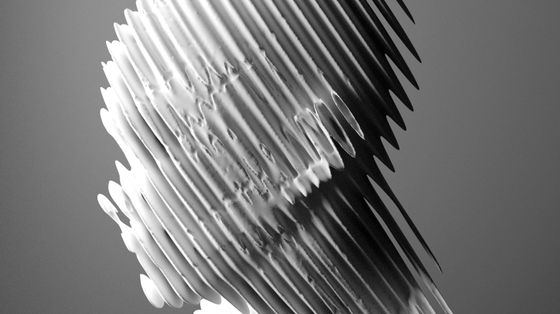La dolce vita di Pignatelli, il principe del jazz
Marco Molendini “riscrive” in un libro la storia del più irregolare dei jazzofili, quella del nobile amico Pepito che portò il grande jazz a Roma

«Le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo», canta Paolo Conte. Ma dopo aver letto la biografia, che non aveva bisogno di essere romanzata, del Principe Giuseppe “Pepito” Pignatelli, siamo certi che anche le donne cominceranno ad apprezzare il genere. Pochi conoscono la vicenda umana ed artistica di quest’uomo originalissimo di sangue blu che, da musicista e collezionista di vinili rari, ha introdotto il grande jazz a Roma, A rispolverare questa storia d’amore e di anarchia, pur se originata in un interno di antichissima famiglia monarchica, è stato il più aristocratico dei critici musicali: Marco Molendini, che, nel mondo del giornalismo (praticante a “Momento Sera” e poi storica firma del ”Messaggero”) è entrato anche grazie al suo amato Pepito al quale dedica un libro scritto di pancia e di cuore. Il Principe del Jazz (minimum fax. Pagine 215. Euro 16,00) conduce il lettore a spasso per i vicoli oscuri e le piazze più remote della Città Eterna, dove tra i sanpietrini si annidano ancora frammenti di memoria viva. Memoria musicale in questo caso, ma non solo, perché sono pagine lastricate di nomi di artisti ribelli, fuggitivi, ma soprattutto grandi sognatori. Un viaggio nel tempo, spiazzante quanto un quadro pop di Mario Schifano, un assolo al sassofono dell’argentino Gato Barbieri o del “Charlie Parker di Primavalle” Massimo Urbani o un cortometraggio a tema, Il blues della domenica sera di Valerio Zurlini: tutti e tre attori “non protagonisti” di questo “doculibro” imperdibile, a difesa della memoria della Roma che fu.
Un nostalgico quanto appassionante jam session sentimentale che prende il via in sella alla Vespa dell’allora studente universitario Molendini. Nell’estate, altrettanto torrida, del ’68, con il compagno di liceo, Alberto, sfrecciano capelli al vento verso l’Helio Cabala, «rifugio ormai fuori moda della Dolce vita». L’appuntamento di quella sera per jazzfan in erba era di quelli imperdibili. Di scena ci sono: «Enrico Rava che fuma come un turco e suona la tromba pensando in grande – scrive Molendini – ; Steve Lacy, rarissimo e superbo sassofonista soprano che vive a Roma, soprattutto di stenti; Franco D’Andrea, che al pianoforte trasforma la sua timidezza in fantasia e Marcello Melis, sardo sciupafemmine dal sorriso nuragico, contrabbassista di notte e dirigente di mattina». Ma a un certo punto i riflettori si illuminano sul vero protagonista di questa Roma undeground: «Pepito Pignatelli, principe e batterista, facendo leva sul fascino residuo dei suoi tanti cognomi (nell’albo di famiglia figura anche il Papa che abolì il nepotismo, Innocenzo XII, e un santo, Giuseppe Pignatelli di Fuentes) ha procurato quell’ingaggio improbabile nel deserto musicale di una città scossa nella sua pigra imperturbabilità, dai primi venti della contestazione». Una folgorazione per il giovane Molendini quell’incontro con un principe degli irregolari, che detesta essere appellato per il suo titolo nobiliare perché «non sopporta l’ipocrisia, i suoi avi aspiravano a diventare papi, cardinali, senatori, mentre lui non sa dove sbattere la testa».
Campa di sogni il rampollo del ramo decaduto dei Pignatelli, sempre a corto di lire, vende di nascosto cimeli di famiglia e spende gli anni ’50 suonando nel sestetto Hot Club di Roma formato dalla sua batteria, Nunzio Rotondo alla tromba, Franco Raffaelli (sassofono), Ettore Crisostomi (piano), Carlo Pes (chitarra) e Carlo Loffredo (contrabbasso). Come un gatto randagio, Pepito, sigaretta in bocca e bicchiere di whisky in mano, ha attraversato di notte le strade vuote del centro storico, dove incrocia Walter Chiari che gli dà la buona notte con tono da sarchiapone: «Principe, vai a dormire e rimboccati la lapide». Pignatelli si ritira sempre all’alba, dopo battute di “caccia” a starlette riempirotocalco come l’americana Ivy Nicholson e solo dopo aver chiuso i battenti, assieme ai proprietari, dei locali notturni. Quelli della Dolce vita che, “ufficialmente”, venne inaugurata due anni prima che Anita Ekberg facesse il bagno vestita nella fontana di Trevi per l’estasi, non solo registica, di Federico Fellini. La Dolce vita inizia il 5 novembre del 1958, la notte folle del Rugantino, il locale di Trastevere (in piazza Sonnino n. 40 al suo posto oggi c’è una banca) dove per il compleanno della contessa Olghina de Robilant, la ventenne ballerina turca Aichè Nanà passò alla storia per la sua danza senza veli. Cose mai viste prima nei nigth sotto il Cupolone e prontamente immortalate dagli obiettivi dei paparazzi. L’uomo della notte, Pepito, non era presente, ma solo perché ancora provato dai due anni passati al gabbio, a Regina Coeli, per via di una storia di droga in cui era coinvolta tutta quella baraonda di «patrizi tossicomani » per i quali, come scrive Gioacchino Belli, «er vizzio, già se sa, bisogna avello».
Pepito il vizio non se lo toglierà mai, ci convive disperatamente dentro la sua vita, a tratti dolce, spesso agra come quella di Luciano Bianciardi, ma in fondo un’esistenza da Bukowski romanesco del jazz. A salvarlo da guai peggiori provvede l’amore incondizionato di una donna eterea come Picchi Gallerati che gli scrive lettere appassionate durante le sue prigioni e una volta fuori convolano a nozze. Picchi è la donna che lo sopporta e lo supporta nella sua grande utopia: fare dell’antica Roma una capitale moderna del jazz. Le amicizie e il gusto estetico del talent scout a Pepito non gli mancano. Così dovendo rinunciare a un tour americano (che gli avrebbe fruttato 5 milioni a concerto e parecchia visibilità) con Romano Mussolini, il “Principe e il pianista Figlio del Duce”, decide che è tempo di portare gli americani a Roma. Con l’escamotage dell’associazione culturale, presidente Giovanni Tommaso e segratario lo stesso Molendini, nella poco raccomandabile via dei Cappellari, civico 74, apre il Blue Note. «Come la celebre cave parigina». Alla comunità dei jazzisti di Harlem esuli in Europa, arriva la notizia del locale del Principe romano, e così, nel piccolo club «sfilano» uno dopo l’altro quei virtuosi di primo piano come Dexter Gordon, Kenny Clarke, Johnny Griffin. E il grande amico Mal Waldron, con il quale riesce nell’intento di incidere il suo unico disco, Mal Waldron Trio, dagli esiti commerciali ovviamente fallimentari, ma almeno la consolazione dell’omaggio alla moglie: tra le dieci tracce figura Blues for Picchi. Sarà la stesa Picchi a incoraggiare Pepito a riprovarci quando il Blue Note finisce in malora (solite beghe giudiziarie) aprendo quel locale che sarà davvero l’ultimo avamposto poetico del jazz capitolino.
Dopo l’estate del ’73 in cui Perugia alza il sipario di Umbria Jazz, e tre anni prima dell’Estate romana ideata dal geniale assessore alla cultura, l’architetto e drammaturgo Renato Nicolini, Pepito si gioca la carta MusicInn. Sì, «come il locale del Massachusetts dove il Modern Jazz Quartet negli anni Cinquanta aveva registrato un bel disco con ospite Sonny Rollins, parte della sua collezione di 33 giri». Un covo dell’anima, scavato nell’Arciconfraternita dei Fiorentini («non chiamatela cantina!», si infuria il Principe) in cui come per magia si presentano tutti i giganti con piano, tromba, contrabbasso, batteria, clarinetto e custodia con sax. Bill Evans, Elvin Jones, Ornette Coleman, Mc Coy Tyner, Max Roach, Benny Goodmann, Chet Baker, Charlie Mingus, Tony Scott... Session documentate, per fortuna, da filmati delle teche Rai, così quelle serate uniche e forse irripetibili, ora si possono rivedere su Youtube. Al MusicInn c’è spazio per tutti, anche per le prime jazziste italiane (le pianiste Patrizia Scascitelli e Dora Musumeci) e Picchi, sostenuta da Nicolini, nel parco del Giardino di Villa Borghese lancia “La donna è una cosa meravigliosa”. Rassegna che voleva essere anche la risposta a quella misoginia dominante nell’ambiente, e che Duke Ellington espresse nel monito: «Il jazz è sempre stato simile al tipo d’uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse». Quel tipo di uomo, Picchi se l’era addirittura sposato, e dopo la sua morte (nel 1981) improvvisa quanto autolesionistica (Pepito aveva 49 anni ma i vizi l’avevano invecchiato precocemente) gli sopravvisse altri 12 anni. Da sola, senza eredi, ha tentato di mandare avanti il loro sogno comune fondato sul jazz, ma alla fine il male di vivere l’ha costretta alla resa e ha scelto di raggiungere il suo amato Principe azzurro, Pepito, il Principe del jazz.
Un nostalgico quanto appassionante jam session sentimentale che prende il via in sella alla Vespa dell’allora studente universitario Molendini. Nell’estate, altrettanto torrida, del ’68, con il compagno di liceo, Alberto, sfrecciano capelli al vento verso l’Helio Cabala, «rifugio ormai fuori moda della Dolce vita». L’appuntamento di quella sera per jazzfan in erba era di quelli imperdibili. Di scena ci sono: «Enrico Rava che fuma come un turco e suona la tromba pensando in grande – scrive Molendini – ; Steve Lacy, rarissimo e superbo sassofonista soprano che vive a Roma, soprattutto di stenti; Franco D’Andrea, che al pianoforte trasforma la sua timidezza in fantasia e Marcello Melis, sardo sciupafemmine dal sorriso nuragico, contrabbassista di notte e dirigente di mattina». Ma a un certo punto i riflettori si illuminano sul vero protagonista di questa Roma undeground: «Pepito Pignatelli, principe e batterista, facendo leva sul fascino residuo dei suoi tanti cognomi (nell’albo di famiglia figura anche il Papa che abolì il nepotismo, Innocenzo XII, e un santo, Giuseppe Pignatelli di Fuentes) ha procurato quell’ingaggio improbabile nel deserto musicale di una città scossa nella sua pigra imperturbabilità, dai primi venti della contestazione». Una folgorazione per il giovane Molendini quell’incontro con un principe degli irregolari, che detesta essere appellato per il suo titolo nobiliare perché «non sopporta l’ipocrisia, i suoi avi aspiravano a diventare papi, cardinali, senatori, mentre lui non sa dove sbattere la testa».
Campa di sogni il rampollo del ramo decaduto dei Pignatelli, sempre a corto di lire, vende di nascosto cimeli di famiglia e spende gli anni ’50 suonando nel sestetto Hot Club di Roma formato dalla sua batteria, Nunzio Rotondo alla tromba, Franco Raffaelli (sassofono), Ettore Crisostomi (piano), Carlo Pes (chitarra) e Carlo Loffredo (contrabbasso). Come un gatto randagio, Pepito, sigaretta in bocca e bicchiere di whisky in mano, ha attraversato di notte le strade vuote del centro storico, dove incrocia Walter Chiari che gli dà la buona notte con tono da sarchiapone: «Principe, vai a dormire e rimboccati la lapide». Pignatelli si ritira sempre all’alba, dopo battute di “caccia” a starlette riempirotocalco come l’americana Ivy Nicholson e solo dopo aver chiuso i battenti, assieme ai proprietari, dei locali notturni. Quelli della Dolce vita che, “ufficialmente”, venne inaugurata due anni prima che Anita Ekberg facesse il bagno vestita nella fontana di Trevi per l’estasi, non solo registica, di Federico Fellini. La Dolce vita inizia il 5 novembre del 1958, la notte folle del Rugantino, il locale di Trastevere (in piazza Sonnino n. 40 al suo posto oggi c’è una banca) dove per il compleanno della contessa Olghina de Robilant, la ventenne ballerina turca Aichè Nanà passò alla storia per la sua danza senza veli. Cose mai viste prima nei nigth sotto il Cupolone e prontamente immortalate dagli obiettivi dei paparazzi. L’uomo della notte, Pepito, non era presente, ma solo perché ancora provato dai due anni passati al gabbio, a Regina Coeli, per via di una storia di droga in cui era coinvolta tutta quella baraonda di «patrizi tossicomani » per i quali, come scrive Gioacchino Belli, «er vizzio, già se sa, bisogna avello».
Pepito il vizio non se lo toglierà mai, ci convive disperatamente dentro la sua vita, a tratti dolce, spesso agra come quella di Luciano Bianciardi, ma in fondo un’esistenza da Bukowski romanesco del jazz. A salvarlo da guai peggiori provvede l’amore incondizionato di una donna eterea come Picchi Gallerati che gli scrive lettere appassionate durante le sue prigioni e una volta fuori convolano a nozze. Picchi è la donna che lo sopporta e lo supporta nella sua grande utopia: fare dell’antica Roma una capitale moderna del jazz. Le amicizie e il gusto estetico del talent scout a Pepito non gli mancano. Così dovendo rinunciare a un tour americano (che gli avrebbe fruttato 5 milioni a concerto e parecchia visibilità) con Romano Mussolini, il “Principe e il pianista Figlio del Duce”, decide che è tempo di portare gli americani a Roma. Con l’escamotage dell’associazione culturale, presidente Giovanni Tommaso e segratario lo stesso Molendini, nella poco raccomandabile via dei Cappellari, civico 74, apre il Blue Note. «Come la celebre cave parigina». Alla comunità dei jazzisti di Harlem esuli in Europa, arriva la notizia del locale del Principe romano, e così, nel piccolo club «sfilano» uno dopo l’altro quei virtuosi di primo piano come Dexter Gordon, Kenny Clarke, Johnny Griffin. E il grande amico Mal Waldron, con il quale riesce nell’intento di incidere il suo unico disco, Mal Waldron Trio, dagli esiti commerciali ovviamente fallimentari, ma almeno la consolazione dell’omaggio alla moglie: tra le dieci tracce figura Blues for Picchi. Sarà la stesa Picchi a incoraggiare Pepito a riprovarci quando il Blue Note finisce in malora (solite beghe giudiziarie) aprendo quel locale che sarà davvero l’ultimo avamposto poetico del jazz capitolino.
Dopo l’estate del ’73 in cui Perugia alza il sipario di Umbria Jazz, e tre anni prima dell’Estate romana ideata dal geniale assessore alla cultura, l’architetto e drammaturgo Renato Nicolini, Pepito si gioca la carta MusicInn. Sì, «come il locale del Massachusetts dove il Modern Jazz Quartet negli anni Cinquanta aveva registrato un bel disco con ospite Sonny Rollins, parte della sua collezione di 33 giri». Un covo dell’anima, scavato nell’Arciconfraternita dei Fiorentini («non chiamatela cantina!», si infuria il Principe) in cui come per magia si presentano tutti i giganti con piano, tromba, contrabbasso, batteria, clarinetto e custodia con sax. Bill Evans, Elvin Jones, Ornette Coleman, Mc Coy Tyner, Max Roach, Benny Goodmann, Chet Baker, Charlie Mingus, Tony Scott... Session documentate, per fortuna, da filmati delle teche Rai, così quelle serate uniche e forse irripetibili, ora si possono rivedere su Youtube. Al MusicInn c’è spazio per tutti, anche per le prime jazziste italiane (le pianiste Patrizia Scascitelli e Dora Musumeci) e Picchi, sostenuta da Nicolini, nel parco del Giardino di Villa Borghese lancia “La donna è una cosa meravigliosa”. Rassegna che voleva essere anche la risposta a quella misoginia dominante nell’ambiente, e che Duke Ellington espresse nel monito: «Il jazz è sempre stato simile al tipo d’uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse». Quel tipo di uomo, Picchi se l’era addirittura sposato, e dopo la sua morte (nel 1981) improvvisa quanto autolesionistica (Pepito aveva 49 anni ma i vizi l’avevano invecchiato precocemente) gli sopravvisse altri 12 anni. Da sola, senza eredi, ha tentato di mandare avanti il loro sogno comune fondato sul jazz, ma alla fine il male di vivere l’ha costretta alla resa e ha scelto di raggiungere il suo amato Principe azzurro, Pepito, il Principe del jazz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA