Il conte Ugolino: cannibale sì, ma solo per contrappasso
di Carlo Ossola
Il brano della “Commedia” ha fatto pensare all’antropofagia, ma Dante mette il nobile pisano all’Inferno come traditore della patria mentre addenta il cranio di chi l’ha condannato a morte per fame
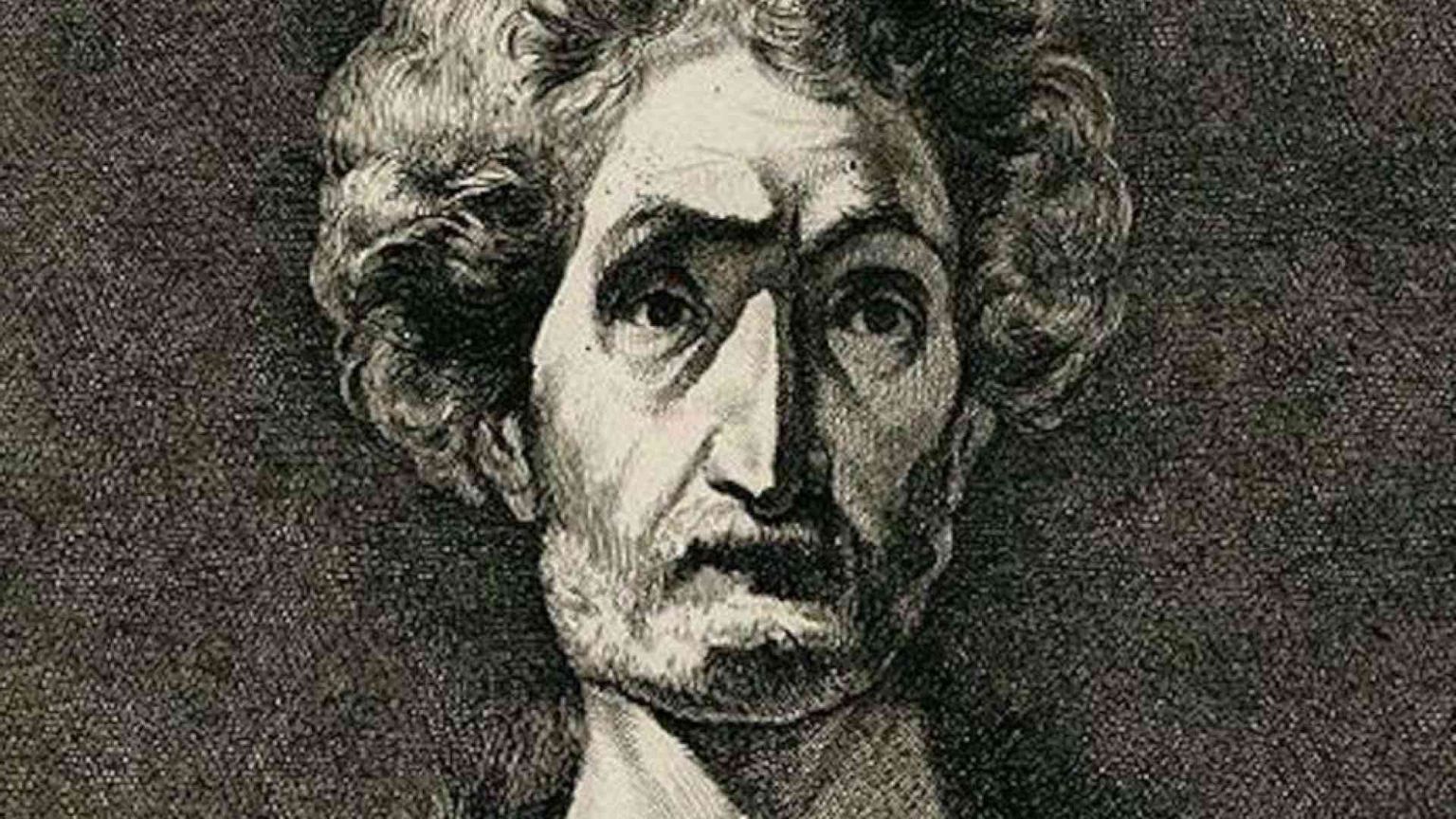
«La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto», così appare Ugolino della Gherardesca, ad apertura del canto XXXIII dell'Inferno: intento a conficcare i denti nel capo del vescovo di Pisa Ruggieri degli Ubaldini, nel «fiero pasto» di vendetta che subito riprenderà dopo aver narrato la propria storia a Dante: «Quand’ebbe detto ciò, con li occhi torti / riprese ’l teschio misero co’ denti, / che furo a l’osso, come d’un can, forti» (vv. 76-78).
Ugolino (1210 - 1289), eminente personalità della Pisa del XIII secolo, fu nel 1288 arrestato e condannato per tradimento - è posto infatti da Dante nell’Antenora, ove sono puniti i traditori della patria - e rinchiuso con alcuni suoi figli e nipoti nella Torre della Muda, una torre della famiglia Gualandi, adibita, prima di allora, a ricovero delle aquile durante il periodo della muta. L’Ar-civescovo Ruggieri, nel 1289, chiude l’accesso alla torre («e io senti’ chiavar l’uscio di sotto / a l’orribile torre; ond’io guardai / nel viso a’ mie’ figliuol sanza far motto», vv. 46-48) nella quale Ugolino e la famiglia si spengono per fame.
Il racconto di Dante suscita un alto pathos per il vano invocar aiuto da parte dei figli e per l’offerta finale del sacrificio di se stessi pur di salvare il padre: «E disser: 'Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti /queste misere carni, e tu le spoglia» (vv. 6163). L’uno dopo l’altro muoiono di stenti: «Vid’io cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno» (vv. 71-75).
L’ultimo verso del dramma ha suscitato due opposte interpretazioni: i più antichi interpreti optano per la morte di Ugolino per sfinimento: sul dolore che lo teneva pur avvinghiato alla vista dei figli - «ahi dura terra, perché non t’apristi?» (v. 66) - prevale il lungo digiuno: «Quasi dica che ’l dolore il tenne vivo doi dì, ma poi per lo digiuno venne meno la sua vita» (Chiose cagliaritane, 1370); «cioè poscia il digiuno finì la vita mia, la quale conservava il dolore» (Francesco da Buti); «Poscia che così gli ebbi chiamati due dì, alla fine dell’ottavo dì il digiuno potè più ad uccidermi che il dolore a mantenermi in pianto: ond’io morii » (Guiniforto delli Bargigi, 1440).
Lunghissima la spiegazione di Cristoforo Landino, 1481, uno dei più autorevoli interpreti della Commedia, che convoca molte autorità mediche e filosofiche per controbattere alla nomea di Ugolino cannibale: «Il che el nostro Martino Novarese, al quale Idio accresca la prudentia et diminuisca l’arrogantia, interpreta che el digiuno potè più che ’l dolore, i che el desiderio del cibarsi vinse la pietà et amore paterno et sforzollo a pascersi della carne de’ figluoli; la qual sententia quanto sia absona lascierò al giudicio del lectore».
Martino Novarese è Martino Paolo Nibia detto il Nidobeato (Novara, inizi XV secolo - Parma, 31 luglio 1483), a sua volta editore, nel 1478, di un incunabolo della Commedia che ebbe grande successo e accreditò il mito di Ugolino antropofago. Sì che conclude il Landino: «Il perché quanto maggiore è il dolore tanto più sopporta l’huomo el digiuno et più vive sanza cibo. Le quali tutte cose note al poeta, distinxe la longitudine del digiuno secondo l’età et secondo el dolore. Et perché e figluoli erono nell’augumento dell’età prima gl’induce a morire, et tra quegli pone el primo, el più tenero d’età, et dipoi gl’altri secondo che erono più o meno provecti ne gl’anni. Et lui pone l’ultimo sì perché era nella consistentia dell’età, sì ancora perché era oppresso da maggior dolore. El primo induce morire el quarto giorno, gl’altri d’ora in ora insino al sexto; lui gli pianse dipoi due giorni, i. el sexto et el septimo; et nel septimo benchè el dolore condensando et constringendo gl’umori prohibissi la resolutione, il che prolungava la vita, nientedimeno la lungheza del digiuno potè più che la prohibitione del risolvere che procedea dal dolore».
Crudeltà e pietà s’intrecciano: il «fiero pasto» è contrappasso al digiuno mortale che Ruggieri aveva comminato a Ugolino; a un tempo appare, impotente e assoluto, un dolore che raccoglie tutto l’essere, come il «bacio di morte» dei mistici. La parola, ha osservato Borges, è qui evento: non ha bisogno di essere sostenuta che dalla straziata pronuncia: non sarà un caso che il primo Ugolino moderno sia quello di Vincenzo Galilei, in un «recitar cantando», in un verlöschend che prepara l’agonia rattenuta del «Remember me, remember me, but ah / Forget my fate » («ricordami, ricordami, ma dimentica il mio destino»), finale del "lamento" di Didone nel Dido and Aeneas di Henry Purcell (1689).
In un’alternanza impressionate di sublime e di ferino, segue, di pari intensità, l’apostrofe contro Pisa, la più violenta di tutta la Commedia: «Ahi Pisa, vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona, / poi che i vicini a te punir son lenti, // muovasi la Capraia e la Gorgona, / e faccian siepe ad Arno in su la foce, / sì ch’elli annieghi in te ogne persona!» ( Inf XXXIII, 79-84). Più cruda, anche, per quell’iperbolico invito alle isole di Gorgona e Capraia, che sono nel mar Tirreno a molte miglia da Pisa, di sradicarsi e convergere sì da far muro davanti alla foce dell’Arno il quale così non più defluisca ma cresca, esondi e sommerga tutta Pisa, rispetto alla precedente apostrofe a Firenze che inaugura il canto XXVI dell’Inferno: «Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande / che per mare e per terra batti l’ali, / e per lo ’nferno tuo nome si spande!» (vv. 1-3). Dante, come ha chiosato Papini, ritorna profeta dell’Antico Testamento, grumo di maledizione e d’amor ferito, com'egli lo definisce evocando un saggio di Jean Cassou: «Occorre amare [gli uomini] d’un amor ostile. Amarli, secondo i versi del poeta Czeslaw Milosz, "d’un amore logorato dalla pietà, dalla collera e dalla solitudine"» (G. Papini, Dante vivo, e J. Cassou, Grandeur et infamie de Tolstoï, Paris, Grasset, 1932).
Terzine eponime
«Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’io cascar li tre ad uno ad uno
tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno»
(Inferno XXXIII, 70-75)
© RIPRODUZIONE RISERVATA







